AL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI
CAVALIERE D. NICOLA SANTANGELO
CHE MAI NON RIMISE DAL SANTO AMORE
DI PATRIA
DI MAGNIFICI MONUMENTI
LA VOLLE DECORATA
E CONFORTANDO LE MENTI NAPOLITANE
AL BEN FARE
LE AGGIUNSE GLORIA NON PERITURA
COME A QUEI CHE DI TUTTI
EBBE MERITATO BENE
D. LUIGI TOSTI
MONACO DELLA BADIA CASSINESE
UN PICCOLO ARGOMENTO
DI GRANDISSIMA OSSERVANZA E GRATITUDINE
IN QUESTO LIBRO
OFFERIVA
Dedica della prima edizione di Napoli, 1836.
AVVISO AI LEGGITORI
Sembra che a quei monaci, cui fu dato dalla Provvidenza campare alla nequizia dei secoli barbari le opere dell’umano ingegno, sia commesso il nobile ufficio di renderle di pubblico diritto all’incremento delle umane conoscenze. L’odierno incivilimento, che vuole adempiuto un tanto ufficio specialmente da quei di Monte Cassino, come custodi di prestantissimo Archivio, muoverebbe giusta querela contro di questi se fra tanta dovizia letteraria, poltrendo nell’ignavia,non si avvisassero donare altrui qualche incognito scritto utile o alla mente o al cuore. Nè i Cassinesi obbliarono un sì santo dovere. Nello scorso secolo, per dire dei tempi men lontani dall’età nostra, il Gattola scriveva la Storia della Badia di Monte Cassino, ed il P. Federici quella degl’ Ipati di Gaeta; ed entrambi, producendo Bolle, Diplomi, ed altre memorie, tolsero queste all’obblio, e vennero sempre più ponendo in luce gli umani avvenimenti. Per opera del P. Fraja, prefetto dell’Archivio Cassinese, a dì nostri videro la luce dieci Sermoni di S. Agostino per la prima volta, e quegli meritò bene della repubblica letteraria. Lo sconvolgimento cui andò soggetta Europa, la voce di un secolo che grida la croce sulle congreghe monastiche, se sconfortò l’animo dei Cassinesi dalle imprese letterarie, non gli ebbe inviliti; e il talento di giovare altrui, di non rimanersi inutili membra della società, e la memoria di essere stati conservatori della Sapienza, li rende tuttora promulgatori di quella.
Anche i meno saputi delle cose italiane han Contezza dell’Archivio Cassinese, e della dovizia de’ manoscritti che in esso si conservano, e delle molte cose le quali incognite si rimangono, e che tornerebbe utile pubblicare. Fra i settecento Codici, o vergati per mano de’ monaci, o per loro cura raccolti, ve n’ha uno cartaceo del secolo XIV, nel quale leggesi il Volgarizzamento di Maestro Donato di Casentino del’opera di Messer Boccaccio, intitolata De Claris Mulieribus. Un indice a’ Capitoli, ed un brieve Prologo dello stesso Donato precede in questo Codice le Vite di Boccaccio. Di questo, e degli altri traduttori farò motto, seguendo quello che ne scrive l’Argelati ed il Villa, che all’opera di lui fece le note.
Il Bagli ed il Betussi tradussero le Vite delle Donne illustri e le Traduzioni di loro vennero a luce. Il primo la volle dedicata a Lucrezia, figliuola del magnifico signore Ridolpho dei Baglioni; e venne pubblicata per i tipi di Giovanni de Trino in Venezia nell’anno 1506, nel giorno 6 di marzo, edizione rarissima, della quale Maittair fa menzione.
La traduzione del secondo venne per la prima volta a luce in Venezia nell’anno 1547, dedicata all’Illustrissima signora Camilla Pallavicino, Marchesa di Cortemaggiore, e fu ristampata nella stessa città nel 1558: e finalmente il Giunti in Firenze riprodusse la traduzione del Betussi nel 1596 con le aggiunzioni del Serdonati, il quale raccontò delle Donne illustri, che dal tempo di Boccaccio fino a’ suoi giorni fiorirono; e questa edizione fu dedicata a Cristiana di Lorena, Gran Duchessa di Toscana. E ciò delle traduzioni conosciute per la stampa.
Di quelle poi che tuttora inedite si conservano negli archivj, due solo possono numerarsi: quella del Sassetti Fiorentino, esistente nella Biblioteca MediceoLaurenziana, e della quale parlano il Manni nella Storia del Decamerone, il P. Montfaucon ed il Negri ; e l’altra di M.° Donato da Casentino. Due codici di questa traduzione esistono nella Biblioteca Reale di Torino, dei quali il primo è scritto nel XIV secolo in un Codice papiraceo di bellissimi caratteri, ed adorno di aurei lavori; ed il secondo scritto anche in pergamena nel secolo XV.
Ma oltre a questi due codici citati dall’Argelati e dal Villa, ve n’ha uno nel famoso Archivio di Monte Cassino finora incognito, e pregevole più di quelli di Torino per l’aggiunzione del Protesto fatto per comandamento de’ S. di Firenze a’ Rettori, ed altri ufficj, che ministrano ragione, fatto per Francesco di Pagholo Vettori a dì 15 settembre 1455, e di due lettere, delle quali una è indiritta dal Gran Turco a Papa Nicolò V. e l’altra da questi al medesimo: la prima è volta dall’idioma arabico nel greco, dal greco in latino, e dal latino in volgare.
Va per altro ricco il Codice Torinese dell’Epistola del magnifico signore Astorre de’ Manfredi, mandata ad una splendida donna da lui sommamente amata, dalle carceri Fiorentine.
Questa lettera non si legge nel Codice Cassinese, e perciò ne vo’ riportarle il principio, che rinvenni nell’opera del Pasini. “Gentilissima, e valorosa donna nella cui somma virtù e bellezza io ho tutta la mia speranza collocata et in chui etiandio scolpito risiede l’abitacolo di tutti i miei amorosi desiri. Egle vulgare opinione che colpi della adversa fortuna abino forza co loro molesti, et pungenti strali di spegnere le cocenti fiamme di cupido, le quali secondo l’autorità de gentili fanno mossa dalla terza spera. Et nel umano spirito disposto a gentilezza fermano il segio della loro dolcissima residenza, ecc. ”
Sembra che questo Astorre sia stato della famiglia di que’ Manfredi, che tenevano la signoria di Faenza; e sia quel desso, che, militando sotto i comandi di Niccolò Piccinino, seguendo le parti di Filippo Maria Duca di Milano, fu sconfitto a Borgo San Sepolcro dai Fiorentini nel di 29 di giugno, 1440, fatto prigione, e cacciato nelle Stinche, o pubbliche carceri di Firenze con Sacramoro Visconti, Antonello della Torre, ed altri: e forse da quelle carceri scrisse questa lettera alla donna che amava. E parlando Astorre nella Epistola, dell’avversa fortuna, possiamo dire per congettura, aver voluto Astorre alludere all’avversità della fortuna nella giornata di Borgo S. Sepolcro, ed alla sua prigionia.
In un secolo, nel quale, la Dio mercè, son tornate le menti italiane alla purità del loro linguaggio bruttato e imbastardito da modi stranieri, quando non solo i corpi, ma le menti, e fino la favella doveva gemere sotto il giogo transalpino; crediamo far cosa utile alla patria prodacendo una scrittura, che, come nascosto tesoro di molte bellezze, in fatto di lingua va ricca. Anzi di modi eleganti abbonda, i quali si desiderano nello stesso Vocabolario della Crusca.
E perciò non credano i leggitori essere la traduzione di M° Donato uno di quegli scartabelli del Trecento, i quali pochissimo oro ti offrono e grande mondiglia; ma è fonte di peregrina venustà, del quale noi doniamo coloro, che all’italiana favella danno opera, e della purità di questa sono teneri.
Speriamo che i leggitori non vorranno incolparci di troppo ardimento se la vieta ortografia del Codice sia stata a moderna foggia ridotta in guisa che nelle parole e nel senso non siavi cangiamento di sorta. E poichè nel nostro esemplare non avvi segno veruno che divida i periodi e l’un senso dall’altro, a questa mancanza supplimmo non secondo ne talentava, ma secondo il testo latino del Boccaccio lo richiedeva.
Solleciti che il nostro Codice venga in luce in tutta sua interezza, que’ passi oscuri che non davano senso, forse per colpa di chi lo scrisse, noi emendammo, ponendoli al confronto coll’opera latina del Boccaccio e colla traduzione del Betussi; riportando per altro a piè di pagina le parole o i luoghi guasti, tali quali si leggono nel Codice. In oltre essendo scemo il nostro Codice del Proemio che Boccaccio premise all’opera sua, abbiamo riprodotto quello volgarizzato dal Betussi, e così a tutti verrà aperta la mente dell’autore di queste Vite.
Facciano buon viso i leggitori a questo nostro lavoro impreso per la utilità di loro, e per chiarire altrui non rimettere i Cassinesi dalla operosità negli studj, memori della gloria che fruttò al nostro paese la sapienza degli antichi Monaci di Monte Cassino.
MEMORIE STORICHE
SU LA VITA
DI M°. DONATO DA CASENTINO.
dell’editore
Forse alcuno si maraviglierà, aver io trapassato con silenzio nel brieve Avviso ai leggitori della persona di Maestro Donato da Casentino autore di questo pregevole libro, e forse in suo pensiero mi avrà dato dell’infingardo o dell’ignorante. Ma se io tacqui della vita di lui, fu desiderio di offerire in separato discorso quello cbe mi venisse fatto rinvenire in altri libri della Vita e delle Opere di Mastro Donato. Ed ecco di mie fatiche, se piccolo, non inutile frutto.
Correva il secolo decimoquarto: e sebbene questa povera terra d’Italia fosse tribolata di discordia, mondata di sangue cittadino per le svariate dominazioni che ne facevano or felice, ora sciagurato governo, pur tuttavia forse non vi fu mai tempo nel quale gl’ingegni italiani fruttassero maggior gloria nelle lettere alla patria di loro. La divina mente dell’Alighieri co’ suoi Canti aveva scossi gli animi trascorsi in miseranda ferocia e presi da lagrimevole talento di parteggiare, e li chiamava a più nobile scopo di gloria; e direi quasi, creando la italiana favella, prestò il mezzo primiero alla manifestazione di una virtù, che nei petti italiani avevano assopita e non morta le umane vicissitudini, le politiche condizioni del paese. Il cenere di Dante era caldo: e, come da scintille da quello destate, si crearono le menti di Petrarca, di Boccaccio, e di altri che fecero più illustre la terra che gli ebbe prodotti: questi furono ammirati nelle corti; e la sapienza di loro consigliava i principi a farla germogliare nelle menti dei sudditi. Si fondavano università e pubbliche scuole di eloquenza e di gramatica, ed al nobile ufficio di sedervi ed insegnarvi erano deputati uomini valentissimi. Fra la schiera dei gramatici e de’ retori del secolo XIV, levò fama più splendida di sè Donato da Casentino, e per le opere che lo predicano maestro di forbita favella, e per l’amicizia che l’ebbe dolcemente unito a Petrarca, a Boccaccio, e ad altri Mastri letterati.
Fu maestro Donato dal Petrarca quasi sempre nominato Appenninigena, e dall’abate Mehus gli vien dato anche il nome di Albanzani. Se la prima denominazione viene dall’avere avuto nascimento Donato appresso gli Appennini, ove si giace la provincia del Casentino, non possiamo dire col Tiraboschi, avere il Mehus senz’argomenti data la seconda a Donato, poichè quegli noverando i nomi di coloro cui indirizzò sue lettere Coluccio Salutato, dà il casato di Albanzani a Donato, avendo così letto nei codici in cui erano scritte le lettere di Coluccio. Certamente Donato ebbe nascimento in Pratovecchio, luogo del Casentino, poichè Petrarca parlando di lui nel suo testamento, dice: Magistro Donato de Prato veteri: ma non è facile cosa rinvenire in quale anno egli nascesse. Vero è che dalle seguenti parole nella lettera che Petrarca gli volle indiritta per temperare l’acerbo dolore di che fu commosso per la morte di un suo figliuolo nomato Solone, chiaro si addimostra, non esser nato Donato prima del 1330. Augustus pronepotuli sui, hac Aetate qua filius tuus erat extincti imaginem in cubiculo suo censecratam posuisse traditur. Moriva Solone nell’anno 1368, nel quale Petrarca lo consolava con questa lettera, ed essendo vissuto diciotto anni come il nipote di Augusto, venne al mondo nel 1350, e perciò Donato, avendolo generato nell’età almeno di venti anni, potè nascere verso l’anno 1336. Dall’essere Donato uomo onorando per sapere, veniva il desiderio che aveano di sua amicizia, e lo studio col quale la coltivavano i più famosi personaggi di quel secolo. Imperocchè, povero come egli era, al dir di Boccaccio, non ancora entrato nella corte di Ferrara, nè per ricchezze nè per favore che avesse goduto appresso i grandi, poteva eccitare in altri desiderio di sè. Se ebbe amico Petrarca, Boccaccio, Salutato Coluccio ed altri; questi lo amarono e l’onorarono, perchè chiaro per sapere, commendevole per probità. E specialmente quel Salutato Coluccio che ebbe fama splendidissima di valente scrittore, segretario di papa Urbano V e di Gregorio XI, e segretario della Signoria di Firenze sua patria, gli scritti del quale erano sì potenti, che Gio. Galeazzo, duca di Milano, guerreggiando contro Firenze, diceva a sè tornare più nocivi gli scritti di Coluccio, che le armi di quella, tanta estimazione concepì di Donato, che dell’amicizia sua era bramosissimo come di quella di principe potente. L’abate Mehus novera quattro lettere scritte da Coluccio a Donato, in una delle quali a questi dà contezza, aver ricevuto un suo libretto, e gliene riferisce grazie: lo stesso Mehus congettura essere questo libro il Volgarizzamento delle Donne Illustri, congettura che a me non sembra improbabile, poichè il libro veniva di Ferrara ove Donato scrisse quella traduzione.
Fra le città italiane, Venezia era pur decorata di cospicua università: in essa venne chiamato Donato, perchè vi sedesse maestro di gramatica. Della qual cosa ne chiarisco Petrarca, il quale nel suo testamento dice: Sciogliere Donato da Pratovecchio, in quel tempo precettore di gramatica in Venezia, di qualunque debito, se mai gli avesse data cosa ad imprestito, perchè non fosse tenuto verso il suo erede a restituzione di sorte. Ma quale fu l’anno nel quale Donato andasse in Venezia, non si addimostra chiaramente. Certo è che nell’anno 1363, imperversando la peste in Italia, e per moria desolate le più popolose città; Petrarca invitava Boccaccio a ricoverare in Venezia; e perchè quell’invito lo allettasse, dicevagli: Sè avere stanza comune con Donato, il quale, abbandonati i colli Toscani, da più anni abitava le spiagge dell’Adriatico; e perciò il tempo della venuta di Donato in Venezia è da assegnarsi non poco prima del 1363.
Mentre in questa città viveasi Donato dando opera alla pubblica istruzione, ricevette non poche lettere dal Petrarca, nelle quali questi in certa guisa stemprava tutto il cuor suo; e torna grato leggerle, per conoscere di quanto amore si amassero que’ due valenti letterati. Fra le altre è bellissimo argomento di loro amicizia quella che Petrarca gli scrisse per confortarlo dopo la morte del suo figlio Solone: la quale sciagura fu poi seguita dalla perdita dell’unico figliuolo che rimaneagli, Antonio. E se nella prima amarezza del cuor suo ebbe a confortatore Petrarca, nella seconda ebbe Coluccio, che lo volle consolato di una lettera: ed in questa lo chiede di sua amicizia, e lo fa consapevole di suo grandissimo desiderio di usar con per mezzo di lettere, perchè udivalo in predicamento di uomo sapientissimo. La lettera poi del Petrarca a Donato, nella quale lo esorta a cessare dai doni, poichè Donato non inviavagli messo con lettere, che non avesse le mani piene di qualche donativo, se mostra l’animo di Petrarca tenero del proprio onore, non volendo comparire amico venale, ci addimostra il cuore di Donato formato a cortesia e ad affezione.
Vediamo ora il frutto delle lezioni di Donato nelle scuole di Venezia. La storia non ne ha lasciato ricordanza de’ suoi discepoli che del loro sapere onorarono la persona di Donato. Solo Giovanni Malpaghino da Ravenna a buon diritto forma l’elogio del precettore di lui, Donato. Fu quegli ristoratore dall’antica lingua del Lazio: Coluccio Salutato lo predica in una lettera, qual uomo maraviglioso per copia di sapere, per maestà e forza di stile, e lui ammira quale scrittore, scevro di que’ vizi dei quali gli altri andavano bruttati. Giovanni nella prima età mosse di Ravenna in Venezia, e fu discepolo di Donato Appenninigena: e sebbene quegli avesse avuto a maestro anche il Petrarca, pure a Donato si spetta la gloria di averlo prima quasi a mano condotto nel santuario delle Lettere. Infatti il Petrarca, che pure doveva andar superbo di aver avuto a discepolo Giovanni da Ravenna, non negò a Donato da Casentino il merito di essere stato il primo a coltivare l’ingegno di quel chiaro retore, ad informarne i costumi, a favorirne le indicazioni agli studj. Anzi Donato, poichè istruì nelle lettere Giovanni, provvide al perfezionamento dell’ingegno, ed alla gloria di lui, chiamandolo a parte dell’amicizia che godeva di Petrarca; sì che poi quegli, usando familiarmente col Cantore di Laura, e prestandogli mano ne’ travagli di Lettere, tolse grandissima utilità, e venne in fama di retore eloquentissimo. Ed in vero scrivendo Petrarca a Giovanni Malpaghino, che tuttora avea stanza in Venezia, quasi non sa esprimere sua gratitudine per Donato, perchè gli avea fatto dono dell’amicizia di lui. La fama, di Donato spiegava ampio volo per l’Italia sì che fu chiamato in Ferrara alla istruzione di Niccolò d’Este, che fu poi Signore di quelle città. Sul tempo della sua andata in Ferrara, non assistito dalla Storia, non posso se non formare congettura, che forse darà nel vero.
Napoli, Bologna, Padova ed altre città italiane, nel secolo XIV avevano le loro università, e Ferrara sebbene aprisse in sua corte orrevole stanca ai letterati, pur tuttavia si rimaneva priva dell’utile che quelle arrecar sogliono all’incivilimento de’ popoli. Il secolo era in sul finire, quando nel 1361 ad Alberto Marchese di Ferrara cadde in animo il nobile divisamento di fondare una università, ottenutane licenza da papa Bonifazio IX: e chiamò in Ferrara Bartolomeo di Saliceto, Giliolo da Cremona, ed altri valentissimi personaggi. Se nella Cronaca Estense pubblicata dal Muratori non vi è nominato Donato, forse questi sarà uno di quelli celati nelle parole aliosque in reliquis facultatibus valentissimos. Ed al certo se fu aggregato al collegio de’ Professori, potè il Marchese Alberto chiarirsi di propria esperienza non solamente del sapere, ma anche della probità di quegli che destinò alla istruzione del suo figlio Niccolò. Nè possiamo fissare un tempo anteriore al 1361, nel quale siasi recato in Ferrara Donato per istruir Niccolò, poichè questi in quell’anno era appena nel settimo anno di sua vita; ed in una più tenera età sarebbe stata inutile cosa affidarlo alle cure di sì scienziato precettore.
Nel 1393 moriva il Marchese Alberto, e lasciava la signoria a Niccolò suo figliuolo che era di nove anni. Dopo che questi tenne le redini del governo di Ferrara per quattro anni, Francesco II di Carrara, signore di Padova, cavalcò per Ferrara con quattrocento uomini d’arme e cento soldati, tolse di carica tutti quelli che formavano il consiglio di Ferrara, ed il Marchese Niccolò III, scegliendo altri a quegl’impieghi, elesse cancelliere il suo maestro Donato. Coluccio Salutato, che gli fu confortatore dopo la morte del suo figlio Antonio, non lasciò congratularsi secolui in una lettera citata dal Mehus, pel suo innalzamento a quel grado: ed in quella esprime chiaramente, essere venuto Donato dalla scuola di gramatica alla istruzione di Niccolò III, ed in età provetta innalzato alla carica di cancelliere.
Mentre Donato dimorava nella corte di Ferrara, scrisse pel Marchese Niccolò suo discepolo il Volgarizzamento dell’opera latina di Boccaccio De Claris Mulieribus. Ecco quel che leggesi intorno a ciò alla fine del Codice di Donato esistente in Torino: Finito libro de famose donne compilado per messer Zuane Boccaccio ad petition della famosissima Reina Zuana de Puglia. Poi traslatado in idioma volgar per maestro Donato di Casentino al magnifico Marchese Niccolò d’Este principe e signor di Ferrara. È probabile, avere scritto Donato questo Volgarizzamento nel 1397, quando Niccolò menò sposa la figliuola di Francesco II di Carrara, signor di Padova, forse per far cosa grata alla novella Marchesana, risguardante il libro delle Donne che erano venute in celebrità. Ma questa è congettura, e non fondasi sopra argomenti validi.
Il Tiraboschi produce la opinione del P. degli Agostini, il quale si avvisa Donato avere anche traslatato in volgare le Vite degli Uomini illustri di Petrarca, fatte scrivere per comandamento di Francesco detto il Vecchio, signor di Padova, e continuate per Lombardo di Serico: ed il suo avviso si poggia sull’autorità di un codice a penna conservato presso i PP. Riformati di Trevigi. Ma alla opinione del P. degli Agostini io non voglio tener dietro, imperocchè di questa traduzione Petrarca non fa motto nelle sue Lettere a Donato: e pure questo era un lavoro che doveva calere al Petrarca, perchè fatto dal suo amico dolcissimo, e perchè risguardava l’opera sua,
Jacopo Delayto, il Cronista Estense, parla dell’innalzamento di Donato all’ufficio di cancelliere, ma non della morte di lui: non facendone altri parola, n’è incerto il tempo.
Tanto ho potuto raccorre sulla Vita di questo illustre Grammatico, e perciò fo fine al mio discorso, dicendo: Donato aver avuto nascimento in Prato Vecchio nel Casentino circa l’anno 1330; essere stato professore di gramatica in Venezia, maestro del Marchese di Ferrara Nicolò III, cancelliere di quella Signoria; essere stato padre di due figli Solone ed Antonio, ed esser morto in età avanzata.
PROEMIO
DI M. BOCCACCIO AI LETTORI
VOLGARIZZATO DAL BETUSSI
Scrissero già molto tempo alcuni antichi brevemente libri degli uomini illustri e al presente con più acuto stile, e più ampiamente il famoso uomo, e eccellente poeta Francesco Petrarca precettar nostro, degnamente ne fa un volume, perchè veramente quelli che posero ogni diligenza, le sostanze, il sangue, e l’anima secondo i bisogni per preceder gli altri con opere virtuose hanno meritato che i nomi loro siano di perpetuo ricordo ai successori. Ma mi son maravigliato molto, così poco appresso questi tali uomini aver potuto le donne, che non abbiano conseguito alcuna grazia di memoria in nessuna particolar descrizione; reggendosi chiaramente per amplissime istorie, molte così valorosamente, come fortemente essersi portate. E se sono da innalzar gli uomini, mentre datagli natural fortezza hanno oprate, degne cose, quanto maggiormente le donne, quali a tutte le quali dalla natura è data una delicatezza, il corpo debile, e l’ingegno tardo, se acquistano un animo generoso, un ingegno acuto, e con notabil virtù ardiscano ed eseguiscano cose difficili, e quasi impossibili, meritano d’essere avute in pregio? Onde, acciocchè non sieno ingannate nel suo merito, m’è venuto in animo di quelle che si può ricordare, fare in onor loro una memoria, e ridurle insieme, a queste, aggiungendo di molte alcune, che o l’ardire, o le forze, e industria dell’ingegno, o il dono di natura, ovvero la grazia di fortuna, o l’ingiuria ha fatto notabili, non lasciando addietro alcuna, che, sebbene non ha fatta cosa veruna degna di memoria, nondimeno ha date grandissime occasioni, ch’altri mercè sua, abbia operato azioni notabili e degne di ricordo. Nè voglio a chi leggerà paia inconveniente, se ritroverà con Penelope, Lucrezia e Sulpizia pudicissime donne, Medea, Flora, Sempronia, ch’ebbero grandissimo, ma scelleratissimo ingegno. Imperocchè, non è di mia intenzione pigliare questo nome di nobile, e illustre così stretto, che sempre paia riuscire in virtù, anzi in più ampio sentimento, con buona pace dei lettori, ritirarlo: intendendo illustri quelle, che per ogni loro fatto palese al mondo conoscerò chiarissime e palesi; ricordandomi, l’aver letto spesse volte tra i Leonidi, gli Scipioni, i Catoni, i Fabricj uomini illustri, i sediziosissimi Gracchi, l’astuto Annibale, il traditor Giugurta, i sanguigni di civil sangue Silla e Mario, il ricco e avaro Crasso, e altri tali. Oltre che quando avessi innalzato con lodi le degne di memoria, e abbassato con riprensioni le vergognose, sarebbe non solamente stata non poca gloria alle generose, e anche non piccola infamia alle scellerate; ma avrebbe paruto, ch’io poco mi fossi dilungato dai termini comuni, e che piuttosto avessi voluto rinnovar quelle cose, che per lunghezza, e difetto al tempo paiano essere mancate. Mi sono immaginato anco alle volte tra l’istorie includervi alcuni amorevoli esempi, ed esortazioni virtuose, aggiungendovi al rincontro acuti stimoli per fuggire e schivare le scelleratezze; perchè congiungendo la dilettazione coll’istorie, ne cavano utilità gl’intelletti. E acciocchè secondo l’usanza antica non paia ch’io abbia solamente toccato i principj delle materie che averò conosciuto dipendere d’autori degni di fede; le ho ridotte in più ampia e lunga istoria, istimando non pur utile, ma necessario. Proprio di queste dover piacere non meno agli uomini, che alle donne, quali come per lo più sono mal pratiche dell’istorie, così anco hanno maggior bisogno, e s’allegrano più d’un parlar copioso. Parrà anco, che io mi sia forse scordato, eccetto Eva, prima madre di tutti, quasi tra tutte queste Gentili non vi aver posto nessuna Ebrea e Cristiana. Ma sono restato, perchè non m’è paruto, che non molto si convengano insieme, nè che di pari abbiano desiderato giugnere all’istesso segno. Perciocchè quelle veramente per la vera e eterna gloria si sono sforzate spessissime volte vincere loro medesime contro l’avversità, e miserie umane, imitando i sacri e santi comandamenti, laddove queste, o per un certo dono di natura, o piuttosto mosse da desio di così subitano splendore, non senza però gran fortezza di mente sono a nome d’eternità pervenute, sopportando molte volte grandissime disgrazie e infiniti assalti di fortuna. Oltre di ciò quelle non solamente vivono chiarissime e risplendenti d’una vera e eterna luce di dovuta eternità, ma la loro virginità, castità, santità e virtù, così in vincere la concupiscenza della carne, come i tormenti dei tiranni, e invitta loro costanza conoscemo essere stata descritta in più d’un volume da molti santi uomini nelle sacre lettere dottissimi, e non poco onorati. E però nessuno dei menti di quelle, come è stato, scritto da altri, non abbiamo voluto paragonare con queste, essendo di gran lunga maggiore delle presenti, che ora mi sforzo di scrivere per darle alcun premio: alla qual opra pia Iddio, padre del tutto, sia presente, e porga favore a ciò che io sono, per scrivere, concedendomi che abbia scritto in sua vera lode.
VOLGARIZZAMENTO DI MAESTRO DONATO DA CASENTINO DELL’OPERA INTITOLATA
DE CLARIS MULIERIBUS DI M. BOCCACCIO
PROLOGO
Incomincia il Libro delle famose Donne, compilato per lo illustrissimo uomo M. Boccaccio, poeta fiorentino, a petizione della famosissima reina Giovanna di Puglia, traslatato di latino in volgare da M.° Donato da Casentino.
CAPITOLO I.
d’Eva.
Dovendo io scrivere per che virtù sono conosciute le famose donne, non parrà cosa indegna di pigliare lo cominciamento da chi fu madre di tutti gli uomini, Eva. La quale fu, senza dubbio, la prima madre, e fu gloriosa di magnifiche virtudi; perchè ella non fu prodotta in questa faticosa valle di miserie, nella quale tutti noi altri uomini nasciamo a fatica, nè fu fabbricata con quello martello, nè con quella incudine che sono le altre in questa vita, nella quale ella non venne debole piangendo lo peccato di sua natura, come vengono gli altri. Ma avendo l’ottimo Fattore di tutte le cose formato Adamo colla propria mano del fango della terra, la qual cosa non avvenne d’alcun altro poi, e avendolo posto nel Giardino dei diletti, il quale fu chiamato poi Campo Damasceno, e avendo fatto addormentare quello d’un piacevole sonno; per artificio conosciuto da lui solamente trasse quella dal fianco di quello dormente compiuta, ed era di compagnia di marito, allegra per la vista del dilettevole luogo, e fecela immortale donna di tutte le cose a compagnia dell’uomo, che già era desto, e da quello eziandio fu chiamata Eva. E che maggior cosa, o più gloriosa potè mai avvenire ad alcuno in sua natività? Ancora possiamo pensare quella maravigliosa per la bellezza del corpo; perchè non è fatta niuna cosa per la mano di Dio, che non avanzi l’altre in bellezza. E benchè questa bellezza perisca per la vecchiezza, e ancora ella caggia per piccola mutazione d’infermitade col mezzo del fiore di nostra etade; nondimeno perchè le donne la noverano tra le loro virtudi, perchè ne hanno gran nominanza, indiscretamente per lo giudizio degli uomini, non ho posto questa d’avanzo tra le cose che fanno famose quelle, procedendo la prova in questo libro. E sopra queste cose quella che fu fatta del Paradiso reina per ragione di sua creazione e di sua abitazione, fu vestita di uno splendore non conosciuto da noi, infino a che ella volentieri usasse col suo marito i diletti di quel luogo. Ma lo nimico, invidioso di sua felicità, era maligno conforto le mise nell’animo che ella poteva arrivare a maggior gloria, se ella facesse contro una legge sola, che l’era imposta da Dio. Al quale per una leggerezza di femmina credendo, più che non abbisognava a lei ed a noi, e pensando mattamente montare a più alte cose, innanzi che facesse altro, con lusinghevole conforto trasse a sua volontà lo debole marito. E facendo contro alla legge con presuntuoso ardire, mangiato del pomo dell’albero, per lo quale si conosce lo bene e lo male, condussero sè e tutta sua schiatta per lo tempo che dovea seguire, di dilettevole patria d’eterno riposo in inansiosa fatica, e miseria, e morte, tra gli spini, e le zolle, e le pietre. E già essendo fuggita la splendida luce, della quale egli erano vestiti, furono ripresi dal loro turbato Creatore, e, vestiti di foglie d’alberi, dal luogo dei diletti vennero bandeggiati nei campi di Ebron. In quel luogo la nobile donna, e famosa per le predette cose, secondo che è creduto da molti, trovò filare alla rocca. E avendo più volte provato il dolore del parto, e quelli i quali tormentano l’animo colla morte dei figliuoli e dei nipoti, non dico il freddo, il caldo, e altre cose, stanca delle fatiche arrivò alla vecchiezza innanzi che ella morisse.
CAPITOLO II.
Semiramis Reina degli Assirj
Semiramis gloriosa reina degli Assirj di che padre nascesse la vecchiezza del tempo ce l’ha tolto. Vero è, come agli antichi autori piace per favola, che essa fosse figliuola di Nettuno, il quale affermano, per errore credendo, essere figliuola di Saturno e Dio del mare. La qual cosa, benchè non sia convenevole a crederla, nondimeno è argomento, quella essere nata di nobili parenti. E questa certamente fu moglie di Nino, nobile re degli Assirj, e di quella generò Nino solo figliuolo. E avendo Nino soggiogata tutta l’Assiria e ultimamente i Battriani, morì d’una ferita d’una saetta. E essendo morto, quella giovinetta, e il suo figliuolo essendo fanciullo, temendo commettere il reggimento di sì gran regno, e cominciata signoria a sì tenera età, fu di sì grande animo, che ardì quella femmina pigliare con arte e ingegno la nazione, la quale l’uomo aspro avea soggiogata con le armi e signoreggiata con la forza. E con alcun’astuzia di femmina avendo pensato lo grande [inganno] ingannò l’oste dei Cavalieri del marito che era morto. E non fu maraviglia, perchè Semiramis e il figliuolo erano simiglievoli delle membra, e nella faccia: l’una e l’altro senza barba, e la voce del fanciullo non era dissimiglievole da quella di una femmina, e per la statura poco o niente differente dal figliuolo. Le quali cose ajutando quella, acciocchè in processo di tempo non si scoprisse l’inganno, portava coperto il capo di una berretta, le braccia e le gambe portava coperte. E perchè fino a quel tempo non era usanza che gli Assirj andassino sì vestiti, acciocchè la novità dell’abito non desse ammirazione a quelli del paese, determinò che tutto il popolo portasse simile abito. E così quella, che era stata innanzi moglie, mostrava lo giovine per la madre; e con maravigliosa diligenza, avendo presa la maestà del Re, servò quella e lo magisterio della milizia. E mettendosi essere uomo, adoperò molte grandi cose, nobili per fortissimi uomini. E poichè non risparmiavasi di alcuna fatica, non impaurita d’alcuno pericolo, soperchiò l’invidia di non uditi fatti di ciascuni uomini; non temè manifestarsi ad ogni uomo chi ella fusse acciocchè ella non mostrasse, sè avere usato inganno di femmina, quasi come ella volesse mostrare, che alla signoria bisogna d’avere animo e non essere maschio. La qual cosa quanto diede d’ammirazione a quelli che la videro, tanto ampiò la gloriosa maestà di quella donna. Acciocchè noi leviamo i suoi fatti più alti palesamente, dappoi la maravigliosa trasmutazione, da uomo, prese le armi: non solamente difese l’imperio che il suo marito aveva acquistato, ma aggiunse a quello l’Etiopia assalita da lei, e vinta con Aspra guerra: e di poi convertì contro a quelli d’India le forti arme, ai quali fino a quel tempo non era andato alcuno se non suo marito. E sopra questo, riparò Babilonia, antichissimo edificio di Nembrotto, città in quei tempi nei campi di Sennaar, e circondolla di mura fabbricate di pietre cotte e di pegola, alte, e grosse di maraviglioso circuito E acciocchè delle molte cose fatte da lei, d’una solamente faccia memoria, dicesi che certissima cosa fu, che avendo ella messa ogni cosa in quiete, e standosi in riposo, un dì facendosi pettinare dalle sue donzelle secondo l’usanza delle donne, e secondo l’usanza del paese facendosi fare le treccie, non avendo ancora pettinata se non mezzi cappelli, avvenne che le fu annunziato, che Babilonia era ribellata, e venuta in signoria di un suo figliastro. La qual cosa ella portò sì molestamente, che gittò via il pettine, subito lasciato l’esercizio di femmina, levossi irata, e prese l’armi, e subito assediò quella fortissima città. E non restò di cessare quei cittadini che restavano, in fin che dopo lungo assedio ridusse quella potentissima città a sua signoria per forza d’arme, istanca per lungo assedio. Del quale sì animoso fatto fece testimonianza per lungo spazio una statua di metallo posta diritta in Babilonia, la quale era una donna che a veva mezzi capelli sciolti e sparti, e mezzi ritorti in una treccia. Ancora ella edificò molte città di nuovo, e fece di grandissimi fatti, i quali la vecchiezza ha sì consumati, che non ne sono pervenuti, infino al nostro tempo alcuni, se non quasi questi che io ho detto. Poi finalmente questa donna cominciò a scellerato peccato: bruttò tutte queste cose, di perpetua memoria lodevoli, non che in una femmina, ma eziandio in ciascuno forte uomo maravigliose cose. Perchè essendo ella stimolata, come le altre, di peccato carnale, fu creduto che ella peccasse con molti, e tra gli altri con chi ella peccò fu Nino suo figliuolo, benchè questo fusse cosa piuttosto bestiale che umana: e quel giovine di eccellentissima bellezza, quasi come se egli avesse mutato di esser femmina, ed ella maschio, marcivasi nelle camere in ozio; dove ella s’affaticava in arme contro a’ nemici. O che scellerato fatto è questo, che questa pestilenzia devitevole, non dico quando le cose sono quiete, ma tra i faticosi pensieri del Re, e le sanguinose battaglie; e che è fuori di natura! Tra gli pianti e gli esilj, non facendo alcuna distinzione di tempi, piglia e conduce in pericolo la mente di quelli che non sono caduti, e macchia ogni onore di vituperosa infamia. Della quale bruttura Semiramide pensando ammorzare colla sagacità quella fama che lasciva avea bruttata, dicesi che ella fece quella vituperosa legge, per la quale era conceduto ai suoi soggetti, che nei fatti di lussuria egli facessero come gli paresse. E temendo di essere ingannata dalle donne di casa, ella prima, secondo che alcuni hanno detto, trovò l’usanza delle mutande, e quella faceva usare alle sue femmine, serrandole con chiavi; la quale cosa ancora si osserva nelle parti d’Egitto e d’Africa. Alcuni altri hanno scritto che essendo ella innamorata del figliuolo, e quello essendo di compiuta età, volendo ritrattare il peccato, ella l’uccise, avendo ella regnato anni ventidue. Ma alcuni altri si discordano dagli altri, e da questi: e dicono che, come ella aveva commesso l’adulterio con alcuno, incontanente lo faceva uccidere, acciocchè il peccato stesse celato. E dicono che essendo ella alcuna volta ingravidata, per lo parto si manifestava, e per essere scusata, dicono che ella fece quella legge, della quale poco d’avanti fu fatta memoria. E benchè paresse alquanto tenere coperto lo disconcio peccato del figliuolo, non potè tor via la indegna azione di quello, perchè mosso a ira uccise quella scellerata reina; o perchè egli vedesse lo suo peccato comune con molti altri, e per questo lo portasse meno pazientemente; o che egli giudicasse sua vergogna la disonestà della madre; o forse perchè temeva che nascesse figliuolo a sospezione dell’impero.
CAPITOLO III.
Opis moglie di Saturno.
Opis ovvero Rea, se noi diamo fede agli antichi, fu famosa tra molte cose prospere, e tra molte avverse. Perchè la fu figliuola di Uranio, potentissimo de’ rozzi Greci, e di Vesta sua moglie la quale, similmente sorella e moglie di Saturno Re non era famosa per niuna opera che fusse pervenuta a noi, se non che per iscaltrimento di femmina ella liberò Giove, Nettuno e Plutone dalla morte, patteggiata da Titano con Saturno. Li quali, essendo uomini, arrivarono a fama di Dei per la ignoranza degli uomini di quella etade. E questa non solamente acquistò onore di Reina, anzi per errore degli uomini fu riputata maravigliosa Dea, e madre degli Dei: e a lei per pubblici ordinamenti furono diterminati templi, sacerdoti e sacrificj. E in tanto crebbe questo vituperoso male, che essendo in fatica i Romani nella seconda guerra degli Africani, quasi per salutevole aiutorio, mandarono ambasciadori di loro dei consoli ad Attalo re di Pergamo a domandare la statua di quella con grandissimi prieghi, e l’ordine dei sacrificj. E fu tolto da Pesinunte terra d’Asia un sasso quasi mal formato; e portato in Roma con diligenzia; e finalmente allogato in un maraviglioso tempio, come somma Deità: e per molti secoli per salute della Repubblica fu onorato appresso ai Romani e per Italia, per molti sagrificj. E fu certamente mirabile giuoco della fortuna, ovvero piuttosto della cecità degli uomini, o vogliamo dire inganno, o decozione dei dimonj, per opera de’ quali avvenne, che una donna sbattuta di molte fatiche, finalmente invecchiata, morta, e convertita in polvere, dannata appresso quelli dell’inferno, sia creduto, esser Dea, e per sì lunga età sia onorata con divine esequie quasi da tutto il mondo.
CAPITOLO IV.
Giunone Reina dei regni, e moglie di Giove.
Giunone Reina dei regni, figliuola di Saturno e d’Opi, fu famosa per tutto il mondo innanzi a tutte l’altre femmine famose per lo nome dei Gentili, per la scritture dei poeti, e per Terrore degli antichi intanto che i sordi denti del tempo non possono aver roso così infame opera, benchè eglino rodano tutte la cose, sì che lo suo nome non sia pervenuto famosissimo insiuo alla nostra età. E certamente di questa possiamo piuttosto recitare la nobile fortuna, che contare alcuna nobile sua opera. Ella nacque d’un parto con quello Giove di Creta, il quale, gli antichi poeti ingannati, finsero Dio del Cielo: ed in sua puerizia fu mandata a Samo; in quel luogo fu nutricata con dilegenza fino a che fa da marito e finalmente fu data per moglie a Giove suo fratello: la qual cosa ha affermato per molti secoli una statua di quella a Samo, posta nel tempio. E pensando quelli che molto spetti a sua gloria, ed alla gloria dei suoi discendenti, che Giunone, la quale pensano, essere reina del Cielo e Dea, sia stata sposata appresso di quelli; acciocchè la memoria di questo non perisse levemente, edificarono un tempio grande maraviglioso innanzi agli altri, e consegraronlo alla sua Dea: e ferono intagliare la sua immagine d’un candido marmo in abito d’una fanciulla che fusse sposata, e feronla mettere innanzi al suo tempio. Questa, finalmente maritata a quel gran Re, crescendo continuo la sua signoria, e la fama per lungo e per traverso portando lo suo nome, acquistò molta chiarezza. E poi per le finzioni dei poeti, e per la furiosa libertà degli antichi fu fatta reina del Cielo; e ancora fu commessa in lei la ragione dei matrimoni, e gli aiutorj di quelle che partoriscono, e molte più altre cose, piuttosto da farsene beffe che da ricordarle. E così per conforto del nimico dell’umana generazione le ferono edificare molti tempj per ogni parte, e molti altari; e furonvi deputati giuochi, sacerdoti e sacrificj, secondo, antica usanza. E tacendo degli altri, dappoi Samo fu onorata lungo tempo con famosa reverenzia da quelli d’Argo, popoli d’Acaja, e dai Cartaginesi: e finalmente portata a Roma fu allogata in Campidoglio nella cella dell’ottimo e sommo Giove, non altrimenti congiunta al suo marito, e sotto il vocabolo di Giunone reina fa onorata da’ Romani signori del mondo lungamente con molte ceremonie, eziandio poi che nacque in terra Iddio e uomo.
CAPITOLO V.
Cerere, Dea delle biade, Reina di Sicilia.
Cerere, secondo che piace a’ molti, fu antichissima reina di Sicilia, e fu di tanto ingegno, che avendo pensato lo lavorar della terra, ella prima appresso i suoi domò i buoi, e trovò l’aratro e il vomere, usògli a portare il giogo, e con fatica di quelli fendere la terra, e spargervi la semenza per li solchi: la quale crescendo per molte biade, insegnò agli uomini, usati vivere di ghiande e di pomi, trarre quelle dalle spighe, macinare la biada, fermentare la farina e farne corpo. Per lo quale servigio, essendo quella mortal femmina, pensarono quelli esser Dea delle biade, onorandola con divini doni, e fu creduto che ella fosse generata di Saturno e di Cibele. E ancora dicono, che Proserpina sola fu sua figliuola generata da Giove suo fratello; e dicono, che con grande turbazione di sua madre fu rubata da Orco Re dei Molossi, e fu cercata lungamente, e per questo fu data cagione di molte favole. Fu ancora un’altra Cerere in Eleusi, città nel paese d’Atene, famosa appresso de’ suoi per quelli medesimi servigi; alla quale, dicono che tutto il mondo fu obbediente; la quale gli antichi magnificorono ugualmente con pari deità ed onori. Parmi assai far menzione d’amendue, e dei loro ingegni sotto un vocabolo. E certamente io non so se io lodi o se io bestemmj lo ingegno di quelle. Chi dannerà, gli uomini venti a modo di fiere essere tratti a migliore vita? chi dannerà, le ghiande essere mutate in biade, per le quali i corpi diventano più dilicati, le membra più forti, e i nutrimenti sono più conformi all’uso umano? chi dannerà, lo rozzo essere mutato in civile? chi dannerà, lo mondo scuro, incolto di bosco, assediato di spine e di disutili piante, essere mutato in bellezze e pubbliche utilitadi? chi dannerà, che gl’ingegni, sieno mutati di pigrizia a contemplazione? chi dannerà, quelle forze, che erano pigri nelle spelonche, essere tratte agli esercizj delle cittadi e delle ville; per le quali sono ampliate tante cittadi, e sono edificate di nuovo, sono cresciute tante signorie, e sono trovati tanti mirabili e eletti costumi, e trovato lo magisterio dell’arte delle biade; la quale benchè per sua natura sia buona, e che sieno buone tutte le cose sopraddette, secondo il giudizio de’ più, come io penso, sarà detto finalmente per lo contrario: chi loderà la moltitudine sperta, abitante le selve, usata alle ghiande, alle poma selvatiche, allo latte delle bestie, all’erbe e al fiume, la quale ha i suoi petti senza pensieri, contenta per la sua legge della natura, sobria e vergognosa, senza inganno, nemica solamente alle fiere e agli animali, essere tratta a’ più dilicati e non conosciuti cibi; dalli quali, se noi non ne inganniamo, noi medesimi, vedemmo che è seguito, dare alli vizj, stati lungamente nascosti e tementi, venire in palese, e dare sicurtà di procedere innanzi. Per questo i campi che noi vedemmo comuni, furono cominciati a avere confini, e seguì poi il pensiero dello lavorio dei campi, e fu cominciato partire le fatiche tra gli uomini: da questo venne di dire mio e tuo, i quali sono certamente vocaboli nemici della quiete pubblica e privata; da questo è proceduta la povertà, la servitù, e ancora le discordie, odj e sanguinose guerre, e la invidia che vola da ogni parte, le quali cose hanno fatto che le piegate falci, appena ancora provate a mietere le biade, fossero convertite in spade diritte e acute contro lo sangue; per questo è navigato il mare, e conosciute le cose di ponente da quelle di oriente, da questo è venuta la delicatezza e lo ingrossare dei corpi, e gli ornamenti delle vesti, le tavole più dilicate; la pigrizia, l’ozio, e la lussuria, che insino a quel tempo era stata fredda, cominciò a scaldarsi con grandissimo danno del mondo. Che forse è peggio, se nel passare degli anni, come alcuna volta avviene per disposizione del cielo, o per guerre, le terre rispondono variamente, siegue la carestia delle biade, il digiuno è più duro che non era prima, e l’aspra fame, non conosciuta mai nelle selve, entra nelle piccole case dei poveri uomini, spesse volte non senza pericolo del ricco. Da questa nasce la magrezza, la infernale pallidezza, la debolezza, per la quale si va tremando, e molte ragioni d’infermitadi, e della affrettata morte. Le quali cose considerate con altre cose senza novero, appena so, anzi lo so, che fu da mettere innanzi quelli secoli d’oro, rozzi e agresti a questi nostri di ferro e adornati.
CAPITOLO VI.
Minerva,che per altro nome fu chiamata Pallas.
Minerva, che per altro nome fu chiamata Pallas, vergine fu famosa di tanta nobiltà, che molti stolti uomini hanno creduto, quella non essere nata d’uomo. Dicono alcuni, che questa al tempo di Ogige re fu veduta e conosciuta prima in Troja, appresso il lago Tritonio, non lungi dal minor golfo delle Sirti: e perchè in processo di tempo vi videro quella non veduta innanzi far molte cose, fu creduto, quella esser nata senza madre della testa di Giove, e discesa dal cielo, non solamente appresso dei rozzi Africani, ma eziandio dei Greci, i quali in quel tempo avanzavano tutti gli altri di sapere. Al quale errore tanto fu dato più fede, quanto di quella fu più occulta l’origine. E innanzi all’altre cose vollero che ella fusse ornata di perpetua verginità: la qual cosa acciocchè fusse creduta con più piena fede, facevano una finzione, che Vulcano, Dio del fuoco, cioè la cupidità della carne, per lungo spazio combattè con quella, e che egli fu vinto. Ancora vollero che ella trovassi l’arte della lana, non saputa per infino a quel tempo, e la insegnò agli Ateniesi. Ella trovò come la lana fusse purgata, come fusse pettinata, come filata, come fussero ordinate le fila, e tessuto collo pettine, come dopo la tessitura fusse calcata co’ piedi. E a lode di quell’arte si fa menzione della maravigliosa prova che fu tra lei e Aracne di Colofonia. Ancora ella trovò l’usanza dell’olio, non conosciuto dagli uomini infino a quel tempo: ella insegnò agli Ateniesi rompere l’uliva, colla macina, e priemere quella collo torcitorio. Per la qualcosa, essendo imparato, dare molta utilità, fu creduto, che fusse attribuito a lei la vittoria contro a Nettuno di porre lo nume ad Atene. Ancora dicono, che ella trovò i numeri nell’ordine lo quale noi ancora serviamo. Ancora dicono, che per artifizio di questa fu trovato prima il carro; fu trovato fare armi di ferro, coprirsi il corpo con armi, ordinare tutte le leggi alle schiere dei combattitori; e che ella insegnò come si viene alla battaglia. Ancora credono che ella trovasse prima la trombetta, ovvero la piva dei pastori, dagli òssi d’alcuni uccelli, ovvero di canne di palude e che dal cielo ella le gittasse, perchè, sonando, quelli fanno enfiare la faccia. Perchè dico io più parole per tante maravigliose cose? L’antichità, donatrice delle Deità attribuì a quella la Deità. Per lo quale rispetto mossi quelli di Atene, pigliarono lo nome di quella; perchè quella città pareva atta a studio, per lo quale ciascuno diventa savio e prudente; e pigliarono quella per sua, e consacrarono a quella per la sua fortezza; edificarono a quella un tempio, e consacrarono a lei; figuraronla in quello con aspri occhi, paurosa, perchè rade volte si vede a che fine vada la intenzione del savio; vollero che quella tenesse un elmo in capo, perchè lo consiglio del savio è coperto ed armato; con un giachetto indosso, perchè il savio è sempre armato a ogni colpo di fortuna; armata di una lunghissima lancia, acciocchè noi comprendiamo che il savio vede da lungi; ancora ella è difesa di uno scudo di cristallo, e in quello intagliata la testa di Medusa, perchè ogni coperitura al savio è chiara; perchè di sapere serpentino lo pretendiamo sì armato, che gl’ignoranti paiano di sasso guardando a quegli. A sua sguardia ponevano la civetta a significare, che gli savj veggono così di notte come di dì. Finalmente la rinomanza, e la riverenzia di questa Dea è sì sparta per lungo e per traverso, e tanto gli ha acconsentito l’antico errore, che poco meno che per tutto l’universo furon fatti templi e sacrificj in onore di quella; e montò tanto, che in Campidoglio appresso di Giove ottimo massimo le fu fatta una cappella, e tra sommi Dii Romani questa era tenuta Dea, e Giunone reina. Nondimeno sono alcuni grandissimi uomini, li quali affermano, che le cose dette non sono state d’una Minerva, ma di molte; alle quali io consentirò volentieri, acciocchè le famose donne sieno state più in numero.
CAPITOLO VII.
Venere, Reina di Cipro.
Opinione è d’alcuni, che Venere fosse una donna di Cipro; ma è dubbio appresso di molti chi fosse suo padre, o sua madre. Per che alcuni vogliono che essa fosse figliuola di uno che si chiamò Ciro, e d’una donna che si chiamava Ciria; e alcuni dicono che ella fu figliuola di Ciro e di Diona, donna Cipriana. Alcuni per magnificare, secondo che io penso, la sua bellezza, affermano, quella generata da Giove e dalla predetta Diona. E certamente di qualunque padre sia nata, penso, quella porre fra le famose donne piuttosto per la sua bellezza eccellente, che per la sua vituperosa invenzione. Dunque fu tanto splendida per la bellezza della faccia, e di tutto il corpo, che spesse volte ingannava lo vedere di quelli che la vedevano. Perchè alcuni credevano, quella essere stella, che noi chiamiamo Venere, altri credevano che fosse femmina celestiale discesa in terra di grembo di Giove e, brievemente, tutti presi d’oscura ignoranza confermavano, quella essere immortale Dea, la quale eglino sapevano, essere partorita da mortale femmina; e affermavano con tutte le forze, quella madre dello infelice Amore, lo quale egli chiamano Cupidine. E non mancavano a quella l’arti di pigliare con varj atti la mente degli stolti che guardavano quella. Le quali opere lavorando, fu proceduto, che non potendo contrastare alle disonestà di quella donna, le quali non scriverò tutte per ordine, fu reputata figliuola di Giove, e una delle venerabilissime Dee. E non fu onorata solamente d’incenso appresso quelli di Pafo, antica città di Cipro; (pensavano quelli, che quella femmina morta, e disonesta si dilettasse di quell’odore, nello quale vivendo si rinvolgeva per li disonesti luoghi) ma ancora fu onorata presso le altre genti; e appresso dei Romani, i quali edificarono un tempio sotto titolo di Venere madre, e di Verticordia, ancora fu onorata d’altri ornamenti. Fu creduto, questa aver tolto due mariti; ma qual fosse il primo non è assai certo: ma, secondo che è piaciuto ad alcuno, ella fu la prima moglie di Vulcano, re di Lenno e figliuolo di Giove Cretese, il quale poi che fu morto, maritossi a Adone figliuolo di Cinira re dei Ciprj, e di Mirra: la qual cosa è più verisimile, che se noi diremo che Adone era stato lo primo marito. Perchè, o che fusse vizio di sua complessione, o che fusse per convenzione di quella regione, nella quale la disonestà parve avere grazia, ovvero possanza, o che avvenisse per malizia di corrotta mente, essendo già morto Adone, discorse in sì gran furia di disonestà, che parve macchiare ogni fama di sua bellezza con la multiplicata disonestà a quelli che non avevano corrotta la vista; essendo già manifesto nelle prossime regioni, quella essere stata trovata da Vulcano suo primo marito con un uomo d’arme. Per la qual cosa fu creduto che la favola del suo adulterio con Marte fosse trovata, finalmente, acciocchè ella paresse tor via alquanto di vergogna dalla sua disonesta faccia, e a sè concedesse più ampia licenzia di sue lascivie, ella prima pensò vituperosa bruttura; e, secondo che si dice, ella trovò vituperosi luoghi pubblici, e disoneste femmine, e costrinse entrare in quelli donne d’Asia: vituperosa usanza de’ Cipriani, prolungata per molti secoli, ne fa testimonianza. Perchè quelli osservano per lungo tempo mandare le sue fanciulle ai lidi, acciocchè elle pigliassero diletto co’ forestieri che venivano; e così parevano pagare a Venere il fiore della sua virginità per la castità che doveva seguire; e così guadagnavano la dote per suo matrimonio. La quale vituperosa mattezza dappoi passò in Italia, perchè si legge che i disonesti Locresi facevano così.
CAPITOLO VIII.
Iside, Reina d’Egitto.
Isis, la quale innanzi fu chiamata Io, fu non solamente reina degli Egizj, ma finalmente fu sua santissima e venerabile Dea. E nondimeno fu dubbio di che parenti, e in che tempo nata fosse appresso degli antichi scrittori delle storie. Furono alcuni che dissero, quella essere stata figliuola d’Inaco, primo re degli Argivi, e sirocchia di Foroneo; i quali è manifesto avere signoreggiato al tempo di Jacob, figliuolo di Isac. Altri affermano, che ella fu figliuola di Prometeo, essendo signore d’Argo Forbante, lo quale fu molto dopo lo primo tempo. Alcuni affermano, che ella fu al tempo di Cecrope re degli Ateniesi; e alcuni dicono che ella fu al tempo di Liceo, re degli Argivi: le quali varietadi oppresso dei valenti uomini non sono senza ragione. Che questa fosse fra l’altre donne al suo tempo nobile e degnissima di ricordazione, tutti lo affermano. Veramente lasciando le discordie degli scrittori, io ho in animo di seguire quello che i più pensano, cioè, quella essere stata figliuola d’Inaco, la quale benchè gli antichi poeti fingano che ella sia piaciuta a Giove per la sua bellezza e da lui sforzata, e per nascondere il fallo fosse trasmutata in vacca; e sia stata conceduta a Giunone, domandandola ella, e Argo suo guardiano stato ammazzato da Mercurio, e a quella vacca essere stato dato un assillo da Giunone, e ella sia stata condotta in Egitto fuggendo, e in quel luogo ricoverata la prima forma, e dal nome di Io istata chiamata Iside; non si discordano le predette cose dalla verità degli scrittori; essendo alcuni che dicono, quella vergine, fatta corrotta da Giove, e quella per paura del padre stimolata con alcuni dei suoi per lo commesso peccato essere entrata in nave, per la quale era per insegna una vacca; e atta a molte cose, stimolata di cupidità di signorie con prospero vento passò in Egitto, e in quel luogo, trovando la regione atta a suo desiderio, vi si fermò. E non trovandosi per che modo ella acquistasse l’Egitto, è riputato quasi certo che che ritrovasse in quel luogo genti grosse, senza arti, e quasi ignoranti di tutte cose umane e piuttosto viventi a modo di bestie che d’uomini; non senza fatica, e ingegno, e industria di maestria ammaestrasse quegli a lavorare la terra, seminare, e finalmente, ricolta la biada a tempo, ridurla a farne cibo. Ancora mostrò a quegli vagabondi e quasi selvatichi, ridursi insieme, dando legge a quegli civilmente. E (più meraviglioso in una femmina) ridotto a sottilità lo suo ingegno, trovò lettere convenienti al volgare di quegli del paese, e trovò il modo d’insegnarle, e con che ordine quelle s’accozzassero insieme. Le quali cose, tacendo le altre, parvero sì maravigliose a quella gente, che non era usata, che lievemente pensarono, quella non essere venuta di Grecia, ma mandata dal cielo, e per questo le deputarono tutti li divini onori. La cui deità (certamente ingannando il diavolo gl’ignoranti) pervenne dopo la morte in sì grande e famosa reverenzia, che le fu deputato un tempio grandissimo a Roma, già donna del mondo, e fulle deputato, che in ciascun anno le fosse fatto solenne sacrificio secondo il costume d’Egitto. E non è dubbio, che quest’onore trascorse infino alle barbare nazioni di Ponente. E certamente questa così famosa donna ebbe per marito Apis, il quale la erratica vecchiezza pensò essere stato figliuolo di Giove e di Niobe, figliuola di Foroneo, il quale, dicono, che avendo conceduto il regno ad Agtaleo fratello di Actaja, poichè egli era stato re trentacinque anni, andossene in Egitto, e insieme con Isis fu signore, e similmente riputato Dio, e fu chiamato Osiris ovvero Serapis. Benchè siano alcuni che dicono che il marito fu un uomo chiamato Tellogone, e di quello ingenerò Epafo, il quale dappoi fu re d’Egitto: e fu pensato che ella l’avesse generato di Giove.
CAPITOLO IX.
Europa, Reina di Creta.
Pensano alcuni che essa fusse figliuola di Fenice; ma molti più dicono, quella essere stata generata da Agenore, che fu re di Fenicia, e fu di sì maravigliosa bellezza, che, non avendola veduta, Giove re di Creta s’innamorò di lei, e per rubare quella, egli uomo possente mettendo agguati, dicono, che per ruffianeccio di parole di alcuno avvenne, che sollazzandosi quella fanciulla, seguendo gli armenti di suo padre, discese della montagna al lido di Fenicia; e presa incontanente, e menata in mare in una nave, nella quale era per insegna un bianco toro, fu condotta in Creta. E penso, che non sia da lodare che alle fanciulle sia commessa troppa licenzia di andare sollazzando, o che elleno ascoltino le parole di ognuno; perchè ho letto, quelle essere state macchiate, che fanno questo, di brutte macchie, le quali eziandio non può tanto lavare la bellezza di perpetua castità. Da queste cose ha tolto materia la favola nella quale si legge, che Mercurio costrinse al lido gli armenti di Fenice, e che Giove si convertì in toro, e nuotando portò Europa vergine in Creta. Ma gli antichi si discordano in che tempo fusse fatta questa rapina. Quegli che la pongono più antica, dicono che fu fatta regnando ancora Danao in Argo; altri dicono, che regnando Acrisio, e quegli di dietro dicono che fu regnando Pandione, re di Atene: la qual cosa pare agli tempi di Minosse suo figliuolo, e d’Europa. Alcuni dicono che Giove la sforzò, e che dappoi fusse moglie di Asterio, re di Creta, e che di quelli avesse tre figliuoli, Minos, Radamante e Sarpedone, i quali sono chiamati figliuoli di Giove, perchè alcuni affermano che Asterio e Giove sono una medesima cosa. La quale discordia appartenendo ad altri molti, s’accordano, Europa essere stata famosa per lo matrimonio di grande Dio. Affermano ancora alcuni; che dal suo nome è denominata Europa, che è la terza parte del mondo, perpetualmente, o che fosse perchè fu di singolare nobiltà, essendo quelli di Fenicia famosi nel suo tempo per molte virtudi, essendo quelli adornati di molti stemmi dei suoi antichi; o che fusse per riverenzia del divino marito, e per rispetto dei figliuoli; ovvero per ispezial virtù di Europa medesima, la quale io concedo non solamente maravigliosa donna per la virtù, essendo denominata parte del mondo da lei, ma eziandio per una maravigliosa statua di metallo consacrata per Pittagora, sommo filosofo, a Taranto a nome di Europa.
CAPITOLO X.
Libia, Reina di Libia.
Libia, secondo che vogliono gli antichi scrittori, fu figliuola di Epafo, re di Egitto, e di Cassiopa sua moglie, e fu moglie di Nettuno, potente forestiero, lo cui nome non è durato per insino a noi; e di quello ella partorì Busiride crudele tiranno della parte di sopra di Egitto. Ma le magnifiche opere di quella sono consumate dal tempo; e è assai argomento che ella fusse grandissima, che ella fu di tanta autorità verso dei suoi, che quella parte d’Africa nella quale ella signoreggiò, dal suo nome si è chiamata tutta Libia.
CAPITOLO XI.
Martesia e Lampedo, Reine delle Amazzoni.
Martesia e Lampedo furono sorelle insieme reine delle Amazzoni, e per famosa gloria delle battaglie si chiamarono figliuole di Marte. Delle quali perchè la storia è strana, è da cominciarla un poco più da lungi. Dal paese di Scizia, in quel tempo selvoso, e quasi non calcato da gente forestiera; lo quale si distende da tramontana verso ponente infino al mare maggiore; due giovani di schiatta di re, Plinos e Scolofito, secondo che si dice, per opera de’ suoi maggiori furono cacciati con parte dei suoi popoli; e questi arrivati in Cappadocia presso al fiume Termodoonte pigliarono i campi Temiscirj, e cominciarono a vivere di rapina, e stimolare quelli del paese, e rubare: i quali in processo di tempo furon presi e tutti morti. La qual cosa patendo molestamente le mogli che erano rimaste vedove, venute in ardore di vendetta caldamente, con alquanti dei mariti che erano rimasti, pigliarono l’armi e nel primo assalto cacciarono i nemici di suo paese. Poi di volontà mossero guerra a quelli che eran d’intorno; e finalmente, pensando piuttosto d’esser serve che maritate, s’elle si congiungessero a uomini d’altre nazioni; e pensando che elleno sole femmine potrebbero bastare a far guerra; e acciocchè elleno non paressero, avere avuti gli Dei senza parte d’armi, di comune consiglio uccisero tutti i loro mariti, che fortuna aveva salvati dalla sconfitta dei nemici. Poi, vòlto il furore contro a’ nemici, quasi com’elle volessero vendicare i morti mariti, impaurirongli sì, che lievemente impetrarono pace da quegli. La quale ricevuta, per aver figliuoli alcuna volta si congiugnevano con i vicini, e come erano gravide tornavano a casa; e finalmente quelli che nascevano maschi gli uccidevano, e le femmine conservavano con diligenza alla milizia e infino che elle erano piccole le segavano la destra mammella, acciocchè non crescesse quando erano grandi, perchè non impedisse lo saettare con l’arco, e la sinistra lasciavano salva per lo nutricamento di quelle che nascessero, onde elle furono chiamate Amazzoni. Ma non avevano quella cura a nutricare quelle fanciulle, che noi abbiamo alle nostre, perchè dispregiata la rocca, e l’altre cose d’esercizio di femmina, esercitavansi a cacciare, a correre, a domare cavagli, a continue fatiche d’armi, a saettare, e a simili esercizi ed erano grandi, indurate ad attitudine di fortezza d’uomini. Con le quali arti occuparono non solamente i campi Temiscirj, tenuti d’innanzi dai loro passati; ma acquistarono, per ragione di guerra, grande parte d’Europa, avendo innanzi presa grandissima parte d’Asia, e erano temute da ogni uomo. Acciocchè la loro potenzia avesse reggimento poichè elle uccisero i mariti, fecero innanzi all’altre loro reine Martesia e Lampedo, sotto lo cui governamento, come è mostrato, elle accrebbero la signoria primiera. E queste certamente maravigliose di milizia di magisterio partirono fra loro le provincie; acciocchè stando l’una a guardia del paese, l’altra andava con parte della gente a soggiogare i vicini che erano congiunti a suo imperio: e così con grandissime prede accrebbero la loro repubblica. E ultimamente avendo Lampedo condotta l’oste contro a’ nemici, per subito concorso dei vicini barbari Martesia fu morta, troppo fidandosi di sè, con parte dell’oste, rimanendo alcune femmine di quello; ma quello che avvenisse di Lampedo non mi ricordo averlo letto.
CAPITOLO XII.
Tisbe donzella di Babilonia.
Tisbe, vergine di Babilonia, diventò famosa fra gli uomini più per lo fine dello sciagurato amore, che per altra opera. E benchè noi non possiamo avere ajuto da’ nostri passati di che parentado questa sia nata, fu nondimeno creduto, che ella fusse vicina congiunta in Babilonia di Piramo, giovanetto di sua etade. I quali per la vicinanza vivendo insieme continuamente, adoperò in quelli, essendo fanciulli, la puerile affezione che per iniqua fortuna, crescendo gli animi, eglino diventati bellissimi, crebbe in grandissimo ardore, e quello in sè mostravano ancora con cenni alcuna volta, sopravvenendo la maggiore etade. È certo, essendo già grandicella Tisbe, cercando i parenti maritarla, cominciarono a tener quella in casale comportando questo amendue molto gravemente, e cercando sollecitamente per che via almeno potessero parlare alcuna volta insieme, trovarono in una parte nascosa della casa una fenditura di parete non veduta per infino allora da alcuno, alla quale fenditura andando nascosamente amendue più volte per usanza, favellando alquanto insieme, per la parete che era in mezzo, non vergognandosi, allargavasi la licenzia di manifestare la sua intenzione, sicchè spesse volte manifestarono i sospiri, le lagrime, i desiderj, e tutte le loro passioni: alcuna volta pregavano per la pace de’ suoi animi: abbracciandosi, baciavansi con pietà, fè, e perpetuo amore. Ma finalmente crescendo l’ardore, cominciarono a fuggire, e determinarono nella seguente notte ingannare i suoi, e uscirsi di casa, e andare a un bosco presso alla città ad una fonte presso alla sepoltura del re Nino e che aspettasse quello che andasse più tardi. Tisbe, forse più calda di amore, ingannò i suoi; con un mantello addosso sola di mezzanotte uscì fuori prima, e facendole lume la luna, andò senza paura a quel bosco, e spettando presso alla fontana, levando sollecita la testa per ogni movimento di cose, fuggì per uno lione che veniva alla fontana, lasciando per disavventura il mantello. Lo lione pasciuto, poi che ebbe bevuto, trovò lo mantello, stracciollo con le unghie, e lasciollo alquanto insanguinato, e partissi. In quel mezzo similmente Piramo uscito di casa arrivò al bosco, e trovò lo mantello, e stando attento per la tacita notte, e vedendo quello stracciato; pensò che Tisbe fusse stata divorata da quella fiera, e con molto pianto rinsonava in quel luogo chiamandosi misero, essere stato cagiona di crudel morte all’amata fanciulla; e dispregiando vivere più, tratta fuori la spada, ch’egli avea portata con seco, disposto morire presso alla fontana, alla quale esso era già presso, se la ficcò nel petto. Istante Tisbe pensando che lo lione fosse partito, e avesse bevuto, acciocchè non paresse avere ingannato l’amante, per non tenere quello sospeso in aspettare, pianamente cominciò a tornare alla fontana. Alla quale essendo già presso, sentendo Piramo ancora sbattersi, impaurita poco meno tornò addietro. E finalmente per lo lume della luna s’accorse che egli era lo suo Piramo, e andata correndo ad abbracciarlo, trovò quello giacere nel sangue che era uscito dalla ferita, e già essere allo estremo della morte. La quale, come ella lo vide, dapprima impaurita, finalmente trista, con grandissimo pianto sforzossi indarno di darli aiutorio, e baciandolo e abbracciandolo per lungo spazio, ma non potendo torgli alcuna parola, e sentendo che non apprezzava i baci, poco d’innanzi desiderati con tanto ardore, e vedendolo morto finire, pensò, ch’egli fusse morto perchè non l’avesse trovata, e disposesi all’acerba morte con l’amato giovane, confortandola insieme l’amore e il dolore. E tratta la spada della ferita, con grandissimo lamento chiamò lo nome di Piramo, e pregollo almeno, che guardasse la sua Tisbe alla morte, che egli aspettasse la sua anima nel partire, acciocchè fussino insieme in qualunque parte, o sedie dove eglino andassero. E (che maraviglia è a dire) lo intelletto di quello mancando, sentì la voce dell’amata fanciulla, e non comportando, ovvero non potendo negare l’ultima dimandagione, aperse gli occhi aggravati da morte, guardando quella che il chiamava. La quale subito si lascia cadere sopra lo coltello di quel giovine, e sparto lo sangue, seguì l’animo di quello che era ferito. E così l’odiosa fortuna non potè vietare che lo infelice sangue d’amendue si mischiasse insieme, la quale non aveva comportato che si giugnessero insieme con piacevole abbracciare. E chi non avrà compassione a quei giovani, chi non darà almeno una lagrima a sì infelice morte, sarà di pietra. Quegli si amarono in puerizia, e per questo non meritarono isciagurata morte; perchè peccato di giovanile etade non è orribile peccato per quelli che sono isciolti di matrimonio, il quale poteva seguire; e forse peccarono i miseri parenti. Appoco appoco per certo si debbono frenare le volontà degli uomini, acciocchè, volendo contrastare al subito suo imperio, non si sospingano per disperazione a pericolo. La passione desiderosa e senza temperanza, è quasi come una pestilenzia e un tormento de’ giovani, nei quali certamente egli si dee portare con paziente animo; perchè, volendo così la natura delle cose, avviene questo infino che noi siamo forti per la etade, quando noi ci pieghiamo ad avere figliuoli; acciocchè l’umana generazione non manchi, indugiando lo ingenerare alla vecchiezza.
CAPITOLO XIII.
Ipermnestra, Reina d’Argo.
Ipermnestra, famosa per nazione e per dignità, fu figliuola di Danao, re degli Argivi, e fu moglie di Linceo. E trovasi per le antiche storie, che già furono in Egitto due fratelli figliuoli del primo Belo, e furono maravigliosi per eccellenza di signoria, dei quali l’uno fu chiamato per nome Danao, l’altro Egitto. E benchè egli avessino uguali signorie non ebbero uguale fortuna di figliuoli; perchè Danao ebbe cinquanta figliuole, e Egitto altrettanti figliuoli maschi. E avendo Danao per augurio, dovere essere morto per mano d’uno di que’ nipoti, e nascosamente essendo stimolato da molta paura, non sapendo quali egli dovesse avere sospetti per sì gran moltitudine; avvenne, che cominciando ad essere grandicelli quelli figliuoli, e quelle figliuole, Egitto domandò che tutte le figliuole di Danao fossero date ai figliuoli, alla qualcosa (pensando Danao orribile peccato) volentieri consentì. E di più dando le figliuole ai nipoti, apparecchiandosi lo sacrificio delle nozze, informò tutte quelle con gran sollecitudine, che se volessero la sua salute, ciascuna la prima notte uccidesse con ferro lo suo marito quando ella lo vedesse gravato di vino e di vivande, e legato di grave sonno. Le quali tutte portati i coltelli nascosamente nelle camere, di comandamento di lor padre li uccisero, essendo quelli giovani matti di grave ebrietà. Ma sola Ipermnestra s’astenne del peccato, perchè già la fanciulla avea posto l’animo al marito, il quale avea nome Linceo; secondo l’usanza delle fanciulle, siccome il vide l’amò, e così avendogli compassione, con grandissima sua lode si astenne di ucciderlo, e confortò lo giovine che si fuggisse, per lo quale fuggire egli campò. E, facendo la mattina lo crudel padre festa per lo commesso peccato, sola Ipermnestra fu presa e messa in prigione, dove per alcuno spazio ella pianse la pietosa opera. Oh miseri uomini con quanto cupido animo, e come caldo, desideriamo noi le cose che deono perire! e per che maledette vie, dispregiando il fine, montiamo noi all’alte cose, e con che peccato serviamo noi quelle quando vi siamo montati! come noi pensiamo, con perverse opere potere mutare la mutabile fortuna! E (che è da ridere) con quali scellerati peccati noi ci ingegniamo fare perpetua questa piccola giornata di vita mutabile e debile, vedendo tutti gli altri correre alla morte! con quali detestabili consigli, con quali opere dispreggiamo lo giudizio di Dio! E sia testimonio lo crudele Danao, lo quale con molto sangue sforzandosi accrescere i suoi tremanti anni, discorse in perpetua infamia. E lo malvagio uomo pensò che si dovesse mettere innanzi i pochi e freddi anni della sua vecchiezza, ai fiorenti della gioventù dei suoi nipoti, perchè forse altri gli avrebbe pensati più utili, purchè egli gli avesse salvati onestamente. Ma avere cercato di allungare la sua vecchiezza con le piaghe dei viventi figliuoli, giustamente può parere crudeltà; e, che più aggiunse all’ingiuria, non armò le mani dei famigli, ma delle figliuole a commettere quel peccato, acciocchè non solamente ei facesse morire i nipoti, ma col peccato fece scellerate le figliuole, le quali con la pietà egli poteva avere oneste. E volendo con quello peccato salvare la vita, non pensò quanto obbrobrio, quanto inganno, detestabile esempio d’obbrobrio, egli lasciasse alle figliuole a dovere esser perverse. Egli fece rompere la fè del matrimonio con la crudeltà; dove, pietoso padre, doveva comandare che portassero nelle camere le sacre faci, comandò che portassero coltelli; dove noi abbiamo per usanza confortare le figliuole all’amore dei mariti, egli le inanimò ad odio e omicidio; e quello che non avrebbe ardito a fare in tutti, comandollo particolarmente alle figliuole; quello che non avrebbe tentato di dì, volle che fusse fatto di notte, quello che non avrebbe ardito a campo, comandò che fosse fatto nelle camere, non pensando che quanti anni egli toglieva alla verde gioventù de’ nipoti, per crudeltà e inganno, tanti secoli s’avea per sè bruttati d’odiosa sua opera. Egli il quale giustamente poteva avere cinquanta generi, fugli salvato per esso giustamente un nimico, delle cui mani finalmente per giusto giudizio di Dio quello crudele vecchio non potè campare, sicchè il suo nocivo sangue non fosse sparso, il quale egli avea salvato con tanto sangue dei nipoti. Il quale finalmente, o che fusse cacciato, o che fuggisse, o che egli fusse chiamato, passò in Grecia, e tenne lo regno degli Argivi occupato per lo ingegno e per la forza; dove, dicono alcuni, che fu commesso lo detto peccato da Danao, ma dove quello, di crudel memoria, fu morto da Linceo, e in luogo di quello regnò Linceo ad Argo. E Ipermnestra fa tratta di prigione, e congiunta di matrimonio a migliore uomo, alla quale egli fece parte del regno: la quale non solamente ebbe fama di reina, ma fatta sacerdotessa di Iunone a Argo, fu gloriosa di doppia fama; e rimanendo le sorelle di vituperosa infamia, ella per la lodabile pietà ha condotto il suo nome, degno di lode, famoso infino al nostro tempo.
CAPITOLO XIV.
Niobe, Reina di Tebe.
Niobe, famosissima donna tra le nobili, fu figliuola di Tantalo, antichissimo e famosissimo re di Frigia, e sorella di Pelope. Poi fu moglie di Arnione, re di Tebe, famosissimo in quel tempo, così perchè egli fu figliuolo di Giove, come per sua eloquenzia; e durando la gloria del regno ella partorì sette figliuoli, e altrettante figliuole. E certamente quello che al savio dovea giovare fu la morte a lei, che insuperbì, e insuperbita non tanto per la nobile famiglia dei figliuoli, ma eziandio per la gloria dei suoi maggiori, ardì di sparlare contro agli Dei. Erano un dì i Tebani solleciti, per ammaestramento di Manio figliuolo di Tiresia astrologo, a fare sagrificj a Latona madre di Apollo e di Diana, venerabile Dea per antica ragione, e Niobe, stimolata quasi da una furia, veduta la sua brigata dei figliuoli onorati di reali onori, presentossi, palese gridando: Che matterìa fusse quelle dei Tebani, fare lo sagrificio a Latona, donna forestiera e figliuola di Titano, la quale solamente aveva due figliuoli concetti per adulterio, e di mettere quella innanzi a sè sua reina, figliuola di Tantalo re, la quale di suo marito avea partoriti a quegli, vedendogli, quattordeci figliuoli, dicendo, che a sè, come a più degna convenivano gli sagrificj. E dopo piccolo spazio di tempo avvenne, che in presenza di quella, per mortale pestilenzia tutti i figliuoli, splendidi di gioventù, in piccolo spazio morirono infino all’ultimo. E Anfione essendo privato di quattordici figliuoli, di dolor pieno con le mani proprie si diede la morte. Laonde i Tebani stimarono ciò esser fatto per ira degli Dei i quali vendicassino l’ingiuria della Dea. Ma Niobe, rimasta vedova e trista, ostinata venne in tanto senza parlare, che piuttosto parea un’immobile sasso che una femmina. Per la qual cagione i poeti ferono poi una finzione, che ella si convertì in una statua di pietra presso Sipiilo, dove erano stati seppelliti i figliuoli. Dura cosa e molto odiosa vedere, nonchè comportare, i superbi, ma comportare le superbe donne è fastidioso, e incomportabile: conciossiacosachè per la maggior parte la natura abbia prodotto quelli con caldo e superbo animo, e queste ella produsse con umile ingegno, non con superba virtù, e piuttosto atte a dilicanza che a signoria. Per la qual cosa è meno da maravigliarsi, se contro a queste elate l’ira di Dio è più provocata e la sentenzia più crudele, quante volte avviene che elleno passino il termine della sua debilità, come fece la insipida Niobe, ingannata da fallacia di fortuna, e ignorante, che avere molti figliuoli non è virtù della madre che li partorisce, ma opera della natura che volge in quella la benignità del cielo. Dunque piuttosto doveva rendere quella grazia (e era suo debito) a uno Iddio dei figliuoli conceduti, che domandare alcuni divini onori, acciocchè le fussero fatti, come se fosse stata sua opera avere tanto numero di figliuoli così maravigliosi. La quale avendo piuttosto operato superbamente che saviamente, fece che, vivendo, pianse la sua sciagura, e dopo molti secoli lo suo nome, odioso a quelli che vengono drieto.
CAPITOLO XV.
Isifile, Reina di Lenno.
Isifile fu famosa donna sì per la pietà che ella ebbe verso suo padre, come per lo suo esilio, e per la morte di Archemore nutricato da lei, e per l’ajutorio dei figliuoli trovato in opportuno tempo. Questa fu figliuola di Toante, re di Lenno, il quale regnava in quel tempo, nel quale alle donne di quell’isola entrò la furia di trarre lo non domato collo dal servigio degli uomini. Dispregiata la signoria del vecchio Toante, con Isifile vennero a questa deliberazione d’un animo, che la notte seguente elle uccidessero tutti i maschi: e non mancò effetto al proponimento. E certo, essendo tutte crudeli l’altre, Isifile fece più pietosa deliberazione; perchè pensando cosa inumana bruttar del sangue del padre suo, manifestò a suo padre lo peccato dell’altre: e messo lui in nave, perchè egli fuggisse a Chio incontanente, per fuggire la comune ira delle altre, fatto un grandissimo fuoco, finse fare l’ultimo servigio al padre. La qual cosa essendo creduta da tutte, e essendo posta nella sedia del padre; in luogo di quello fu sostituita reina delle malvage femmine. È certamente santissima la pietà dei figliuoli verso i padri. E quale cosa è più laudabile, che rendere con umanità, e con onore la sua vicenda a quegli dai quali, essendo piccoli, noi ricevemmo nutrimento, con sollecitudine siamo stati guardati, e con continuo amore siamo condotti in perfetta età, e siamo ammaestrati di costumi e di dottrina, e ancora magnificati di onori e di ricchezze, e siamo validi per li costumi e per lo ingegno? certamente niuna. Le quali cose essendo date da Isifile con sollecitudine a suo padre, non senza cagione ella è aggiunta alle nobili donne. Dunque, regnando quella, o che fosse menato per fortuna di venti, o che egli v’andasse deliberatamente, Giasone andando a Coleo cogli Argonauti arrivò a quell’isola; e facendo resistenza le donne indarno, pigliò quel luogo, e dalla reina fu ricevuto in casa, e a suo matrimonio. Dal quale poichè partì, ella partorì due figliuoli, i quali per la legge di quelle di Lenno, secondo che piace ad alcuno, comandò che fossero portati via a Chio a suo padre che gli nutricasse. Per la qual cosa, saputo che ella avea salvato il padre, levarono lo romore contro a quella, perchè avea ingannate l’altre: e appena entrata in nave campò dal comun furore, e andando a suo padre e a’ suoi figliuoli, fu presa da’ corsari, e fatta serva. Dopo molte fatiche fu donata a Licurgo, re di Nemea; e fu posta a guardia di un suo figliuolo dal re, il quale era piccolo fanciullo chiamato per nome Ofelte. La quale guardando quello, passando per lo paese Adrasto re con l’oste, il quale periva per sete andando con quell’esercito a Tebe, e pregando, quella mostragli la fontana, lasciando lo piccolo figliuolo che nutricava tra fiori in un campo: e domandò Adrasto che gli contasse la sua passata fortuna. Ella fu conosciuta da Enone e Toante, suoi figliuoli già cresciuti, e già della milizia del re; e dirizzata nella speranza di miglior fortuna, trovato lo fanciullo che ella nutricava morto, giuocando egli fra l’erbe, per lo sbattere di una coda di serpente, poco meno turbò tutta l’oste col pianto; dalla quale oste e dai quali figliuoli ella fu tolta a Licurgo, il quale furiava per lo dolore, e fu difesa dalla fortuna e dalla morte non so come fatto.
CAPITOLO XVI.
Medea, Reina dei Colchi.
Medea, crudelissimo esempio di antica malvagia, fu figliuola di Oete, malvagissimo re di Colco e di Ipsea sua moglie: fu assai bella, e simigliantemente ammaestrata. Ebbe intanto lo cognoscimento delle erbe, che niuno le conobbe meglio; e seppe perfettamente turbare lo cielo, convocare venti dalle tane, muovere tempeste, fare star fermi i fiumi, fare e comporre veleni, comporre fuochi artificiosi ad ogni incendio, e fare tutte simili cose. E, che molto peggio fu, non ebbe l’animo discordevole dalle arti; perchè mancandole quelle, parevate levissima cosa usare lo ferro. Questa primieramente amò ardentissimamente Giasone di Tessaglia, in quel tempo maraviglioso giovine per virtù, mandato da Pelia suo zio, il quale avea invidia della sua virtù, in Colco, sotto pretesto di gloriosa andata d’acquistare lo vello dell’oro. E presa della sua eccellenzia, acciocchè ella meritasse lo suo amore, adoperò, che convenuta discordia tra quegli del paese, si movesse guerra a suo padre, acciocchè Giasone avesse spazio di compiere lo suo desiderio. Quale uomo eziandio penserà che in un muovere d’occhi seguisse lo sterminio di uno ricchissimo re? Dunque, commesso quel peccato, avendo meritato lo abbracciane dello amato giovine, con quel medesimo nascosamente si mise a fuggire, portando con quello tutta la sostanza del suo padre. E non contenta di sì gran fallo, volse a peggio lo crudele animo, perchè pensando che Oete seguisse quegli, fuggendo meno con seco un suo fratello piccolo fanciullo, lo quale, perchè il padre avesse cagione di restare per lo cammino, fece tagliare, e spargere per li campi le membra del detto suo fratello nell’isola di Faside, chiamata Tomitania, per la quale seguendo lei, egli doveva passare; acciocchè dimorando il padre a ricogliere le membra del figliuolo, e piagnerlo, e a seppellirlo, egli desse eziandio spazio a quelli che fuggivano: e non l’ingannò l’opinione, perchè così avvenne. Ultimamente dopo molti errori arrivò in Tessaglia con Giasone, ove ella riempiè Esone suo suocero di tanta letizia, sì per la tornata del figliuolo, come per la acquistata vittoria, e per la preda, e per lo nobile matrimonio, che pareva ritornato in fiorita gioventù. E volendo fare acquistare lo regno di Giasone, seminò zizzania tra Pelia, e le figliuole con sua arte, e armò quelle miseramente contro a suo padre. Poi in discorso d’anni fatta odiosa a Giasone, in luogo di lei tolse Creusa figliuola di Creonte, re de’ Corinti: e sopportando Medea questa cosa impazientemente, e infuriata, divisando più cose intorno a Giasone, alla fine s’inanimò con l’arte sua far fuoco arteficiato, e con quello Creusa, figliuola di Creonte, e Creonte con tutta la casa reale abbruciare, e vedente Giasone, ella uccise due figliuoli i quali ella avea avuti da lui, e fuggì in Atene, ove Egeo re la tolse per moglie; dal quale ebbe Medo figliuolo dinominato da lei. E avendo tentato indarno di uccidere col veleno Teseo, il quale tornava, fuggì la terza volta. E tornata in grazia di Giasone, insieme con lui fu cacciata da tutta Tessaglia da Agelao figliuolo di Pelia, e con Giasone insieme tornò in Colco, e ritornò nel regno il padre, il quale era vecchio e bandeggiato. Ma che alla fine ella facesse, o dove ella morisse, o in che modo, non mi ricordo averlo letto nè veduto. Ma acciocchè io non lasci di dire, non si deve dare troppa licenzia agli occhi; perchè guardando quegli noi conosciamo le bellezze, pigliamo invidia, traiamo a noi ogni cupidità: movendo quegli si eccita l’ardire, si loda la bellezza, dannasi indegnamente la bruttezza e la povertà, e non essendo ammaestrati giudici, solamente credono alle parti di fuori; spesse volte premettono quelle che sono vituperose alle sacre, e quelle che sono faticose, spesse volte alle allegre, e commendando le cose che si devono vituperare, in piccolo spazio bruttano alcuna volta gli animi di vituperosa corruzione. Questi ignoranti son presi, tratti, rapiti, e tenuti con mordaci vizj dalla bellezza eziandio giovanile con piacevoli sollazzi. E perchè quegli sono le porte del petto, per quegli entra la cupidità nella mente; per quegli passano i sospiri, e appigliano lo cieco fuoco; per quegli il cuore manda fuori lamenti, e mostra le sue disoneste affezioni. I quali se alcuno conoscesse bene, o terrebbegli serrati, o direrebbegli al cielo, o egli se li ficcherebbe a terra; e niuna via fuori di questa è sicura, E se al postutto si conviene adoperarli, debbonsi costringere col freno sì che egli non vadano discorrendo. La natura vi ha fatta la porta non solamente perchè sieno serrati dormendo, ma perchè contrastino alle cose nocive. E certamente se Medea avesse serrati quelli, e avesseli piegati ad altra parte quando desiderosa li dirizzò in Giasone, sarebbe durata lungamente la potenzia del padre, la vita del fratello, l’onore di sua verginità sarebbe durato netto. Le quali cose tutte perirono per la disonestà di quegli.
CAPITOLO XVII.
Aragne d’Asia
Aracne fu una donna d’Asia, e fu di popolo, figliuola di Idomonto di Colofonia tintore di lana; la quale benchè non fosse famosa per sua schiatta, nondimeno si dee magnificare per alcune sue virtù. Affermano alcuni antichi, che ella trovò l’uso del lino, e che ella prima pensò fare le reti: è incerto se furono da pescare o da uccellare. E avendo trovato suo figliuolo, il quale fu chiamato Closter, gli fusi atti ad arte di lana, pensano che questa tenesse il principato nell’arte del tessere, e che ella fosse di grande ingegno; che ella con le dita, con le fila e con la spola, e con le altre cose destre a siffatti uffizj, lavorava quello che il pintore faceva col pennello; e non è da dispregiare questo artificio in una femmina. E certo udendo sì chiara nominanza non solamente in Colofonia, dove abitando ella avea sua tessoria, ma in ogni luogo, insuperbissi tanto, che ella ardì venire a contenzione con Pallade, la quale avea trovata quell’arte: e non potendo comportare d’esser vinta, con impaziente animo con un laccio finì sua vita. Per la qual cosa fu data cagione a quegli che di questo vollero fare finzione, perchè avendo convenienza Aragne con ragno, vermine, nel nome e nell’esercizio, e quello stando appiccato per lo filo come quella per lo laccio, dissero che Aragne per misericordia degli Dei fu convertita in ragno e continuamente con sollecitudine soprasta il primo artificio. Altri dissero, che, benchè ella si mettesse lo laccio per morire, non morì, sopravvenendo l’aiutorio de’ suoi; ma lasciata la sua arte istette sempre in dolore; E al presente, priego, che se alcuno lo quale creda in una cosa andare innanzi agli altri, dica Aragne medesima, se gli piace, se ella pensava potere volgere lo cielo in sè e tirare con sè tutte le dignità; o se piuttosto ella avrebbe potuto co’ preghi e co’ meriti avere fatto verso di sè il suo Dio fattore di tutte le cose, benigno sì, che con l’aperto grembo di sua cortesia, lasciate l’altre, avesse condotte tutte grazie a quella. Ma che dirò io? questa pare avere cosi giudicato. E certamente fu somma stoltizia. La natura con eterna legge volge lo cielo, e dà a tutti gl’ingegni atti a varie cose: come questi diventano deboli por ozio e per pigrizia, così per istudio e per esercizio diventano chiari, e capaci delle grandissime cose. E stimolando quella medesima natura, tutti siamo mossi dal desiderio al conoscimento di tutte le cose, benchè non con una medesima sollecitudine e fortuna. E se è così, è contrario che molti non possono essere pari in una medesima cosa? e per questo, alcuno estimare sè solo avanzare gli altri nel corso della gloria in sì grande moltitudine di uomini, è cosa che aspetta a matto animo. E certo io desidererei che questa Aragne fosse sola, e non fusse sollazzo, perchè sono senza numero i legati di tanta sciocchezza, i quali, levandosi in pericolo di matta presunzione, fanno che non dobbiamo ridere di Aragne.
CAPITOLO XVIII.
Oritia di Martesia.
Oritia fa figliuola di Martesia, e fu insieme con Antiope, la quale alcuni pensano, essere stata sua sorella, reina delle Amazzoni dopo Martesia. E innanzi alle altre cose fu molto meravigliosa, e commendabile per la perpetua verginità; e valse tanto con Antiope sua sorella, compagna di regno in fatto d’arme, che ella ampiò di molti onori lo regno delle Amazzoni, e levò in tanto le sue lodi di disciplina militare, che Euristeo, re di Micene, pensò faticosa cosa poterle torre per battaglia lo suo schezzale; e per questo si dice, che egli impose ad Ercole suo debitore, come cosa grandissima, che egli glie lo portasse. E certamente a quella donna fu grandissima lode che fusse mandato contro a lei per la famosa Virtù in fatto d’arme Ercole, lo quale vinceva ogni cosa. Il quale entrato in cammino, arrivato con nove galere al lido delle Amazzoni, non essendo presente Oritia, levato romore contro alle Amazzoni, perchè erano poche, lievemente ebbe vittoria; e presa Menalippe, e Ippolita, sorelle di Antiope, avuto Io schezzale della regina, Menalippe fu restituita. Ma come Oritia sentì che Teseo compagno d’Ercole aveva portato Ippolita, ardì muovere la guerra a tutta la Grecia, raunando ajutorj; ma per la discordia abbandonata da’ confederati, fu vinta dagli Ateniesi, e tornò nel regno. Ma non mi ricordo aver trovato che ella facesse dappoi.
CAPITOLO XIX.
Eritrea Sibilla.
Eritrea, o che ella fosse chiamata Erifila, molto maravigliosa donna, fu una delle Sibille. Alcuni certamente pensano che fussero dieci in numero; e chiamarono quelle per proprj nomi. E perchè elleno seppero molto degli augurj, così hanno chiamato quelle per soprannome; perchè sios in Eolio è a dire in latino di Dio, e biles è a dire mente: e per questi due nomi Sibilla è a dire mente divina, ovvero mente di Dio Delle quali tutte venerabili, dicono, questa essere stata sommamente famosa, appresso quegli di Babilonia essere sua origine alcun tempo innanzi la guerra di Troja, benchè molti pensano che ella desse i suoi augurj al tempo di Romolo, re de’ Romani. E, secondo che dicono, questa ebbe nome Erifila, e fu chiamata Eritrea, perchè lungo tempo abitò appresso Eritrea isola; e in quel luogo compose più scritture. E ebbe questa tanta virtù d’ingegno, ovvero eloquenza, e merito di devozione nel cospetto di Dio, che per sollecito studio, non senza divino dono, meritò (se è vero quello che si legge da lei detto) descrivere con tanta chiarezza le cose future, che piuttosto parve Evangelio che augurio. Questa certamente, domandata dai Greci, disse in versi sì chiaramente le fatiche loro, e la disfazione d’Ilione, che niente ne fu saputo più certo dopo il fatto. E così comprese in poche e vere parole lo imperio de’ Romani e le sue varie fortune per gran tempo innanzi che cominciasse, sicchè piuttosto pareva che ella avesse scritto un’abbreviazione al nostro tempo, che avere predette le cose future. E (che molto più è segreto della mente divina, secondo mia sentenzia) aperse le parole della Incarnazione del Figliuolo di Dio, dette innanzi interamente per figura dagli antichi profeti; sicchè pare avere dettata una storia, e non avere predetto gli atti che dovessero essere della Incarnazione, della natività, delle opere, del tradimento, della presa e dello scherno, e della disonesta morte, e del trionfo della risurrezione, dell’ascensione, e finalmente del giudizio, e del tornare delle anime. Fra donne degli antichi fu sì degna di riverenzia, che furono ancora alcuni i quali affermarono, quella avere serrata perpetua virginità: la qual cosa io crederò lievemente, perchè non mi pare che in uno macchiato petto fosse potuto abitare tanta chiarezza di cose future. È scuro in che parte ella morisse.
CAPITOLO XX.
Medusa, figliuola di Forco.
Medusa fu figliuola e erede di Forco, ricchissimo re, e fu lo suo ricchissimo regno nel mare Atlantico, lo quale alcuni hanno creduto che fossero l’isole Esperide. Se noi possiamo dar fè alla vecchiezza, fu di sì maravigliosa bellezza, che non solamente avanzava l’altre, ma, come una cosa maravigliosa fuori di natura, trasse a sè molti uomini per vederla. Ella avea capellatura d’oro, e avevane in grande quantità, aveva faccia di speziale bellezza, grande e diritta statura, ma soprattutto ella ebbe sì grande, e sì piacevole vigore d’occhi, che se ella guardava alcuni benignamente, poco meno stavano immobili e innamorati. Ancora alcuni hanno affermato, che ella fu sommamente ammaestrata d’agricoltura, e per quello poi acquistò per soprannome Gorgon: per lo cui esercizio ella conservò non solamente con meravigliosa sagacità le ricchezze di suo padre, ma accrebbele grandissimamente, intanto che quegli che la conobbero credettero che ella avanzasse tutti i re di Ponente di tesoro. E così per la gran bellezza, e per la sagacità ella pervenne in grandissima fama eziandio appresso remotissime nazioni. Con glorioso romore la fama di quella pervenne in Grecia, ove tra gli altri giovani d’Acaja, Perseo il più forte, udite sì fatte cose, entrò in desiderio di vedere quella bellissima donna, e di torle lo suo tesoro. E così entrato in nave, nella quale era per insegna un cavallo Pegaseo, con maravigliosa prestezza arrivò in Ponente: in quel luogo, usato lo suo sapere e le armi, rubò la Reina, e carico di ricca preda tornò a casa. E da queste cose pigliò materia la finzione dei poeti, nella quale noi leggiamo: Medusa Gorgone era usata convertire in sasso gli uomini che ella vedeva, e i suoi capelli essere stati convertiti in serpenti per ira di Minerva, perchè ella avea corrotto lo suo tempio, commettendo in quello adulterio con Nettuno; e che ella partorì lo cavallo Pegaseo; e Perseo sedendo su d’un cavallo alato volò nel regno di quella; e avendo usato lo scudo di Pallade, vinse. Possedere oro è una infelicità: se si tiene riposto non è d’alcuna utilità ovvero comodità al posseditore, che se cessino i rubatori, non cessano i faticosi pensieri dei posseditori; perchè, cacciato lo riposo de l’animo, perdesi lo sonno, e entra la paura, mutasi la fè, cresce lo sospetto, e brievemente è impacciato tutto l’uso di questa misera vita: e se per alcun caso si perde quello, fatto povero, l’avaro è tormentato dalla cupidità, lo cortese loda lo fatto, lo invidioso ride, lo povero lo consola, la turba mette in favola quello pieno di dolore.
CAPITOLO XXI.
Iole, Reina di Etolia.
Iole fu figliuola di Eurito, re di Etolia, e fu una donzella bellissima tra le altre del paese. E sono alcuni che dicono, quella essere stata amata da Ercole domatore del mondo; lo matrimonio della quale avendogli promesso Eurito, dicesi, che per isconforto d’un suo figliuolo, dappoi egli gliel negava. Per la qual cosa irato Ercole mosse contro a quello gran guerra, e quello uccise, e prese l’amata Iole: la quale certamente più toccata dalla morte del padre, che dell’amore del marito, cupida di vendetta, con maraviglioso e costante scaltrimento, con finto amore coperse l’animo che aveva; e con lusinghe, e con lasciva piacevolezza trasse Ercole a sì caldo amore di sè, che assai s’accorgeva che Ercole non le negherebbe alcuna cosa che gli domandasse. E per questo, come se ella avesse avuta paura dello amante così orribile, disse innanzi l’altre cose a quello forte uomo, che egli riponesse la mazza, con la quale egli aveva domati miracolosi animali, che egli mettesse giù la pelle del Leone Nemeo, insegna di sua fortezza, fecegli mettere giuso la ghirlanda di pioppo, l’arco e le saette: le quali cose non bastando al suo animo, più arditamente presunse contro al suo nemico, avendo pensato con che arme gli potesse nuocere. E primieramente gli comandò che egli s’ornasse le dita delle mani, e che egli si ungesse la testa con unguenti Cipriani, che egli si pettinasse i capelli, e ungesse la irsuta barba, e ornassesi con fanciullesche ghirlande e con la mitria Meonia. Più, gl’impose che egli si vestisse di porpora e di veste delicate; pensando quella giovinetta, molto più aver fatto con l’inganno d’avere invilito sì robusto uomo con le lascivie, che averlo morto col ferro e col veleno. E certo non pensando avere assai fatto alla sua indignazione, tanto operò in lui, che condusse quello dato alle delicatezze, che eziandio tra le femminette, a modo di femmina sedendo, contava le favole delle sue Fatiche; e pigliando i fusi filava la lana con rocca; e le dita, che erano state dure a uccidere i serpenti, essendo egli nella forte età, le faceva morbide a filare la lana. E certamente non fu piccolo argomento a quelli che vogliono guardare l’umana debilità, e la malizia delle femmine. Dunque con quella deliberazione l’animosa fanciulla mossa contro a Ercole con perpetua vergogna vendicò la morte di suo padre non con armi, ma con inganno e con lascivia, e fecesi degna dell’eterno nome. Perchè di quanti miracoli Ercole condusse trionfi, di tanti più gloriosamente trionfò Iole, la quale uccise lui solo. Questa pestilenziosa passione è stata avvezza a accostarsi a delicate fanciulle, e molto spesso pigliare lascivi e viziosi giovani; perchè l’amore è disprezzatore della gravità ed amatore della leggierezza: e perciò è egli maggiore miracolo che egli sia entrato nel durissimo petto di Ercole, che non furono quelle cose che spesse volte egli domò. La qual cosa non dee dare poco, di paura, e d’ismarrimento ai solleciti d’amore, essendo manifesto come sia forte e possente nemico. Dunque è da vegliare, e da armare i nostri cuori con molta fortezza; perchè noi non siamo vinti contro a nostro volere. Dunque al principio si dee far resistenzia; deonsi frenare gli occhi, sicchè non veggano la vanità, serrare le orecchie come l’aspide, con contrarie fatiche, domare la lascivia:, perchè l’amore s’offerisce lusinghevole a quegli che non si guardano, ed è piacevole nella prima entrata, con allegra speranza conforta ad ornarsi lo corpo, ad ornare i costumi, a lepori, a balli, a canti, a suoni, a giuochi, a brigate, e a simili cose. Ma poichè egli con matte lodi ha occupato tutto l’uomo, e vinto la libertà, messe le catene e i legami alla mente, indugiando i desiderj oltre alla speranza, desta i sospiri, non facendo alcuna differenza dai vizj alla virtù purchè segua suo appetito, ponendo nel numero de’ nemici ogni cosa che è contraria a questo: ardendo le fiamme, va e torna, non istancandosi, lo desiderio: cercasi la cosa amata, e, replicando spesso lo vedere, sempre si contraono nuovi ardori; e non essendo possibile pentirsi, piangesi, e dirannosi prieghi unti per lusinghe, trovansi ruffiane, promettonsi doni, donasi, gittasi e alcuna volta s’ingannano le guardie, e con lo vegghiare si pigliano i fortificati cuori. Alcuna volta si arriva al desiderato abbracciare: allora lo diletto, nemico dell’onestà, e confortatore dei peccati, cacciata via la vergogna e l’onestà, con una bruttura apparecchiata ai porci manifesta le scellerate blandizie. Allora cacciata la temperanza, e chiamata la lussuria calda di mangiare e di bere, tutte le notti si consumano in vituperosa lascivia, nè per questo s’ammorta quel furore, anzi molto spesso s’accresce in maggiore fiamma. Per la qual cosa addiviene, che Ercole cada in quella vituperosa obbedienza: ismenticansi gli onori, consumansi le ricchezze, armasi l’odio, spessissime volte si sottentra a’ pericoli della vita: nè queste cose mancano di dolori: avvengono le contenzioni e paci brievi, e da capo sospetti, morte delle anime, consumatori dei corpi. E se gli amanti non vengono a suo desiderio, allora l’amore povero di ragione, aggiunto agli stimoli gli sproni, accresce li pensieri, raddoppia lo desiderio, e induce dolori quasi intollerabili da non potergli curare di alcuno rimedio, se non con lagrime e con lamentanze, e alcuna volta con la morte: cercansi vecchiette, domandansi indovini, provansi le virtù dell’erbe, dell’incanti e delle fatture: le lusinghe si convertono in minaccie, pensasi alla forza: dannasi lo ingannato amore; e non manca, che alcuna volta questo artigiano de’ mali mette tanto furore, che sospigne alla forza ed a’ coltegli. Oh quanto è dolce, e quanto è soave questo amore! lo quale dovendo noi temere e fuggire, noi lo leviamo in alto come Dio: quello onoriamo, quello umilemente adoriamo, e offeriamogli sagrificio di lagrime e di sospiri, offeriamogli disonestà di adulterj e corruzione, e mandiamogli le corone della nostra disonestà.
CAPITOLO XXII.
Deianira, moglie d’Ercole.
Deianira, secondo che alcuni affermano, fu figliuola di Oeno, re di Etolia, e sorella di Meleagro, e fu famosa di tanta bellezza, che per averla per moglie combattè Ercole e Acheloo: la quale essendo rimasa a Ercole, fu amata da Nesso Centauro. E portando quella Ercole di Calidonia nella sua patria, ritenuto dall’Ebeno, fiume di Calidonia, cresciuto per piova, vennegli incontro Nesso amante: perchè egli era cavallo proferissi, a Ercole di servirlo per portare Deianira oltre al fiume. Al quale avendo Ercole data la moglie, acconciandosi a notare, quegli quasi contento di suo desiderio, avendo già passato il fiume, con la sua mazza cominciò a fuggire. E non potendo Ercole seguirlo coi piedi, giunselo con una saetta avvelenata del sangue Lerneo. Lo quale veleno sentendo Nesso, pensando non potere campare, incontanente diede a Deianira la sua camicia insanguinata del suo sangue; affermando, che se ella la mettesse indosso a Ercole, quella ritrarrebbe lui d’ogni altro amore al suo. Deianira semplice, tolta la veste per un grande dono, per alcuno spazio di tempo servò quella nascosamente a Ercole; e amando egli Iole mandogliela cautamente per Lieo suo servo. Quegli mescolando quel sangue al sudore, entratogli per li pori, entrò in rabbia, sì che di propria volontà si gittò nel fuoco. E così Deianira vedendosi fare vedova di sì grande marito, isperando trarlo al suo amore, perdello, e eziandio vendicò la morte di Nesso.
CAPITOLO XXIII.
Iocasta, Reina di Tebe.
Iocasta, reina di Tebe, fu più famosa per le sue scienze, che per le sue opre e per lo suo regno. Questa certamente avendo avuta famosa origine dai primi edificatori di Tebe, fu maritata a Lajo, re de’ Tebani, essendo ella vergine; e del quale essendo gravida d’un figliuolo, per un’avversa risposta d’augurio cha ebbe Lajo, comandò che il partorito figliuolo fosse dato alle fiere; la qual cosa ella fece gravemente: e pensando quella, che fosse divorato incontanente, fu nutricato per figliuolo appresso al re di Corinto. E già venuto in perfetta età, uccise Lajo presso i Focosi; e quella rimasta vedova, e non conoscendo il figliuolo tolse quello per marito, e di quello ebbe due figliuoli Eteocle e Polinice, e altrettante figliuole, cioè Ismena ed Antigona. E parendo felice sì per lo regno, e sì per la prole, per risposta degli Dei conobbe essere suo figliuolo quello che essa pensava essere suo marito. La qual cosa, benchè ella portasse gravissimamente, egli portò tanto più gravemente, che, desiderando morire per lo commesso peccato, cavossi gli occhi, e abbandonò lo regno, il quale presono i figliuoli con discordia: e rotti fra sè i patti, vennero a guerra; e benchè spesse volte venissero a battaglia insieme, con grande tristizia di Iocasta, finalmente ella gli ricevette morti, combattendo amendue soli. Del quale dolore impaziente la misera madre e avola, benchè ella vedesse Creonte suo firatello già re, vedendo quello che era suo marito e figliuolo in esilio e cieco, e Antigona e Ismena, figliuole già intrigate sull’avversa fortuna, fatta già vecchia, cacciò fuori collo ferro l’anima istanca per li mali e facente resistenzia, e finì con la vita le fatiche. Sono nondimeno alcuni che dicono, che ella non potè sì lungamente comportare i suoi nocivi errori; ma com’ella vide Edipo cavarsi gli occhi, incontanente s’uccise.
CAPITOLO XXIV.
Amaltea, chiamata Deifoba.
Amaltea, chiamata Deifoba, dicono, che ella fu figliuola di Glauco. Credono che fusse l’origine di quella da Cuma di Calcis, antica terra di Campagna. Ed essendo stata quella una delle Sibille, credasi, che ella fosse al tempo del guasto di Troja, e che ella vivesse sì lungo tempo, che alcuni pensano che ella arrivasse insino al tempo di Tarquiqio Prisco. E fu la verginità appresso di questa di tanto pregio, per la testimonianza d’alcuni, che in lungo spazio di tempo non comportò essere toccata d’alcuno uomo. E benchè le scritture dei poeti dicano, quella essere stata amata da Febo, e per dono di quello avere ottenuto di vivere lungo tempo, e avere saputo indovinare, io certamente penso, che per merito della verginità ella abbia ricevuto il lume, per lo quale ella predisse, e scrisse molte cose future, da quel Sole vero, il quale allumina ogni uomo, che viene in questo mondo. E dicesi che ella sopra lo lido di Baia presso Averno ha uno maraviglioso tempio, lo quale io ho vedutole ho udito che da lei serva il nome insino a questo tempo. Il tempio, benchè sia consumato per lunga vecchiezza, e per negligenza sia mezzo caduto, eziandio così rovinato conserva l’antica maestà, e fa maravigliare quegli che guardano la sua grandezza. Sono alcuni che dicono, che fuggendo Enea, ella gl’insegnò la via, e fu sua guida allo ’nferno; la qual cosa io non credo: ma di questo diremo altra volta. Quegli che dicono che ella visse per molti secoli, affermano che ella venne a Roma a Tarquinio Prisco, e portogli nove libri, de’ qnali ne arse tre in sua presenza, non volendogliene dare il pregio che ella gli domandava; e domandogli il dì seguente quel pregio che prima aveva voluto di nove, affermandogli che se non glielo desse subito, arderebbene tre, e lo dì seguente, gli altri tre; di che egli diede lo dimandato pregio. Gli quali libri dappoi conservati furono trovati tutte contenere le fatiche de’ Romani. Per la qual cagione dappoi i Romani servarono quegli con gran diligenza, e secondo che richiedeva lo bisogno di consigliare di cose future, correvano a quegli come ad un tempio. E non è infatti cosa a credere che questa e Deifoba fosse una medesima cosa: e quella, abbiamo letto, che morì in Cicilia, e in quel luogo per lungo tempo fu mostrata la sepoltura per gli abitanti. Dunque per istudio e divina grazia diventiamo famosi, la quale non è negata ad alcuno che se ne faccia degno; e se noi stiamo pigri e accidiosi dopo nostra natura, eziandio vecchi andiamo ignoranti alla sepoltura. E finalmente se le femmine sollecite per ingegno o per industria o per divinità sono valenti, che si dea pensare delli miseri uomini li quali hanno attitudine a tutte le cose? se eglino cacciano la viltà dell’animo, certamente arrivano a quella Deità. Piangano dunque e avviliscano quegli i quali per la pigrizia perdono si gran bene; e confessino, sè essere pietre animate tra gli uomini; la qual cosa sarà, confessando egli senza lingua lo suo peccato.
CAPITOLO XXV.
Nicostrata, chiamata Carmenta.
Nicostrata, la quale poi fu chiamata Carmenta in Italia, fu figliuola di Iano, re d’Arcadia, e secondo altri fu sua nuora. E non fu solamente maravigliosa di reame, ma fu ammaestrata in litteratura greca; e fu di sì sottile ingegno, che con sollecito studio imperò infino all’arte del vaticinio, intanto che diventò famosa indovina; la quale usata alcuna volta da sè medesima manifestare in versi cose future, fu domandata dai Latini Carmenta, quasi tolto via il primo nome di Nicostrata. E questa fu madre d’Evandro, re d’Arcadia, il quale, si dice per le favole degli antichi, essere stato figliuolo di Mercurio, o che sia perchè egli fu pronto e eloquente, o che egli fu sagace. Il quale, secondo che dicono alcuni, perchè a caso egli aveva morto il suo vero padre, o che fusse (secondo che piace ad alcuni altri) per altra cagione nata discordia fra i suoi cittadini, fu cacciato del regno de’ suoi passati. E confortandolo Carmenta sua madre, e promettendogli per augurio gran cose, se egli andasse a quel paese che ella gli mostrasse, in compagnia di lei entrò in nave con parte de’ suoi popoli, e con prospero vento dal Peloponneso per guida di sua madre arrivò al porto del Tevere, e posesi al monte Palatino, il quale dal nome di suo padre ovvero di Pallante suo figliuolo chiamò Palatino. E trovando Carmenta gli abitatori del luogo quasi uomini salvatichi, benchè già innanzi per industria di Saturno, fuggito di quel luogo, avessero apparato a seminare le biade; guardando quegli non avere alcuno uso di lettere, ovvero poco, e quello di lettere greche; e considerando con la divina mente quanta fama restasse a quel luogo e a quella regione, pensò che fusse indegna cosa che i suoi gran fatti fussero mostrati con aiutorio di lettere d’altra gente, per li tempi futuri e con tutta forza di suo ingegno si convertì a dare a quegli popoli proprie lettere, e al postutto diverse dalle altre nazioni: alla quale impresa non mancò Dio; per la cui grazia avvenne che, trovato da quella nuove lettere, secondo lo volgare d’Italia, insegnò come quelle si dovessero giugnere insieme, contenta solamente di sedici lettere, come per innanzi Cadmo, edificatore di Tebe avea trovato a’ Greci, le quali noi insino a qui tegniamo per doni di quella, e chiamiamo Latino, benchè alcuni altri savi ci ebbero aggiunte alcune altre utili, non mutando alcuna delle prime: questa invenzione parve tanto maravigliosa, che certamente i grossi uomini credettero quella non essere stata femmina, ma piuttosto Dea. Per la qual cagione avendo onorata quella in vita con divini onori, poichè ella morì, edificarono un tempio sotto suo nome nella infima parte del monte Campidoglio, ove ella era venuta; e per fare perpetua la sua memoria dal suo nome chiamarono i luoghi vicini Carmentali. La qual cosa dopo Roma, fatta grande, non comportò che fusse tolta via; che anzi chiamarono una porta, fatta per necessità da’ cittadini, per molti secoli porta Carmentale per lo nome di Carmenta. Italia fu già innanzi all’altre regioni famosa per molte proprietadi, e quasi splendida di celestiale luce: nè fu cercata la sua chiarezza solarmente nella sua parte; perchè d’Asia vennero le ricchezze e gli ornamenti reali, la nobiltà venne primieramente da’ Troiani (benchè i Greci l’accrescessero molto), l’aritmetica e geometriche arti vennero d’Egitto, da’ sopraddetti Greci venne la filosofia, la eloquenza, e quasi ogni arte meccanica: l’agricoltura, ancora conosciuta da pochi, Saturno bandeggiato la insegnò, lo falso coltivare degli Iddii venne da’ Toscani e da Numa Pompilio; le pubbliche leggi vennero primamente d’Atene, dappoi fecele lo senato, e gl’imperadori; lo sommo sacerdozio, e la perfetta religione diede Santo Pietro; la disciplina militare fu trovata dagli Romani, con la quale per la fortezza dell’armi e degli uomini per intera carità verso la repubblica acquistarono la signoria di tutto il mondo; le forme delle lettere, assai è manifesto, per quello che è detto, che Carmenta le trovò a’ nostri antichi, poichè ella venne d’Arcadia. E poi fu creduto che ella desse la prima invenzione della grammatica, la quale in processo di tempo i passati fecero più abbondevole; ai quali Dio fu sì favorevole, che gran parte di sua gloria fu tolta alle lettere ebraiche e alle greche, e a tutta Europa quasi uscirono per ampio spazio le nostre lettere; per le quali sono iscritti infiniti volumi in ogni scienza de’ fatti degli uomini, e dei gran fatti di Dio, conservati a perpetua memoria degli uomini, acciocchè noi conosciamo per aiutorio di quelle cose che noi non potemmo vedere. Con queste mandiamo i nostri prieghi e conservamoli con l’altrui risposte; queste descrivono a noi Iddio, secondo che si può fare; queste disegnano lo cielo, la terra e il mare, e tutti gli animali; e non è alcuna cosa che per quella chi vole non possa imparare. E brevemente per opera di quelle, che per ampiezza dalla mente non si può comprendere ed ottenere, fidatissimamente si comanda a sua guardia. Le quali cose, benchè alcune convengono ad altre lettere e lingue non per questo è menomata alcuna cosa commendabile alle nostre. Finalmente di così nobili virtudi alcune n’avemo perdute, alcune n’avemo date, e alcune ancor tenemo, almeno piuttosto per lo nome che per l’effetto. E comechè sia adoperato dell’altre cose dalla fortuna, o per lo nostro difetto, non ha potuto torre sì maravigliosa e sì opportuna gloria alla nominanza d’Italia nè la ruberìa de’ Tedeschi, nè il furore dei Gallici, nè le cautele degli Angli, nè la ferocità degli Spagnoli, nè i barbari d’alcun’altra generazione col loro assalto: sicchè mai egli dicessero, e ardiron di dire, che per la loro virtù fussero trovate le prime lettere, e molto meno che eglino trovassero le grammatiche; le quali come noi abbiamo trovate, così gliele dessimo mai sempre disegnate col nostro vocabolo. Onde addiviene, che quanto più sono portate da lungi, tanto più sono ampliate le lodi del nome latino, e gli onori; e più chiaro fanno la testimonianza dell’antichissimo onore, nobiltà, e ingegno; e serbano incorrotto argomento di nostra sottilità, eziandio con la indegna azione dei barbari: della quale singolare gloria, benchè noi dobbiamo rendere grazie a Dio che l’ha date, nondimeno siamo tenuti a Carmenta di molta lode, carità e fè. Per la quale pietosa cosa è, che noi la magnifichiamo a nostro potere in eterna memoria, acciocchè d’alcuni non siamo reputati.
CAPITOLO XXVI.
Procri, moglie di Cefalo.
Procri di Pandione, re d’Atene, moglie di Cefalo, figliuolo del re Ealo, come fu odiosa alle oneste donne per avarizia, così è piaciuta agli uomini, poichè per lei è manifesto il vizio dell’altre donne. Amandosi quella col suo marito, insieme vivendo di pietoso e nuovo amore, avvenne per isciagura di quegli, che di Cefalo s’innamorò una donna chiamata Aurora, la quale era di singolare bellezza; lo quale lungamente quella donna tentò indarno, essendo quello sommamente preso dall’amore di Procri, sua moglie, di che quella sdegnata disse: Cefalo, tu ti pentirai d’avere amato sì caldamente Procri tua, e troverai, se se ne sarà fatto pruova, che ella amerà più i danari che te. La qual cosa udendo il giovane, cupido di tentarla, mostrò di volere andare in un lungo viaggio, e partissi; e piegando la via, tornò nella patria; e per messi tentava la fermezza della moglie con doni, i quali comechè fussero grandi, nel primo assalto non la puoterono muovere. Ma perseverando, ed aggiugnendo gioje, piegò si l’animo di quella la quale già vacillava, che promise dare albergo allo desiderato piacere dello amante se gli desse i promessi doni. Allora Cefalo ismarrito per lo dolore si manifestò, poichè conobbe per lo inganno lo debole amore di Procri. La quale vergognata, e percossa dalla coscienza del fallo, subito si fuggì per le selve, e diessi a vivere in solitudine. Il giovane impziente all’amore di quella, di propria volontà perdonando a quella, coi prieghi la ritornò a sua grazia, repugnando quella; ma niente montò, perchè la forza del perdonare non è sufficiente contro ai morsi della coscienza. Procri si moveva in diverse mutazioni d’animo, e toccata d’amore pensò che suo marito contro lei, quello, per lusinghe dell’altr’amante facesse, la qualcosa quella aveva mercatato con lui con monete; cominciò nascosamente seguire quella, cacciando egli per le montagne, per gli gioghi e per le nascose valli. La qual cosa durando, avvenne, che stando Procri nascosamente in un’erbosa valle, tra le canne del padule, movendosi, lo marito, credendo che fusse una fiera, ferilla con una saetta. Non so che io dica piuttosto, o se l’oro è la più possente cosa che sia in terra, o se è più stolta cosa cercare quello che l’uomo non vuole trovare. Dalle quali due cose approvando ciascuna la stolta donna, trovò a sè perpetuale infamia, e la morte, la quale non cercava mai. Acciocchè io non taccia lo smemorato amore dell’oro, per lo quale si muovono quasi tutti gli stolti, domando quegli che sono presi di sì ostinata gelosia; mi dichino che utilità o che onore egli sentono, che gloria o che onore acquistano? A mio parere, questa è dispregiata infermità della mente, la quale ha principio dalla pusillanimità di quello che la soffre, poichè noi non la vediamo se non in quegli, i quali si estimano di sì piccola virtù, che lievemente concederebbero che ciascuno gli fusse da mettere innanzi.
CAPITOLO XXVII.
Argia, figliuola del Re Adrasto.
Argia fu una donna di Grecia, la quale ebbe nobile origine degli antichi re d’Argo, e fu figliuola del re Adrasto; la quale come ella diede per la maravigliosa sua bellezza alla sua età lieta presenza, così lasciò a quegli che seguissero integra testimonianza, e famosa e perpetua del matrimoniale amore: per la qual cosa infino a’ nostri dì è pervenuta la sua nominanza chiara e splendida. Questa adunque maritata a Polinice, figliuolo d’Edipo, re di Tebe, essendo lui in esilio, di lui avendo partorito Tessandro; considerando il padre, stimolato di mordaci pensieri per lo inganno dei suoi fratelli, partecipe delli pensieri, priegò lo padre già vecchio non solamente con pianto, ma lo indusse ad arme contra Eteocle, lo quale contro le leggi de’ patti con suo fratello teneva con tirannia lo regno di Tebe; e acciocchè ella non ricevesse per fatale risposta nocumento di sorte, cortese oltre alla natura delle donne, diede volontariamente a Euridice, moglie di Anfiarao astrolago, lo prezioso giojello, lo quale per lo tempo passato era stato isventurato alle donne di Tebe. Per la qual cosa Anfiarao che era nascosto fu manifesto, e andò a Tebe, ma con ria fortuna; perchè dopo molte battaglie, essendo morti gli altri principi, e Adrasto essendo rimaso ignudo di aiutorio, e quasi in fuga e vedendo Argia che il corpo di Polinice era rimasto non seppellito tra gli altri corpi dei popolari, subito, piena di ansietà, non considerata sua nobiltà, l’onore del matrimonio, nè la debolezza di femmina, con piccola compagnia entrò in cammino per andare al campo: e non la ritennero gl’insidiatori dal cammino, nè le fiere, nè gli uccelli, i quali seguitano i corpi morti, nè le anime che volano intorno, secondo che pensano gli stolti, e (che era di maggior paura) non la ritenne il comandamento di Creonte, lo quale era, che niuno s’atterrasse niun corpo sono pena capitale. Anzi andò con ardente e tristo animo di mezzanotte nel campo ov’errano quegli corpi morti e volgendo questo e quello puzzolente; acciocchè con un piccolo lume ella riconoscesse la faccia che già cascava dello amato marito, non cessò finchè ella non trovò quello che ella cercava. E fu maraviglia che la faccia già mezza consumata della ruggine dell’armi, pallida e bagnata dal corrotto sangue; e che per certo già non sarebbe stata conosciuta da alcuno, non potè stare nascosta all’amante moglie; e non potè la bruttezza del guasto volto rimuovere i baci, nè il comandamento di Creonte non potè ritenere li baci, nè le lagrime, nè il fuoco. E spesse volte avendolo baciato per la bocca, e con le lagrime avendo lavato le puzzolenti membra, e spesso rivoltosselo in braccio, lamentandosi, acciocchè non lasciasse alcuna cosa di pietoso ufficio, poselo a ardere, e arso quello corpo, ripose la cenere in uno vase; e manifestato lo fuoco nel fatto, non temè la morte, nè la prigione del crudele. Molte donne hanno ispesso pianto le infermità dei mariti, la prigione, la povertà e la ria fortuna, durando la speranza di tornare a più benigna fortuna, e tolto via la paura della più crudele. La qual cosa benchè paia lodabile, non si può dire che sia pericolosa a segno d’amore, come si possono dire le cose che fè Argia. Questa andò nel campo de’ nemici, potendo piangere a casa; trovò lo ferito corpo, lo quale si poteva trovare per altrui mani; col fuoco fece lo reale onore, potendo sotterrare nascosamente, considerata la condizion del tempo, bastava; ella fece lo pianto, dove ella poteva passare tacendo; e non aveva che sperasse, morto lo marito in esilio, ma aveva onde ella temesse lo nimico, così l’avea confortato lo vero amore, la fè intera di santità del matrimonio, e conservata castità. Per le quali cose Argia degnamente dee essere lodata e onorata, e magnificata con chiara nominanza.
CAPITOLO XXVIII.
Manto, figliuola di Tiresia.
Manto, figliuola di Tiresia, somma in divinazione a Tebe, fu famosa al tempo di Edipo re, e de’ figliuoli. Questa, sotto magistero di suo padre, fu di pronto e di sì grande ingegno, che ella imparò nobilmente Piromanzia, trovata prima dai Caldei, e secondo alcuni da Nembrotto, intanto che al suo tempo niuno conosceva meglio lo movimento delle fiamme, lo calore e il mormorare delle quali dicono che sono dimostrazioni nelle cose future: non so per che diabolica opera ancora che conobbe con sottile guardare le vene delle pecore, le interiora di ciascuno animale. Secondo che fu creduto ispessissime volte con sua arte convocò i spiriti maligni, e le anime dello Inferno, dare voce e rispondere a quelli che domandavano. E certo essendo già morti nelle battaglie i re dei Greci, che assediavano Tebe, e avendo Creonte presa la signoria della terra, questa, secondo che piace ad alcuni, si partì, e andò in Asia, fuggendo lo nuovo re. In quel tempo e luogo edificò lo nuovo tempio, famoso per augurj del Clarico Apollo, e partorì Mosso, glorioso astrologo al suo tempo, benchè gli antichi non ne scuopron di chi ella lo generasse. Ma alcuni hanno detto altrimenti, e dicono, che dopo la guerra di Tebe ella con molti dei suoi andò per lungo spazio errando, e finalmente arrivò in Italia; e che in quella generò e partorì d’uno chiamato Tiberino uno figliuolo, lo quale fu chiamato Citeone, altri dissono Bianore. E dappoi pervenne in Gallia Cisalpina, dove trovando luoghi paludosi, forti per sua natura al lago Benaco, acciocchè ella potesse vacare più liberamente ai suoi maleficj, ovvero condurre lo resto di sua vita con più sicurtà nel mezzo della palude, pose sua sedia in la terra levata dall’acqua; e dopo, alcuno tempo in quel luogo morì e fu seppellita. Alcuni dicono che suo figliuolo edificò una città, e per nome di sua madre la chiamò Mantova. Alcuni pensano, che ella infino alla morte con fermo proposito conservò verginità. E era certamente famosa e santissima opera, e sommamente laudabile, se ella non l’avesse bruttata con le sue scellerate arti, e se ella l’avesse salvata al vero Iddio, al quale si dee conservare la verginità.
CAPITOLO XXIX.
Delle donne de’ Compagni di Jason.
Noi non sappiamo lo numero, nè i nomi delle donne de’ Menj; o che sia per la pigrizia di quei che scrissero al suo tempo, o che sia per difetto della lunghezza del tempo, è indegna cosa; avendo meritato quelle grandissima lode di gloria per grandi opere. Ma poichè così è paruto alla odiosa fortuna, isforzerommi, con quanta arte potrò, redurre quelle nominate, a mio potere, con degna lode alla memoria di quegli che verranno drieto, come quelle che bene l’hanno meritato. Dunque i Menj furono de’ compagni di Jason, e degli Argonauti giovani famosi di non piccola nobiltà, i quali compiuta l’andata di Colco, tornati in Grecia, lasciata la loro antica patria, elessero loro sedia appresso i Lacedemonj; dai quali non solamente fu concesso la cittadinanza a quegli amorevolmente, ma furono ricevuti tra i Senatori i quali reggevano la Repubblica. Della quale splendida cortesia i successori non ricordandosi, ardirono, volere sottomettere per sè la pubblica libertà a vituperosa servitù. Furono in quel tempo ricchissimi giovani, e non solamente famosi per sua virtù, ma eziandio circondati di doppia chiarezza per li parentadi de’ nobili Lacedemonj e intra le altre cose avevano bellissime donne, le quali erano nate de’ nobili cittadini. E certamente non è l’ultima parte dell’onore del mondo; al quale onore s’accostavano grandi sette, per le quali non sentivano l’amistà della patria pubblicamente, ma, appropriandola a’ suoi meriti, montarono a tanta matteria, che pensarono, dovere essere messi innanzi agli altri: di che egli caddero a cupidità di signoria, ed a questo posero sua forza ad occupare la Repubblica presuntuosamente. Per la qual cosa, scoperto lo peccato, furono presi, e messi in prigione per l’autorità della Repubblica, furono sentenziati a pena capitale, come nemici della patria. E dovendo loro essere data la morte da’ manigoldi, la seguente notte secondo l’usanza de’ Lacedemonj, le loro donne triste e piangendo, per deliberazione de’ mariti pigliarono questo consiglio, e secondo lo pensiero non indugiarono; ma fatto sera, in oscure vestimenta, con la faccia coperta e piena di lagrime andavano alle prigioni per vedere i mariti. Lievemente fu loro conceduto dalle guardie andare a quegli, perchè erano gentili donne. Ai quali essendo arrivate, non si spese il tempo in lagrime e in pianto; ma subito, manifestato lo suo consiglio a’ mariti, mutate le vesti, imbendati quegli a modo di femmine, piangendo e cogli occhi bassi a terra, mostrando tristizia, aiutandogli l’oscurità della notte, e la reverenza, perchè erano nobili donne, ingannando le guardie, misono fuori quegli che dovevano morire, rimanendo elleno in luogo di quei dannati: e non fu conosciuto l’inganno infino che andando i manigoldi per fare morire i dannati, trovarono le mogli in luogo de’ mariti. E per certo fu grande e singolare amore delle donne. Ma lasciamo le beffe e l’inganno contro alle guardie, che fu salute de’ dannat; e che sia partito a’ Padri, e che sia seguito. E primieramente contemplarne alquanto la forza del matrimoniale amore, e l’ardire di quelle donne. Alcuni dicono, che non è più mortale odio, che quello delle discordie delle mogli, essendo che fermate in nodo indissolubile, secondo antico ordinamento di natura; e così quando elle convengono co’ loro mariti, lo suo amore passa tutti; perchè scaldato dal fuoco di ragione non arde istoltamente, ma scalda con piacere e scalda di tanta carità, che sempre vogliono e non vogliono pazientemente; e lo amore usato a sì piacevole unità non lascia alcuna cosa contro la sua conservazione, e non fa alcuna cosa pigramente e freddamente: e se la fortuna è contraria, di propria volontà sottentra alle fatiche e a’ pericoli; e con socia sollecitudine alla salute pensa e delibera; trova i rimedj, e fabbrica gl’inganni, se la bisogna il richiede. Questo, soavissimo e già formato con piacevole vivere, sospinse gli animi delle donne de’ Menj con tanto furore, che elle trovarono quegli inganni, i quali non avrebbono potuto vedere innanzi: nel pericolo de’ mariti, struggendo le forze dell’ingegno, apparecchiarono gl’istrumenti, e l’ordine delle cose che avevano a fare, acciocchè elle ingannassero le guardie accorte e aspre; e rimossa la oscurità de’ sensi, pensarono che niuna cosa si dee lasciare per la salute di quello che noi amiamo; e cercata la pietà nell’intimo segreto del cuore, acciocchè elle traessero i mariti del pericolo, con presuntuoso ardire entrarono in quello, acciocchè il casto amore delle mogli assolvesse quegli che parevano esser tenuti da duro e capitale supplicio, traendogli delle mani de’ manigoldi. E queste, che parve grandissima cosa, beffata la possanza delle leggi per pubblico decreto e autorità del Senato, e ingannata tutta la volontà della città, acciocchè compiessero quello che elle desideravano, non temerono rimanere serrate sotto la signoria delle ingannate guardie in luogo dei dannati. E certamente io non sono sufficiente ad ammirazione di così pura fede, di così integro amore. Per questo ho per fermo, se elle avessero amato temperazione, e fossero state congiunte a quelli con sottile legame, sarebbe stato lecito a quella stare pigre in ozio a casa loro, e non arebbono queste fatto sì fatte cose. E acciocchè con poche parole io conchiuda molte cose, ardisco affermare, queste essere stati veri e certi uomini, e quegli giovani Menj essere state le femmine che faceano quella finzione.
CAPITOLO XXX.
Pantasilea, Reina delle Amazzoni.
Pantasilea fu reina delle Amazzoni, e cedette nel regno ad Antiope e Oriti; ma nondimeno chi fusse suo padre o sua madre, non l’ho letto. Dicesi che questa, spregiata sua bellezza e morbidezza del corpo, cominciò a vestirsi l’arme delle sue passate, e ardiva coprire con l’elmo i biondi capegli, cingersi lo turcasso, e a modo di cavaliere e non di femmina montar suso il carro e il cavallo, e oltre all’altre reine mostrarsi maravigliosa di potenzia e di magisterio. Alla quale non essere mancato ingegno, è manifesto; perchè si legge, che insino al suo tempo non era in oso portare la mannaia per arme. Questa, secondo che piace ad alcuni, udito la prudenza di Ettore Trojano, non avendolo veduto, lo amò ardentemente e desiderando lasciare dopo sè nel suo regno di gloriosa schiatta successori, mossa volentieri, venne in aiutorio di quello contro a’ Greci a sì grande impresa con grandissima moltitudine delle sue. E non s’intimorì per la chiara nominanza de’ principi Greci, che ella desiderando più piacere a Ettore con l’armi e con la prodezza, che con la bellezza, ella ispessissime volte non entrasse nella battaglia degli stretti combattitori, e alcuna volta abbatteva i nemici con la lancia, e colla ispada si faceva la via tra quegli che facevano resistenza, e spesse volte incalzando le schiere con l’arco, essendo una donna, faceva maravigliare Ettore che stava a vedere. E finalmente combattendo un dì questa valente donna fra gli stretti nemici, e oltre a usanza mostrandosi degna di sì grande amante, essendo già morte molte delle sue, ricevuto il colpo della morte, miserabilmente cadde in mezzo de’ Greci, che ella avea gittati per terra. Alcuni dicono, che ella arrivò a Troja dopo la morte di Ettore, e in quel luogo, secondo che scrivono, quella essere stata morta combattendo aspramente. Alcuni si potrebbono maravigliare, che femmine ardissero di correre a’ nemici e uomini, come che elleno fussero armate, se non che cessa l’ammirazione, perchè l’usanza si converte in altra natura, per la quale queste cose e simili, e molto maggiori siano fatte da quella in fatto d’arme, che da quegli, i quali la natura ha fatti maschi: l’ozio, le delicatezze gli hanno convertiti in femmine, ed in lepri che portano elmo.
CAPITOLO XXXI.
Polissena, figliuola del re Priamo.
Polissena, vergine figliuola di Priamo, re di Troja e di Ecuba: giovanetta fu di sì fiorita bellezza, che potè infiammare l’aspro petto d’Achille, figliuolo di Peleo, e per fraude d’Ecuba sua madre potè ridurre quello a morte, venendo egli solo di notte nel tempio d’Apollo Timbreo. Per la qual cosa non indebitamente fu morta, essendo perita la forza de’ Trojani, e guasto Ilion: ella fu menata da Neottolemo alla sepoltura di suo padre per purgazione dell’anima di quello; e in quel luogo, se noi dovemo dare fede alle scritture de’ passati, veduto l’altero giovane tenere il coltello ignudo, piangendo quegli che stavano d’intorno ella innocente, con costante animo e con sicuro volto porse la gola; sicchè ella non mosse meno gli animi per ammirazione di fortezza, che per pietà di lei che pativa. E certamente fu grande cosa, e degna di ricordanza, che ella di tenera età, di bellezza d’una femmina, di dilicatezza reale, mutazione di fortuna non abbia potuto soperchiare lo grande animo di una fanciulla; e che ella sia stata forta sotto la spada del nimico, sotto la quale alcuna volta dubitano, e spesse volte mancano gli animosi petti di nobili uomini. E crederò lievemente, questa essere stata opera di nobile fortuna, che con questo disprezzare di morire mostrasse, che femmina la fortuna avrebbe prodotta se il nimico non l’avesse sì tosto ispacciata.
CAPITOLO XXXII.
Ecuba, Reina de’ Trojani.
Ecuba, reina de’ Trojani, fu similmente lume grandissimo del perire di prosperità, fu certissimo ammaestramento di miserie. Questa, secondo alcuni, fu figliuola di Dimante Aone: alcuni vogliono, questa essera stata figliuola di Cifeo, re di Tracia, la qual cosa io medesimo penso, perchè i più pensarono così. Questa vergine fu moglie di Priamo, re nobilissimo de’ Trojani, e di quello mischiatamente generò e partorì diciannove figliuoli; tra i quali fu quel singolare rimedio, e splendore della gagliardia dei Trojani, Ettore, lo quale ebbe tanta chiarezza di fama, che non solamente egli fece famosi eternalmente i suoi passati, ma la sua patria d’eterna gloria. Ma non fu tanto famosa per felicità del regno, e per chiarezza de’ molti figliuoli, che anzi soperchiando l’avversa fortuna, fu conosciuta a tutto il mondo. Ella pianse con grandissima tristizia Ettore suo figliuolo, e Troilo, giovinetto ardito più che non era la sua forza, i quali furono morti per le mani di Achille, e in quella morte cadde quasi la ferma colonna del regno. E così ella miserabile vide Paris morto da Pirro, poi Deifobo, al quale prima furono tagliate le orecchie e il naso, poi vituperosamente morto, Ilion essere arso dal fuoco de’ Greci; Polite essere tagliato in grembo al padre; e Priamo medesimo vecchio innanzi agli altari della propria casa essere scannato; Cassandra, sua figliuola, Andromaca sua nuora, e sè medesima andare per ischiave de’ nemici; Polissena, essere scannata innanzi la sepoltura d’Achille; e Astianatte suo nipote, tratto del luogo nascoso, essere abbattuto ad un sasso; e ultimamente in su lo lito di Tracia trovò seppellito Polidoro suo figliuolo, giovanetto morto per fraude di Polinestore, e in quel luogo lo pianse. Per li quali, e sì grandi dolori e tanti, dicono alcuni, che ella diventò rabbiosa; e che andava urlando a modo di cagna per li campi di Tracia: e così dicono, quella essere morta e seppellita nel lito d’Elesponto in un monte chiamato Cynosenia. Alcuni dicono che ella fu menata da’ nimici in servitù con l’altre: e acciocchè non le mancasse alcuna particola di miseria, vide ultimamente, dopo la morte di Agamennone, uccidere Cassandra per comandamento di Clitennestra.
CAPITOLO XXXIII.
Cassandra, figliuola di Priamo.
Cassandra fu figliuola di Priamo, re di Troja: e questa, secondo che affermano alcuni, ebbe scienza d’augurj acquistata per istudi, ovvero per dono di Dio, ovvero piuttosto per diabolico inganno: ma questo non è assai certo. Nondimeno è affermato da molti, che molto innanzi ch’Elena fusse rubata per l’andata di Paris, più volte predisse con chiare parole la venuta d’Elena, lo lungo assedio di Troia, ultimamente la morte di Priamo, e la disfazione d’Ilion: e per questo non essendo credute sue parole dal padre, dicesi, che i frategli la gastigavano con busse. E da questa fu fatta finzione d’una favola: cioè, che ella era amata da Apollo, e richiesta in suo adulterio; il quale, dicono che ella gli promise, se egli innanzi le desse scienza del futuro: avendola ricevuta, negando la promessa, e Apollo non potendole torre quello che le avea dato, dicono, che egli giunse al dono, che niuno credesse quello che ella dicesse: e così avvenne, che suo detto era creduto come di una matta. E questa isposata a nobile giovane chiamato Corebo, perdè quel marito per la guerra, innanzi che ella lo menasse a suo matrimonio. E finalmente nella preda di Troja toccò per serva ad Agamennone, al quale, menandola a Micene, predisse la morte, e gli agguati apparecchiati contro di lui da Clitennestra. Alle cui parole non essendo data fede, dopo molti pericoli arrivò a Micene; e Agamennone pel tradimento di Clitennestra fu morto, e ella ancora fu morta di comandamento di Clitennestra.
CAPITOLO XXXIV.
Clitennestra, Reina di Micene.
Clitennestra fu figliuola di Tindaro, re di Oebalia e di Leda, e fu sorella di Castore e di Polluce e di Elena: essendo vergine fu maritata ad Agamennone, re di Micene: la quale benchè per sua nazione fusse assai conosciuta, e per lo marito, diventò più famosa per suo scellerato ardire. Perchè signoreggiando Agamennone suo marito l’oste dei Greci presso Troja e avendo ella già avuti più figliuoli, innamorossi di Egisto, ozioso e vile giovane, figliuolo di Tieste e di Pelopia; lo quale perchè era sacerdote, non era andato all’oste. E, secondo che alcuni hanno detto, per conforto di Nauplio vecchio padre di Palamede commise adulterio con Clitennestra. Del quale peccato seguì che quell’animosa donna, con armato animo a tradimento, e presuntuoso ardire si levò contro al marito; o che ella il facesse per lo timore del commesso peccato, tornando Agamennone, o che ella il facesse per conforto del adultero, o per cupidità del regno, o che fusse per indignazione; menando egli Cassandra a Micene, ricevè quello in casa con infinta allegrezza di volto e tornando egli vincitore di Troja, stanco del navigare, e delle fortune, e egli già a caso bagnato di vino, fecelo ammazzare allo adultero, lo quale ella teneva in agguato. Sia alcuni altri dicono, che essendo egli impacciato dalle vestimenta della vittoria, quasi come egli fosse piacevole alle Greche nella festa, l’adultera moglie lo confortò, che egli si vestisse le vestimenta della patria, e quelle che gli avea lavorate a questo fine, essendo quelle senza collare, ella gliele porse; e avendogli messe già le maniche, e mezzo avviluppatolo, fu tenuto da quella, confortando ella lo adultero ucciditore; e così non vedendo egli da chi, fu ammazzato. La qual cosa come ella fu fatta, ella prese lo regno, e con Egisto adultero insieme signoreggiò sette anni. Ma in quel mezzo sendo cresciuto Oreste, figliuolo d’Agamennone di quella, lo quale ascosamente gli amici avevan salvato del furore della madre; e avendo quello preso animo a vendicare la morte del padre, prese tempo, occise quella e l’adultero. E non so quale io biasimi più o lo peccato o l’ardire. Lo primo, che fu grandissimo male, non era meritato dal valentissimo uomo; lo secondo quando meno liceva alla perfida donna, tanto è più abbominabile. E nondimeno io ho da lodare la virtù d’Oreste, la quale non potè portare lungamente, essere ritenuto dalla pietà della scellerata madre; che egli non ponesse l’animo a vendicare la indegna morte di suo padre, la quale avea sofferto dallo adultero sacerdote per comandamento della scellerata femmina. E, sparto il sangue di quegli, per lo comandamento e opera de’ quali era stato sparto, il sangue di suo padre fusse purgato; acciocchè lo peccato tornasse contro agli adulteri.
CAPITOLO XXXV.
Elena, moglie di Menelao.
Elena, secondo che è parato a molti, conosciuta al mondo sì per la sua lascivia, come per la lunga guerra che seguì per quella, fu figliuola di Tindaro, re di Cibalia, e di Leda, bellissima donna; e fu moglie di Menelao, re di Lacedemonia. E, secondo che dicono tutti gli antichi Greci, e dopo quegli i Latini, quella fu di tanta bellezza, che leggiermente sia messa innanzi alle altre. E lasciando gli altri, Omero, uomo di divino ingegno, si stancò innanzi che egli potesse scrivere quella sofficientemente in versi secondo la ragione. Ancora tutti i dipintori e intagliatori in molti modi pigliarono quella medesima fatica, acciocchè almeno, se egli potessero, lasciassero a quegli che venissero dietro la immagine di così eletta bellezza. Fra quali Zeusi Eracleota, a quel tempo famosissimo maestro, e messo innanzi agli altri, condotto per grandissimo pagamento da quegli di Crotone, pose tutto l’ingegno e le forze dell’arte a figurare quella col pennello; e non avendo altro esemplo, che i versi di Omero, e la gran nominanza d’ogni parte; come egli potè per queste due cose comprendere nella mente della faccia, e dello altro stato della persona; pensò potere comprendere, e mostrare agli altri che la domandavano, quella divina faccia per più bellezze di molte altre. E mostratogli da quegli di Crotone bellissimi fanciulli, poi le sirocchie di quegli, delle quali egli elesse cinque di spezial bellezza; di tutte quelle raccolto in sè una forma, prendendo tutta la forza di suo ingegno, appena fu creduto, che assai pienamente egli potesse compiere con l’arte quello che desiderava. E io non mi maraviglio; perchè chi potrebbe col pennello e chi col colore in una pintura, o in una statua descrivere la bellezza degli occhi, e la piacevolezza e affabilità di tutta la faccia , secondo la qualità delle parole e degli atti, essendo questo uffizio della natura? Dunque egli fece quello che egli potè, e quello che dipinse lasciò a quegli che vennero drieto per una celestiale bellezza d’una immagine. E da questo gli autori hanno fatta finzione d’una favola; e hanno descritta quella essere stata figliuola di Giove trasformato in cigno, per istellato splendore degli occhi, per la chiarezza della faccia, per li crespi capelli d’oro sparti per li omeri da ogni parte, per la sua viva, sonante e piacevole voce, per alcuni movimenti della faccia odorifera e colorita, per la chiara fronte, bianca gola, per le grandi dilicatezze dello elevante petto, non conosciuto se non per la veduta di suo respirare; acciocchè oltre alla bellezza che ella avea ricevuto dalla madre, intendessimo per infusione di deità concesso quello che gli artigiani per suo ingegno non potevano esprimere col pennello e con colori. Per questa maravigliosa bellezza tratto innanzi agli altri Teseo, andò d’Atene a Lacona, e presa quella vergine, e tenera per l’età, giuocando quella nella palestra, secondo lo costume della patria: e benchè di quella egli non potesse avere alcuna cosa oltre ad alcuni baci; nondimeno diede a quella alcuna infamia di non servata virginità; la quale fu renduta al fratello, secondo alcuni, da Alethia, madre di Teseo, essendo egli in altro paese, domandandogli quella i fratelli. Altri disseno, che ella fu renduta a Proteo, re d’Egitto: e finalmente poichè fu da marito, fu maritata a Menelao, re della Lacedemonia; del quale ella ebbe Ermionia, sua figliuola. Dappoi in discorso d’anni essendo tornato a Troja Paris, lo quale era stato gittato nella montagna d’Ida per lo sogno di sua madre, essendo ella gravida, e avendo soperchiato nella palestra Ettore, non essendo conosciuto: e avendo schifata la morte, e per li segni essendo conosciuto dalla madre; ricordandosi egli della promessa di Venere fatta nella montagna d’Ida della bellissima moglie che ella gli avea promessa per la sentenza che le avea data; e, secondo che alcuni dicono, mosso per domandare Esiona, fece fabbricare navi presso lo monte d’Ida, e con reale compagnia passò in Grecia: dove egli fu ricevuto nello albergo di Menelao. In quel luogo come egli vide Elena ornata di celestiale bellezza, vaga in ornamenti reali, e contenta d’essere guardata; innamorato subito, e presa isperanza per li costumi di quella; e guardandola al tempo furtivamente, al tempo ella s’innamorò di lui. Ai principi favorisce la fortuna; perchè Menelao per certa necessità era andato in Creta. Per la qual cosa, dicon alcuni, che essendo innamorati amendue, di concordia avvenne, che Paris portò nella sua patria lo fuoco veduto dormendo da Ecuba sua madre, e empiè lo augurio: levò Elena dal lito di Laconia con grandissima parte del tesoro di Menelao in tempo di notte, ovvero, secondo che piace ad alcuni, tolse quella dall’isola Citerea, che è appresso a quel luogo; dove, secondo l’usanza della patria, Elena era nel tempio a vegghiare per lo sacrifizio:, fa messa nelll’apparecchiata nave, e con quella, dopo molti pericoli, arrivò a Troja, dove ella fu ricevuta da Priamo con grandissimo onore; pensando egli, piuttosto avere purgato la vergogna dell’ingiuria d’Esiona, la quale era tenuta da Telamone, che avere ricevuta nella patria la strema desolazione del suo regno. In grazia di questa donna tutta Grecia si commosse: e pensando tutti i principi di Grecia piuttosto la ingiuria di Paris, che la lascivia d’Elena; avendo raddomandata quella più volte indarno, feciono lega a distruzione di Troja: e raccolto loro sforzo, con mille navi e più caricate di gente armata, Smontarono in sul lito tra il monte Sigeo e il monte Reteo in Frigia; e assediarono Ilion, indarno facendo resistenza i Trojani. Elena potè vedere dalle mura dell’assediata città di che pregio fosse la sua bellezza, guardando il lito pieno di nemici, e ogni cosa essere guasta con ferro e con fuoco, e combattere i popoli, morire e tagliare l’uno l’altro, e ogni cosa essere bruttata così del sangue dei Trojani, come di quel de’ Greci. La quale certamente fu dimandata con sì pertinace proposito, e tenuta, che non essendo renduta, durò l’assedio pel tempo di dieci anni, con la morte di molti nobili. Nel quale assedio essendo guasto e morto Ettore e Achille, essendo morto Paris da Pirro, asprissimo giovane; quasi parendole, avere poco peccato la prima volta, maritossi la seconda a Deifebo più giovane. Finalmente tentandosi col tradimento quello che non parea possibile con le armi; questa, che era stata cagione dello assedio, acciocchè ella desse aiutorio a guastare, e che ella ritornasse in grazia del primo marito, seppe e acconsentì al tradimento. E facendo falsamente vista di partirsi i Greci; i Trojani, stanchi delle prime fatiche, e con nuova letizia e allegri conviti vinti dal sonno e dalle vivande, Elena cogli lumi, sotto vista di balli, dalla rocca fece segno a quegli che stavano attenti: i quali tornati, taciti, trovando la città mezza addormentata, aprì le porte, e entrati drento, e messo fuoco nella terra, e Deifebo morto vituperosamente, fu restituita Elena a Menelao suo marito, dopo lo vigesimo anno poi che ella fu portata in Troia. Altri dissono, che Elena fu portata via da Paris contro a suo volere e per questo meritò essere ricevuta da quello: lo quale tornando con quella in Grecia molto perseguito da’ venti e dalla fortuna di mare, costretto arrivare in Egitto, fu ricevuto da Polybo re. Dappoi, chetata la fortuna, tornò in Lacedemone con la ritornata moglie: dove egli fu ricevuto l’ottavo anno dopo il guasto di Troja. Ma dove poi vivesse, o quanto vivesse, o quello che dappoi ella facesse, o in che luogo ella morisse, non mi ricordo averlo trovato in alcuno luogo.
CAPITOLO XXXVI.
Circe, figliuola del Sole.
Circe per sua incantazione infino a questo tempo famosissima, secondo la testimonianza de’ poeti, fu figliuola del Sole, perchè fu ornata di singolare bellezza; ovvero perchè circa lo conoscere dell’erbe fu sommamente maestra, ovvero piuttosto perchè ella fu savissima nel trattare delle cose, le quali tutte cose lo Sole, per diversi rispetti, dà a quegli che nascono, secondo gli astrologhi. Ma non mi ricordo avere letto per che modo si partisse da Colco e arrivasse in Italia: pure tutte le storie s’accordano, che ella abitò Etheo, montagna dei Volschi; lo quale monte del nome di quella infino a quel tempo e testè è chiamato il Monte Circeo. E non trovandosi di questa sì famosa donna alcuna cosa, se non per i poeti; toccati brievemente i detti de’ poeti, secondo che è conosciuto, ovvero conceduto al mio ingegno, sporrò la intenzione di quegli che gli credono. Dunque dicono, innanzi all’altre cose, che tutti i naviganti che arrivano al lito di quel monte (lo quale già fu isola) o che eglino v’arrivassino di volontà, o che eglino v’arrivassino per fortuna, convertivansi in fiere per diverse spezie, per incantamenti di quella, e per bevanda d’alcuna velenosità. E tra questi, dicono, che furono i compagni di Ulisse, lo quale andava vagabondo:, ma egli fu difeso per l’aiutorio di Mercurio, lo quale tratta fuori la spada, minacciando a quella venefica, lo ritrasse nella prima forma; e per ispazio d’un anno dimorando con quella, dicono che egli generò di quella Telegono suo figliuolo, e da lei si spartì pieno di consiglio: e sotto questo detto, penso, stare nascosa questa sentenzia. Sono alcuni che dicono, che questa donna non molto di lungi da Gaeta, terra di Campagna, fu possente di forza e di parlare; e che ella non curava molto, purchè seguisse lo suo diletto, di salvare l’onestà senza infamia: e così trasse molti di quegli che arrivavano al suo lito, con lusinghe e ornato parlare, non solamente a’ suoi diletti, ma indusse alcuni a roberie per terra e per mare:, e alcuni, lasciata ogni onestà, attizzò con arti ovvero inganni a fare arti mercatorie; e molti per suo singolare amore fece insuperbire: e quegli, ai quali per arti umane della scellerata donna pareva tolto lo parlare, ponghiamo degnamente convertiti in fiera di sua opera. Da quella cosa noi possiamo comprendere assai, che, considerati gli costumi degli uomini e delle donne, in ogni luogo sono molti Circei, e molti più uomini per la loro lascivia convertiti in bestie: e Ulisse, innanzi ammaestrato per lo consiglio di Mercurio, assai significa lo savio uomo, lo quale non può essere legato dagl’inganni de’ lusinghieri; anzi spesse volte cogli suoi argomenti iscioglie i lacci di quegli che sono legati: l’avanzo, assai è manifesto appartenere alla storia; per la quale è manifesto, Ulisse essere stato per alcuno spazio con Circe. Dicesi ancora che questa medesima donna fu moglie di Pico, figliuolo di Saturno, re de’ Latini; e che ella gl’insegnò la scienza dello indovinare; e che ella lo trasmutò in uno uccello che era del suo nome per gelosia, perchè egli era innamorato di Pomona ninfa; perchè egli avea in casa uno uccello picchio, per lo cui cantare, e movimento egli pigliava la scienza delle cose future; e perchè egli secondo gli atti del picchio conduceva sua vita, fu detto, che egli era convertito in picchio. E per che modo, o dove morisse quella donna, non è trovato.
CAPITOLO XXXVII.
Camilla, Reina de’ Volschi.
Camilla maravigliosa e sommamente degna di lode fu reina de’ Volschi; e questa fu figliuola di Metabo, re antichissimo de’ Volschi; della madre, moglie del detto re, ebbe nome; la quale incontanente poi che partorì quella, morì; e rimanendo quella piccola al padre, per sua consolazione pose alla figliuola il nome della madre, togliendo via una lettera. E questa vergine dal primo dì di sua natività ebbe asprissima fortuna; perchè poco dopo la morte della madre, Metabo per subito furore de’ primi tra i suoi cittadini fu cacciato del regno: lo quale fuggendo, non portò con seco alcuna cosa, se non la piccola fanciulla, amata da lui sopra tutte le altre cose: e fuggendo egli misero, solo, appiè, portando in braccio Camilla per sua compagnia, arrivò al fiume Damasceno, lo quale per la piova del dì passato, e per lo disfare della neve era molto cresciuto; e non potendo passare notando con quella verginetta, e non volendola lasciare, per subito pensiero essendo spirato da Dio, lo quale non voleva, quella morisse in sì tenera etade, ma conservarla a famosa verginità, deliberò di rinvolgerla in iscorze di sughero, e così rinvolta legò quella all’asta d’uno spiedo che egli avea fatto. La qual cosa legata e rinvolta, promise a Diana, se gliela salvasse, e fatta la promissione, con tutte sue forze la gittò oltre dal fiume; e sopra lo quale notando egli dopo quella, arrivò all’altra ripa salvo con quella insieme: essendo allegro, benchè fusse in miseria, abitò in luoghi nascosti per le selve, e non senza gran fatica nutricò quella fanciulla con latte di bestie. La quale, come ella arrivò a più forte etade, cominciò a vestirsi di pelle di bestie, portare arme, trarre con la frombola, portare al collo lo turcasso, tendere e tirare con l’arco, perseguire i cervi, fuggendo eglino, e cavriuoli selvatichi, dispreggiare ogni lavorio di femmina, salvare sopra ogni cosa la sua verginità, far beffe degli innamorati giovani, e al postutto rifiutare lo matrimonio di quegli che la chiedevano; e tutta si dava a Diana, alla quale lo padre l’avea promessa. Con gli quali esercizj indurata quella femmina vergine, tornata nel regno di suo padre, seguì costantemente lo suo proposito. Finalmente essendo venuto Enea da Troja, e avendo tolta per moglie Lavinia in Italia; e quegli avendo cominciata guerra tra lui e Turno, re de’ Rutoli, facendo l’una parte e l’altro suo sforzo, Camilla, favoreggiando la parte di Turno, andò in suo aiutorio con gran moltitudine di suo regno. E avendo combattuto più volte armata contro a’ Trojani, combattendo aspramente, abbattè molti di quegli. Dopo la morte de’ quali perseguendo ella un sacerdote di Cibele, chiamato per nome Corebo, per cupidità di avere le sue arme, un cavaliere chiamato per nome Arante la ferì d’una saetta nel petto dopo la mammella, per la quale ferita ella cadde morta in terra, della cui morte seguì gran danno ai Rutoli. Così ella morì tra quegli esercizj che ella avea amati. A questa io vorrei, che guardassino le fanciulle del nostro tempo: e considerando quella vergine già in compiuta età per suo diletto discorrendo per le selve e per le tane delle fiere con l’arco e col turcasso; premendo cacciare con la fatica i piaceri del disordinato appetito, e gli diletti e le delicatezze, e rifiutando le artificiose bevande, con costantissimo animo rifiutò non solamente il toccare degli uomini, ma eziandio de’ giovani di sua etade: per ammaestramento di quella imparino quello sia dicevole a loro in casa de’ padri, nelle chiese, nei palagi, dove si raduna la moltitudine degli aspri giudicatori: e per esempio imparino, non è ascoltare le cose disoneste, sottrarre la bocca del parlare, costrignere gli occhi al vedere, con gravità comparerai gli costumi; e ordinare tutti gli atti con una gravezza d’onestà; costrignere gli riposi, e nel mangiare fuggire le troppe delizie, fuggire i balli, e le conversazioni degli uomini: ancora conoscano le fanciulle, che desiderate ogni cosa che piace, e che si può fare non è santa cosa, nè conforme all’onestà; acciocchè, fatte più savie in fiore di lodevole verginità sotto lo comandamento de’ suoi maggiori, arrivino con maturità al sacro matrimonio.
CAPITOLO XXXVIII.
Penelope, moglie di Ulisse.
Penelope, moglie d’Ulisse, figliuola d’Icaro re, uomo di somma prudenza e virtù, fu una donna di grandissima bellezza e somma onestà, e esempio incorruttibile santissimo e eterno delle donne. La forza dell’onestà di quella fu stimolata per lungo tempo indarno; perchè essendo ella giovanetta, vergine, e per la sua bellezza molto amata, lo padre la maritò a Ulisse, del quale ella partorì Telemaco. Dopo questo egli fu inviato, anzi quasi tratto per forza all’oste di Troja: di che Penelope rimase con Laerte suo suocero, e Anticlia sua suocera, e con lo piccolo figliuolo. E certamente durando la guerra per ispazio di dieci anni, non portò alcuna ingiuria, se non che stette a modo di vedova. Ma poi che fu guasta Troja, tornando i principi de’ Greci a casa, sopravvenne la nominanza, alcuni di quegli essere pericolati per tempesta di mare tra gli scogli, alcuni altri essere arrivati in altri paesi, e alcuni essere affondati in mare, e così pochi essere tornati nella patria; e solo Ulisse essere incerto dove egli era arrivato con sue navi.
Per la qual cosa, essendo aspettato lungamente a casa, non tornando egli, nè apparendo, quello essere stato veduto da alcuno, stimava ciascuno che egli fusse morto. Per la quale credenza Anticlia, miserabile madre, per mettere fine al dolore, con un laccio finì sua vita. Ma Penelope, benchè gravemente portasse l’assenza del marito, portò per lungo spazio lo sospetto della morte di quello: e dopo molte lagrime e molto chiamare d’Ulisse spesse volte indarno, deliberò con fermo animo invecchiare in castissima vedovità tra lo vecchio Laerte, e Telemaco, figliuolo fanciullo. Essendo quella bella, e di belli costumi, e di gentile schiatta, alcuni giovani d’Itaca, di Cefalonia, e di Etolia amavano e desideravano quella; da’ quali ella raddomandata con molti stimoli, e menomando la speranza della vita e del tornare di Ulisse, avvenne che Laerte per lo fastidio delli vagheggiatori stava in villa; e quegli aveano occupata la regal casa d’Ulisse, e con prieghi e con lusinghe stimolavano Laerte per potere avere quella per moglie. E temendo quella donna che non le fusse rotto lo sacro proposito del suo petto, non vedendo più via a negarlo, ispirata da divino lume, pensò almeno ingannare per infino ad alcuno tempo. Pigliando termini, e stimolando quegli, domandò che le fusse lecito aspettare lo marito, per infino che ella potesse compiere una tela, la quale ella avea cominciata, secondo regale donna. La qual cosa avendo conceduto lievemente quegli gentili uomini che la domandavano, ella con astuzia di donna ditesseva la notte nascosamente tutto quello che ella avea tessuto il dì. Con la quale arte ingannando quegli, che in casa di Ulisse consumavano i suoi beni in continui conviti, non potendo quella ingannare; avvenne per divina pietà, che essendo passati venti anni da che egli era partito di casa, Ulisse tornò in Itaca solo e sconosciuto, venendo del regno di Fenicia; e andò a’ suoi pastori per domandargli dello stato delle sue cose, maliziosamente in povero abito; esaminò Sibate, suo porcajo, già vecchio, dal quale ricevuto dimesticamente, seppe quasi come stessino i suoi fatti: e vide suo padre e Telemaco che tornava da Menelao, e nascosamente gli si diè a conoscere, e manifestogli tutta sua deliberazione. E avvenne, che Sibate lo condusse a casa sua non conosciuto; dove, poichè egli vide a che modo quegli aspettatori trattavano i suoi fatti; e come Penelope rifiutava contrarre matrimonio, mosso ad ira col figliuolo, e co’ suoi fattori e famigli, assalì quegli giovani che stavano in convito in casa sua; e nominatamente uccise Eurimaco, figliuolo di Polibo, Antinoo di Anfione, e Crisippo di Samo, Agelao, ed alcuni altri, e con quegli Melanteo suo pastore, e alcune femmine di casa, le quali, egli seppe, avere tenuto brigata con quegli: e liberò la sua Penelope dall’assedio di quegli; la quale finalmente appena potendo riconoscere quello preso da somma allegrezza, ricevè quello, avendolo lungamente desiderato. Licofion, greco poeta, nondimeno disse, che Penelope per fattura di Nauplo, il quale per la morte di Palamede suo figliuolo era nimico d’Ulisse, commise adulterio con alcuni di quegli nobili giovani che la domandavano: la qual cosa per veruno modo è credibile, essendo ella di tanta onestà per le scritture di tutti gli altri autori; la cui virtù è tanto più famosa, e tanto più da commendare, quanto ella si truova più rada, e quanto ella stimolata per maggiore battaglia perseverò più costantemente.
CAPITOLO XXXIX.
Lavinia, figliuola del Re Latino.
Lavinia, sola figliuola del re Latino e d’Amata sua moglie, reina de’ Laurenti, della schiatta di Saturno, finalmente fu moglie d’Enea, nobilissimo duca de’ Trojani, è più famosa per la guerra di Turno, re de’ Rutoli, che per altra sua opera. E questa certamente per singolare onore di sua bellezza, e per lo regno di suo padre, al quale ella pareva rimanere erede, era dimandata con somma istanza per moglie da Turno re de’ Rutoli, ardentissimo giovane: e di questo avea data isperanza, Amata, madre di Lavinia, la quale già di quello con grande istanza era favorevole al nipote. Ma Latino per augurio, avendo inteso, dover dare la figliuola per moglie a un forestiere signore, era tardo a consentire alla moglie, anzi essendo sopravvenuto Enea da Troja, Latino, sì per gentilezza di sua schiatta, come per ammaestramento dell’augurio, domandando Enea sua amistà, promisegli la figliuola; per la qual promessa fu cominciata la guerra tra Enea e Turno. E dopo molte battaglie, Lavinia con le ferite, col sangue e la morte di molti nobili nomini fu tolta per moglie da Enea, essendole innanzi Amata, sua madre, per isdegno morta d’un capestro. E sono nondimeno alcuni che hanno detto, la guerra essere stata dopo il matrimonio; ma come la cosa sia stata, è manifesto che Lavinia ebbe un figliuolo da Enea, famosissimo principe; e essendo morto Enea presso lo fiume Numico innanzi che ella partorisse, temendo Ascanio suo figliastro, lo quale era rimaso signore, dicesi, che ella si partì, e abitando per selve, partorì quello postumo, e posegli nome Julio Silvio. E certo essendo Ascanio più benigno verso della matrigna, che ella non credeva; e avendo edificato perse Alba, volontariamente lasciò lo regno del padre a Lavinia, che avea nell’animo l’antica nobiltà di sua schiatta, vivendo onestamente e castamente tenne, e servò quello infino che regnasse Silvio compiutamente. Alcuni hanno detto, che poichè ella si partì delle selve, ella si maritò a uno chiamato Melampode; e che Ascanio nutricò Silvio con benevolenza di fratello.
CAPITOLO XL.
Didone, Reina di Cartagine.
Dido, la quale prima ebbe nome Elisa, fu edificatrice di Cartagine. E piacenti a lode di questa parlare alquanto più lungamente, se per ventura con le mie poche lettere potessi in alcuna parte almeno tor via la infamia messa indegnamente all’onore di castità. Acciocchè io cominci alquanto più di lungi a sua gloria: i popoli di Fenicia, secondo che è assai famosa cosa, molto conosciuti per industria, venendo quasi dell’estremità dell’Egitto allo lido di Soria, edificarono in quello molte famose città. Fra gli altri fu loro re Agenore, famoso al nostro tempo non che al suo; dal quale fu creduto che difendesse la gloriosa schiatta di Dido, lo cui padre fu Belo, re di Fenicia; lo quale nell’isola di Cipro, soggiogata da lui, morì. E alla morte lasciò la giovinetta e Pigmalione, alquanto maggiore, suo figliuolo, raccomandando quegli ai suoi cittadini; i quali fecero re Pigmalione in luogo di suo padre, e Elisa, eccellentissima di bellezza, diedero per moglie a Aterbo, chiamato Sicheo, sacerdote d’Ercole, lo quale avea maggior degnità appresso del re, questi s’amarono insieme con gran Santità. Era Pigmalione oltre a tutti gli uomini cupidissimo e insaziabile d’oro, così Sicheo era ricchissimo; benchè, conosciuta l’avaritia del re, egli tenesse nascosta la sua moneta; ma non avendola potuto nascondere alla nominanza, tratto Pigmalione da cupidità, per avere speranza d’avere lo suo tesoro, uccise a tradimento lo cognato, lo quale non si guardava. La qual cosa come Elisa seppe portolla sì impazientemente, che appena s’astenne d’uccidersi. E avendo consumato molto tempo indarno, e pianto, chiamando ispesse volte lo suo diletto Sicheo; e mandata contro a suo fratello, e chiamata ogni crudele bestemmia, deliberò fuggire; o che ella l’avesse per ammaestramento di visione, secondo che dicono alcuni, o che ella lo facesse per proprio consiglio di sua mente; forse perche l’avarizia del fratello non conducesse anco lei alla morte. E messa giuso la debilezza di femmina, e fermato l’animo con fortezza d’uomo (per la qual cosa ella meritò d’essere chiamata dappoi Dido in lingua di Fenicia, che e a dire in lingua latina forte donna) innanzi all’altre cose trasse a sua volontà alcuni de’ principi delle cittadi, i quali per varie cagioni ella sapeva avere in odio Pigmalione: e tolte le navi del fratello, apparecchiate per mandare lei, o per altra cagione, fece subito riempierle dai compagni. E di notte, tolto lo tesoro del marito, il quale ella sapeva, e quello che ella potè torre al fratello, fecelo nascosamente mettere in nave; e con deliberata malizia fece legare fardegli pieni d’arena sotto vista che fusse lo tesoro di Sicheo, e in presenza d’ogni uomo fecegli mettere in mare, cioè in nave. E essendo già larghi in mare, maravigliandosi quegli che non sapevano il fatto, comandò, che i detti fardegli fussero gittati in mare; e con lagrime affermò, sè aver trovato modo di aver la morte, la quale ella avea lungamente desiderata, avendo gittato in mare lo tesoro di Sicheo; ma dice, che avea compassione ai compagni, i quali, ella non dubitava, se ne andassino a Pigmalione, essere con lei insieme duramente tormentati dallo avarissimo e crudelissimo re: ma se eglino volessero fuggire con lei, affermò di non mancare a loro, e a’ suoi bisogni. La qual cosa udendo i miseri nocchieri, benchè gravemente lasciassero la patria dove egli erano nati, e le proprie case, nondimeno per paura della crudel morte impauriti consentirono lievemente d’andare in esilio. E volte le navi, a guida di quella andarono in Cipro: dove ella levò fanciulle, le quali, secondo loro usanza, in sul lido pagavano a Venere la loro prima verginità, per piacere de’ suoi giovani, e per generar li figliuoli; e tolse per compagnia del suo cammino il sacerdote di Giove, e tutta sua famiglia, lo quale indovinava grandi cose di quella fuga. E già lasciandosi alle spalle Creta, e Sicilia dal destro lato, piegò dal lato di Barberia, e entrò nel paese de’ Messali, e finalmente nel golfo assai co[no]sciuto: dove essendo sicuro lo stare delle navi, determinò di dare alquanto di riposo a’ nocchieri, che erano stanchi. E venendo i vicini per desiderio di vedere i forestieri, e alcuni portando vettovaglia e mercatanzia; secondo usanza, cominciarono a pigliare e fare insieme amistà e parentado. E parendo grato agli abitatori, che quegli forestieri rimanessero in quel luogo e essendo venuti ambasciadori da Utica, posta similmente per quegli che erano venuti da Tiro, e quegli confortando pigliare sede in quel luogo, subito andarono, e comperarono solamente in su quel lido tanta terra quanto volgesse un cuojo di bue (benchè ella avesse udito, che il suo fratello la minacciava perseguirla, non impaurita) perchè mostrasse non fare ingiuria ad alcuno, e alcuno non sospettasse, in quella essere gran cosa per lo tempo che dovesse seguire. E questo fu scaltrimento di femmina! per suo comandamento fu tagliata quella pelle di bue in sottilissime correggiuole, e giunta l’una con l’altra, presero molto più, che non pensavano i venditori: e edificò battagliera città sotto l’augurio di una trovata testa di cavallo; la quale ella chiamò Cartagine, e la rocca Birsa dalla pelle di bue. E mostrato lo tesoro che avea tenuto nascosto, e confortato li compagni, che erano fuggiti con lei, a grande speranza; subito furono levate le mura, i palagi, i templi, le mercatanzie pubbliche e private. E avendo ella dato al popolo leggi, e la regola del vivere, e subito essendo cresciuta la nobile città; fu famosa per tutta Africa di grande bellezza e non veduta altra volta, di non udita virtù e castità. Per la qual cosa, essendo quegli d’Africa sommamente inchinevoli a lussuria, avvenne, che il re de’ Musicani s’innamorò di lei, e domandò quella per moglie ai maggiorenti di Cartagine; minacciando, se non gli fusse data, far guerra, e guastar la città che cresceva. E sapendo cittadini lo sacro proponimento di quella vedova reina della inflessibile castità; e temendo per sè molto, essere disfatti per la guerra, se quello domandatore fusse ingannato di suo desiderio; non arditi di dire a lei quello che domandava che quello volesse; pensarono ingannare la reina con parole, e trarla a suo volere con la sentenzia di quella medesima. E dissero a lei, che lo re desiderava ridurre la sgominata gente a più umani costumi, e per questo domandava a loro alcuni ammaestratori, minacciando fare guerra, se non gli fossero dati: e dissono, ch’erano in dubbio, chi dovesse pigliare quella fatica, e lasciare la patria per andare a vivere con sì aspro re. La reina non s’accorse dell’inganno; ma volta a quegli, disse: O nobili cittadini, che ignoranza e che viltà è la vostra? non si può dire, che quello sia dirittamente cittadino, lo quale per la pubblica salute rifiuti la morte, od altra incomodità, se cagione lo richiede: dunque andate allegri, e con poco vostro pericolo rimovete dalla patria lo gran furore della guerra. Con queste riprensioni della reina parve a quegli principi, avere ottenuto quello che egli volevano; e parve loro discoprire i veri comandamenti del re. Le quali cose udite, assai parve alla reina, sè avere affermata la deliberazione con la propria sentenzia; e in sè medesima si dolse, non osando contraddire allo inganno dei suoi. Ma, stando ferma in suo proponimento, subito fece questa deliberazione, la quale le parve di bisogno a sua onestà: e disse che mariterebbe, se le fusse dato termine. Lo quale essendole conceduto, e sopravvenendo Enea Trojano non veduto mai; deliberò, piuttosto volere morire, che rompere sua castità: ordinò uno grande fuoco nella più alta parte della terra, per quietare l’anima di Sicheo, secondo lo credere dei cittadini; e vestita di nero, servando varie cerimoniere sacrificati molti animali, montò sopra quel rogo in presenza di molti cittadini, i quali guardavano che ella dovesse fare. Le quali cose avendo fatte tutte per voto, trasse fuori un coltello, che ella avea sotto le vestimenta; e messo quello innanzi al castissimo petto, chiamato Sicheo, disse: Secondo che volete, cittadini miei, io vo’ a marito: e appena fornite queste parole, con somma tristizia d’ogni uomo lasciossi cadere sopra il coltello; e soccorrendo quegli per aiutarla, avendo offesi i luoghi della vita, morì ispargendo lo sangue onestissimo. O Dio! alla tua onestà fu fatta forza, e tu fosti eterno e venerabile onore di viduità! Vorrei che le donne vedove guardessino a te, e in ispezialità quelle che sono cristiane guardassino alla tua fortezza; e, se elle possono, con intera mente considerino te, la quale spargi lo tuo santissimo sangue; e quelle in ispezialità, alle quali fu levissima cosa non dirò andare al secondo marito, ma al terzo, al quarto, e oltre. Io dimando, quelle che diranno, che hanno le ’nsegne della fè di Cristo, guardando quella di strana nazione, e infedele, e dalla quale Cristo non era conosciuto, ad acquistare la lode che deve perire, con così costante animo e con fermo proposito procedere infine alla morte non ricevuta da altri, anzi dalla propria mano, innanzi che ella volesse consentire al secondo matrimonio, e innanzi che ella permettesse, essere isforzato lo venerabilissimo proponimento della sua osservanza? E perchè le donne del nostro tempo sono sottilissime a scusarsi, alcuna dirà, secondo che io penso: Ella dovea fare così perchè ella era abbandonata alla morte dal padre, e dalla madre e da’ frategli; i vagheggiatori la stimolavano con lusinghe: io non potrei contrastare; io sono di carne, e non di ferro. O che giuoco è questo! Dido di cui aiutorio si fidava, la quale avea un solo fratello, e quello era nimico? non ebbe Dido molti vegheggiatori? anzi era Dido di pietra e di legno più che altre donne del nostro tempo? dunque con la mente ciascuna è possente assai: ella fuggì, morendo, per quella via, che ella pensava, non potere resistere con la forza. Ma noi, i quali diciamo, essere sì abbandonati, non abbiamo nel Cristo per rifugio? e egli è certamente nostro ricuperatore, sempre presente a quegli che sperano in lui: pensi tu, che quello il quale campò i Fanciulli della fornace del fuoco, che liberò Susanna dal falso peccato, non possa campare dai legami delle mani dei nemici? Piega a terra gli occhi, e serra gli orecchi; e a simiglianza di uno scoglio ricevi l’onde che sopravvengono; e non muovendoti lascia stare i venti, e rimarrai salva. E forse un’altra dirà: Io avea grandi possessioni, casa bellissima, masserizie reali, e gran quantità di ricchezze; molto desiderava avere figliuoli, acciocchè tanta ricchezza non passasse agli stranj. Ma questo è matto desiderio: non avea Dido regno senza figliuoli? non avea ella ricchezza di re? che dirai tu? Ella rifiutò esser madre, perchè savissimamente pensò, che niuna cosa è più stolta che guastare i suoi fatti per fare gli altrui. Dunque macchierò io la castità per acquistare posseditori ai campi, alla splendida casa, e alle masserizie, e che spesso avviene che sono consumatori? e se tu hai ricchezze grandi, certamente tu le dei spendere, e non gettar via: molti sono poveri di Cristo, ai quali infino a che tu dai le ricchezze, tu edifichi per te eterni palagi, e illumini la tua castità d’un altro splendore. Ancora a verno gli amici, de’ quali niuno è più convenevole erede, perchè ciascuno gli ha sì fatti come egli li domanda; ma i figliuoli non sono sì fatti come tu gli vuoi, ma quali la natura gli produce. Verrà la terza, e dirà, che le conviene così fare, perchè lo padre gliele comandò, e perchè i parenti ne la costringono, i vicini ne la confortavano; quasi come noi non sapessimo, che il suo appetito l’avesse confortata, anzi l’avesse comandato quello disfrenato, d’una negazione avrebbe annichilato ogni cosa: Dido potè morire per non vivere disonesta, questa non potè negare lo matrimonio per vivere onesta. Forse si presenterà un’altra, che (a suo credere) sarà più scaltrita che le altre, e dirà: Io era giovane; (come tu sai) la gioventù è calda; io non potrei stare continente: lo Dottore delle genti dice, che meglio è maritarsi, che ardere: lo cui consiglio io seguito. O come bene è detto questo! quasi come io sia un fanciullo, e comandi stare casto alle vecchiette, o come Dido non fusse giovanetta, quando dispose stare casta. O come quella è scellerata opera! non sia tolta in devozione la parola di San Paolo così santo, ma anzi piuttosto a difensione del peccato molto s’alleghi, quello che è più brutta cosa! Noi possiamo restaurare la mancata forza co’ cibi e non possiamo menomare coll’astinenza la superflua? Quella pagana donna per vanagloria potè signoreggiare allo suo ardore, e porgli legge; e una donna cristiana per acquistare vita eterna non potrà signoreggiare sè medesima? Oimèi mentre noi pensiamo ingannare Iddio con sì fatti modi sottraiamo noi medesimi allo caduco onore, non dico allo eterno, e sospingiamo noi medesimi allo pericolo d’eterna dannazione. Dunque si vergognino quelle che considerano lo morto corpo di Dido; e pensando la cagione di sua morte, alleggino lo volto dolendosi quella che è cristiana essere avanzata in onestà da quella che è membro di diavolo. Nè pensino, che, come hanno pianto il morto corpo vestite di nero, abbiano fatto ogni suo dovere: deesi salvare l’amore infino alla fine, se vogliono adempiere l’officio del vedovatico; e non pensino passare ad altro amore. La qual cosa alcune fanno piuttosto per satisfare a suo ardore sotto colore del matrimonio, che per ubbidire al sagramento del matrimonio: e che tanto è cercare consorzio di tanti uomini, e a tanti cogiungersi, che, seguendo Valeria Massalina, entrare per le caverne, e per gli luoghi disonesti. Ma di questo altra volta si dirà; perchè confesso, avere passato troppo i termini del cominciato lavorio: ma chi è quegli che sia sì suo signore, che alcuna volta non sia tratto del suo proposito? Domando perdonanza a quegli che leggerà: e i tornerò onde io mi partii. Dunque i suoi cittadini con pubblico pianto e tristizia celebrarono la sepoltura di Didone, grande e magnifica non solamente d’onori umani, ma eziandio di divini a suo potere; e onoravano quella non solamente in luogo di comune madre e reina, ma in luogo di gloriosa Dea. E continuamente obbedendo a quella infino che durò Cartagine, ebbero quella in reverenzia con are, templi e sacrificj (A).
CAPITOLO XLI.
Nicaula, Reina d’Etiopia.
Nicaula, secondo che si può comprendere, nacque nell’estremo d’Etiopia, la quale per certo fu degna di ricordanza, quanto ella, nata tra gente non costumata, fu più famosa di costumi. E manifesto, che mancando i Faraoni, ovvero la schiatta di quegli, se noi dovemo dare fede agli antichi, ella fu famosissima reina d’Etiopia e d’Egitto. Secondo che dicono alcuni, fu reina d’Arcadia, e che ella ebbe grandissima casa reale in Meroe, isola del Nilo, e in quel luogo abbondò di tante ricchezze, che fu creduto quasi, questa avanzare tutti gli uomini. Fra le quali ricchezze e delicatezze avemo letto, che ella non si diede a riposo, e morbidezza di femmina, anzi, benchè noi non conosciamo lo maestro, sappiamo che ella fu ornata di tanta scienza delle cose del mondo, che parve cosa miracolosa. La qual cosa ancora pare confermare la Sacra Scrittura, per la cui autorità si dimostra, che costei, la qual chiama Saba, udita fa scienza del savio Salomone, lo quale era famoso al suo tempo, e la cui gloria e fama avea pieno già tutto il mondo, si maravigliò, benchè i matti ignoranti non sogliono ammirare, ma dispregiare sì fatte cose. Ma, che è molto più, non solamente si maravigliò, ma venne in Jerusalem per udire quello, partendosi da Meroe; la quale, poco meno in capo dell’ altra parte del mondo lasciando il suo maraviglioso regno, passando l’Etiopia per lo lido del Mare Rosso, e gli deserti d’Arabia con sì splendida compagnia, e con sì magnifica spesa, e grandissima moltitudine di famiglia, che Salomone medesimo, ricco sopra tutti i re, si maravigliò di quella donna. La quale fu ricevuta da lui con sommo onore; e sponendogli alcune oscure parole, e avendo udito la risoluzione di quelle con diligenzia, confessò volontariamente che la sapienza di Salomone avanzava la nominanza e la capacità dell’umano ingegno, dicendo, che non era dubbio, quella essere acquistata per dono di Dio, non per istudio. Poi fece a quello maravigliosi doni, tra i quali si crede, fussero quegli arboscegli, i quali poi Salomone fece piantare e coltivare non lungi dal lago Asaltide. E finalmente ricevuti i doni da lui con somme lodi, ritornò a casa. E sono alcuni che credono, che questa medesima fusse Candace, reina di Meroe, dalla quale furon poi chiamati Candacj i re d’Egitto per lungo tempo, come innanzi erano stati chiamati Faraoni.
CAPITOLO XLII.
Panfila, donna Greca.
Truovo che Panfila fu una donna Greca; e avendole tolta la vecchiezza di che luogo ella nascesse, nondimeno fu benigna a lasciarle lo nome del padre, perchè si truova che ella fu figliuola d’uno chiamato Platra. E benchè la non si possa ornare d’amplissime dignitadi, perchè ella fece alcuno bene per la repubblica, non le dee essere taciuto la sua parte delle lodi, perchè niuna cosa è trovata di nuovo (quantunque ella paia lieve dopo il fatto, e dispregiata) che non sia grande argomento d’ingegno, e, secondo la quantità della cosa, che non sia degna di premio. Vogliono gli autori, a’ quali è dato alcuna fede, che questa prima colse lo bambagio degli arboscelli che lo producono; e con lo pettine lo pettinò delle superfluitadi, e poi che fu pettinato filò con la rocca, ed eziandio lo insegnò tessere, e così indusse l’uso di quello, non conosciuto per infino a suo tempo. Della qual cosa la pensata ragione lievemente mostrerà quanto nelle altre cose Panfila dovesse essere valuta.
CAPITOLO XLIII.
Rea Ilia, madre di Romolo.
Rea Ilia, madre di Romolo e Remo, fu già splendida tra gli Toscani di spettabile fama, perchè ella ebbe suo principio per gli Silvj, re degli Albani, i quali erano discesi successivamente da Enea, duca glorioso de’ Trojani, e fu figliuola di Numitore, re degli Albani. Essendo ella giovinetta, avvenne, che Amulio, fratello più giovane di Numitore, istimolato dalla cupidità della signoria, dispregiata la ragione degli uomini, per forza cacciò Numitore del regno. Contro al quale acciocchè egli non fusse crudele, s’interpose la fraterna pietà; e contentossi di confinarlo in villa a privato riposo. Ma contro a Lauso giovanetto, figliuolo di Numitore, acciocchè si togliesse chi lo cacciasse del regno, fu crudele con aspro animo; e morto quello, salvò Ilia sua sorella ancor fanciulla; ma acciocchè egli gli togliesse le speranze di marito e di figliuoli, fecela monaca fra le Vestali; e costrinsela a promettere perpetua virginità. La quale cresciuta in compiute etade, istimolata da lussuria congiunsesi con alcuno maschio, benchè non si sappia per che modo; e questo si manifestò per la gravidezza, per la quale ella partorì in un medesimo luogo Romolo e Remo edificatori della città di Roma: per il qual peccato, benchè fusse donna reale, secondo le leggi, e gli ordini della religione antica, e per comandamento del re i figliuoli furono esposti alle fiere ad esser divorati, ed essa sepolta viva. E benchè lo suo corpo sia seppellito nella terra, la nobile opera de’ figliuoli levò alta la sua nominanza, e fece, che quella rimase a quegli che vennero, la quale lo tiranno si sforzò di nascondere con sacra legge. E guardando questa con la mente, e vedendo le sacre vestimenta e le bende per alcuno spazio coprire i furti di Venere; non mi posso tenere, che io non derida della matteria d’altrui. Sono alcuni i quali come avari, acciocchè ditraggano alle figliuole alcuna particella di dote, sotto pretesto di devozione, non so se io dico serrano o perdano ne’ chiostri delle monache le piccole fanciulle, e alcuna volta grandi, ma isforzate, dicendo: Se avrò sagrificate quelle vergini a Dio, le quali colli suoi prieghi disporranno meglio li fatti suoi, e morendo, guadagneranno la beata vita. Oh cosa da ridere! non sanno eglino, che una donna in ozio è della milizia di Venere; e quelle avere sommamente invidia alle pubbliche meretrici, e che elle riputano migliore luogo le celle di quelle che il loro chiostro. E guardando agli matrimonj delle donne secolari, e agli vani adornamenti, ai balli e ai dì di festa, e se non aver avuta niuna esperienza di matrimonio: chiamano sè vedove dal principio di questa vita, piangono la sua fortuna, bestemmiando e maledicendo l’anima di suo padre con tutta la sua mente lo suo velo e suoi chiostri: e per consolare i suoi cuori tristi ricorrono solamente ai pensieri, per che modo possano rompere la sua prigione e fuggire, o almeno metter drento i suoi amanti; cercando pigliare furtivamente lo diletto, lo quale l’è stato tolto palesemente, essendole sottratto lo matrimonio. E queste sono le contemplazioni, non dico di tutte, ma della maggior parte, e i prieghi a Dio, i quali passano al cielo perchè siano prosperi i fatti de’ loro padri, e sieno santi quegli che l’hanno imprigionate! Oh miseri padri, e parenti, quali quelli sieno! se egli pensano, che l’altre possano portare quello che eglino non possono, e quello che egli fuggono; spesse volte piangono i vituperosi adulterj, parti con infamia, nipoti gettati e strangolati per crudel morte, essere cacciate vituperosamente, e alcuna volta lo fuggire; e ultimamente conviene nutricare quelle vituperose, ovvero vituperate, le quali l’avaro avrebbe potuto maritare oneste. Conoscano dunque gli s[t]olti se vogliono misurare le altrui forze con le loro, che le fanciulle non si debbono consacrare a Dio ignoranti, nè piccole, nè costrette, ma si debbono consacrare in età perfetta, sì che elle sappiano con intera mente quello che elle fanno; anzi prima si debbono nutricare in casa sotto santità della prima puerizia, informate di perfetta onestà e di laudabili costumi, e di propria volontà, e non costrette al giogo di perpetua verginità. Ma queste penso che sieno rarissime: meglio che il numero sia minore, e siano sì fatte, che vituperare con moltitudine lo santuario di Dio (B).
CAPITOLO XLIV.
Caja Cirilla, moglie di Tarquinio Prisco.
Caja Cirilla, benchè io non trovo alcuna memoria di sua origine, penso nondimeno che fusse romana, ovvero toscana; e questo si conferma per autorità degli antichi, perchè dia fu sommamente grata moglie di Tarquinio Prisco, re de’ Romani. Essendo questa donna di sottilissimo ingegno, comechè ella fu moglie di un re, e in casa reale, non comportò stare in pigro ozio; anzi essendo data a arte di lana (la qual cosa io penso in quel tempo onorevole cosa appresso i Latini) fu tanto nobile artigiana circa a quello, e tanto sollecita, che la sua fama è prolungata infino a questo tempo non senza pubblico premio. Perchè essendo ella riputata appresso i Romani maravigliosa, e sommamente amata donna, non essendo eglino ancora corrotti dalle delizie d’Asia, per pubblico ordinamento fu determinato, che quando alcuna donna andava da prima a marito, nello entrare nella casa dello sposo, ciascuna fusse domandata come avesse nome, e che subito la dimandata rispondesse: Caja, quasi come per questo elle dovessino pigliare augurio di futura modestia. La qual cosa quantunque ella paia minima appresso de’ superbi animi di quegli che sono al presente, non dubito che appresso dei savj uomini, considerata la semplicità di quel tempo, parrà indino d’ottima donna, e molto laudabile.
CAPITOLO XLV.
Saffo Poetessa.
Saffo Poetessa fu una fanciulla dell’isola di Lesbo della città di Mitilene: e di sua origine, non rimase altra cosa. Ma se noi guardiamo allo studio, quello che lo tempo ci ha tolto vedremo in parte restituito; quella cioè essere nata di nobili e onesti parenti; perchè quello non potè mai essere desiderato da vile animo, e a quello non potè mai venire alcuno d’animo popolaresco. E benchè non si sappia in che tempo quella fusse, nondimeno ebbe sì nobile animo, che essendo in fiorita età e bellezza, non fu contenta solamente sapere congiugnere insieme le lettere, ma confortata da più caldo furore d’animo e da più vivacità d’ingegno, montata a più alto studio per l’altezza di Parnasso, montò a quella, non rifiutandola le Muse, e cercato, arrivò infino al bosco dell’alloro, e al tempio d’Apollo; e bagnata nella fonte de’ poeti, preso la cetera, facendo la danza le sacre Muse, essendo fanciulla, non dubitò suonarla e pronunziare versi: le quali cose sono parute molto faticose eziandio a studiosi uomini. Perchè dire più parole? ella per lo suo studio arrivò a grado, che infino al presente i suoi versi sono famosi. Per testimonianza degli antichi, fu diritta a lei una statua di metallo consacrata a suo nome, e ella fu annoverata fra i famosi poeti. E certamente non sono più famose le corone dei re che la sua corona, nè le mitre dei sacerdoti, nè le laure de’ trionfanti. E (se creder si dee) come ella fu felice di suo studio, così fu infelice di suo innamoramento, perchè presa ella d’amore, occupata da intollerabile pestilenza d’un giovane; o che per piacevolezza di quello, o per bellezza, o per qualche altra cagione, non volendo egli consentire a suo desiderio, ed ella dolendosi della sua ostinata bellezza, descrisse versi contro a quello; i quali io avrei pensato elegie, perchè quegli sono appropiati a siffatta materia, se io non avessi letto, che ella, quasi dispregiata la forma dei versi trovata da altri passati, trovò nuova generazione di versi con certi piedi, quali ancora sono denominati di lei. Ma che diremo noi? è da biasimare le Muse, le quali, sonando Anfione, poterono muovere i sassi delle montagne; e, cantando Saffo, non valsero a mollificare il cuore di uno giovanetto.
CAPITOLO XLVI.
Lucrezia Romana, moglie di Collatino.
Lucrezia Romana moglie di Collatino, fu la guida della umana castità, e santissimo nome dell’antica modestia, fu figliuola di Lucrezio Spurio Tricipitino, famosissimo uomo tra i Romani, e fu moglie di Collatino, il quale era stato fratello di Tarquinio Prisco. È incerto se ella parve più bella tra le altre donne romane per la bellezza o per la onestà. E tenendo assediata Ardea città, Tarquinio Superbo, e ella essendo andata a Collazio, castello del marito non molto lungi dalla città di Roma; avvenne che nel campo, durando l’assedio per lungo spazio, cenando i figliuoli del re, tra i quali era Collatino, caddero a contenzione dell’onestà delle mogli; e facendo ciascuno, secondo usanza, menzione della sua innanzi all’altre, vennero a questa conclusione, che apparecchiati i cavalli e montati a cavallo, andarono di notte a vedere che esercizj fussero i loro, durando la guerra, sì che elleno non sentissero. E avendo trovate a Roma le fanciulle reali con le loro pari istare in sollazzi, volti i cavagli n’andarono a Collazio, dove egli trovarono Lucrezia con le sue femmine a esercizio di tela, e non era vestita con alcuno adornamento; per la qual cosa parve più laudabile che le altre, secondo il giudizio di tutti. E benignamente ella ricevette Collatino e gli altri giovani in casa: nella quale Sesto, figliuolo di Tarquinio, guardando con disonesti occhi la bellezza, e l’onestà della donna casta, acceso di scellerato amore, deliberò con seco d’averla per forza, se per altro modo non potesse usare la bellezza di quella. E non molti dì dappoi, istimolando lo furore, lasciato di notte nascosamente il campo, andò a Collazio; dove, perchè egli era parente di suo marito, fu ricevuto da Lucrezia benignamente e onorato. Ma poi che egli sentì che tutta la famiglia taceva, e pensando, tutti i compagni tacere; con uno ignudo coltello entrò nella camera di Lucrezia, e manifestò chi egli fusse; minacciando d’ucciderla, se ella gridasse, o se ella non consentisse alla sua volontà. Lo quale, vedendo ricusare il suo desiderio, non temendo la morte; ridussesi ad una malvagia malizia, e disse che ucciderebbe un suo servo appresso di lei; e direbbe, avere morta lei e il servo, avendogli trovati in adulterio. Udite queste parole, la donna soprastette tremando; e impaurita a sì scellerata infamia, temendo che, se fusse morta, non fusse chi purgasse la sua innocenzia, con dispetto dell’anima consentì lo suo corpo all’adultero. Lo quale dappoi che soddisfece alla sua volontà iscellerata, partendosi vincitore, tornò a suo padre. Lucrezia, turbata di sì scellerato peccato, come fu dì, mandò per Tricipitino suo padre, per Bruto, parente di Collatino (lo quale fino a quel dì era stato reputato matto, e per altri parenti, e per suo marito; i quali poi che furono andati a lei, ella contò loro per ordine con lagrime le cose che Sesto avea fatte contro a lei. E consolandola i parenti, piangendo ella miserabilmente, trasse fuori uno coltello, che ella avea sotto le veste, e disse: Se io m’assolvo del peccato, non mi libero della pena; e più innanzi non viverà alcuna disonesta ad esempio di Lucrezia. E, dette queste parole, ficcossi il coltello nello innocente petto, e lasciandosi cadere sopra lo coltello, in presenza del marito rimase morta ai suoi piedi. Infelice per certo fu sua bellezza e sua onestà; la quale mai non si può lodare con sofficienti lodi tanto, quanto più aspramente la sua ingiuria fu punita. Perchè non solamente fu restorato lo suo onore bruttato per la violenza dello scellerato giovane, ma eziandio per quello seguì la libertà di Roma.
CAPITOLO XLVII.
Tamiri, Reina di Scizia.
Tamiri fu nobile reina di Tartaria. Perchè i Tartari sono in paese sterile, sotto fredda parte del cielo, vicino alli monti Rifei, e alli monti Iperborei, e questi quasi conosciuti soli a sè medesimi, è incerto di chi ella fusse figliuola e a chi fusse maritata. È famosa solamente per questa chiarezza di nobiltà, che ella fu reina, e signoreggiò aspri e indomiti popoli, tenendo già Ciro lo regno d’Asia. Lo quale forse venne in cupidità del regno de’ Tartari, acciocchè Tamiri fusse conosciuta più famosamente; e forse egli voleva piuttosto esaltare la sua gloria, che accrescere lo suo regno. E certamente egli avea udito che i Tartari erano uomini poveri e salvatichi, ma avea udito, che egli erano stati invincibili, ed eziandio da grandissimi re. Dunque egli tratto da questa cupidità condusse suo oste contro alla reina Tamiri. E sentendo ella innanzi la sua venuta, benchè quello fusse temuto per tutta l’Asia, e poco meno per tutto il mondo per le grandi cose che egli avea fatte, nondimeno ella non cercò per ambasciadori mezzani, patti di pace; anzi raunato suo sforzo, e fatta capitano della guerra, potendogli contrariare con edificj navali, lasciogli passare lo fiume Arasse con tutta sua gente e oste, e entrare nel suo paese: pensando la saggia femmina, potere molto meglio vincere la rabbia di Ciro dentro al suo paese che di fuori. E essendo certificata che egli fusse entrato nel regno, diede la terza parte del suo sforzo a uno suo figliuolo, il quale era giovanetto, e comandogli che egli andasse contro a Giro, e combattesse; il quale sentendo, che il giovine andava con l’oste, pensando sì la qualità del luogo che li costumi delle genti, deliberò vincere piuttosto quello con l’inganno che con la prodezza, e mostrò fuggire, lasciando il campo pieno di vettovaglie, e di vino non ancora conosciuto dai Tartari. Nel quale campo entrato il giovane quasi vincitore, come avesse cacciato lo nimico, allegro coi suoi Tartari, confortato non a combattere, ma a mangiare; cominciarono a divorare ampiamente lo cibo e la bevanda non conosciuta, Per la qual cosa lasciato lo magistero della milizia, venne il sonno e addormentaronsi: nel quale essendo eglino gravati, sopravvenne Ciro, e uccise quello con la sua oste; e essendo quasi certo della vittoria, fecesi innanzi. Ma Tamiri udito la morte dei suoi, benchè molto si dolesse della morte del figliuolo, non avendone se non uno; nondimeno non si diede a piangere a modo di femmina; anzi ristrette le lagrime per ira e per cupidità di vendetta, coll’avanzo di sua gente, con quell’arte che ella avea udito essere stato preso lo figliuolo, pensò potere pigliare lo nimico, benchè similmente non mandasse fuori il campo ripieno di vino. E sapendo ella i luoghi, mostrò fuggire, e condusse per lungo circuito di vie lo nimico che la segue cupidamente tra le sterili montagne, e aspre per lo freddo: e in quel luogo serrò lui, bisognoso quasi di ogni cosa necessaria, tra montagne e aspri luoghi; e volta a quegli tagliò tutta l’oste. E ancora Ciro non campò, anzi saziò l’ira di quella vedova; perchè ella con feroce animo fece cercare fra’ corpi il corpo di Ciro, e trovato quello, fecegli tagliare la testa, e comandò che fosse messa in un otre pieno di sangue de’ suoi: e quasi come ella avesse data sepoltura al superbo Re, disse: Saziati del sangue, del quale tu se’ stato assetato. Ma finalmente non abbiamo alcuna cosa che è da dire di questa donna, se non questa, la quale tanto fu maggiore, quanto fu maggiore la signoria di Ciro.
CAPITOLO XLVIII.
Lena, Greca meretrice.
Lena, secondo che pensano, fu una donna greca, la quale, benchè non fusse onesta, con riverenza nondimeno delle oneste donne e delle illustri reine, piacemi descriverla fra le famose donne. Perchè, come ho detto d’innanzi, non promisi dire solamente delle oneste donne, ma delle famose, per qual modo elle fussero famose. Ancora noi siamo sì costretti alla virtù, che non solamente dobbiamo magnificare quella che noi vediamo nata in luogo onorato, ma dobbiamo sforzarci di trar fama a quella che noi vediamo sommersa in brutto luogo, e degna chiarezza. Perchè la virtù è in pregio in ogni luogo; e non riceve brutta macchia di vizio se non come lo raggio del sole non si brutta mischiandosi nel fango. Dunque se alcuna volta noi vediamo la virtù fisa con dato esercizio nel petto d’alcuno, dovremo biasimare lo suo vizio così, che le sue lodi non siano menomate alla virtù, essendo quella tanto più maravigliosa e più degna, quanto egli era riputato più rimosso da quella. Per la qual cosa non si dee sempre rifiutare la memoria delle disoneste; anzi facendosi elle degne d’alcuna memoria per merito di virtù, debbonsi magnificare con più ampia e più lieta lode, adoperando in quella questa onorata virtù, acciocchè faccia vergogna alle lascive reine, e la viltà delle reine iscusi la disonesta lascivia di quelle; ancora acciocchè appaia, non solamente gli animi dei nobili essere costretti e congiunti ad alti titoli, e che la virtù non isdegna alcuna che la voglia. — Lena si dee mettere tra sì famosa brigata di donne; acciocchè eziandio in quella parte, nella quale adoperò valentemente, sia lodata. Dunque Lena, data a brutta disonestà, e vituperoso servigio, fu cagione che non si sapesse sua schiatta, nè suo paese. Nondimeno regnando in Macedonia Aminta, Armonio e Aratone, nobili giovani, o che fussero stimolati per liberare la patria di brutta servitù di tirannia, o per altra cagione, uccisero Hispar, crudele tiranno. E tra gli altri, che furono presi da quelli che succedeva, fu presa Lena, come se ella avesse saputo quello che era fatto, per l’amistà di quegli. E essendo costretti i congiurati a manifestare con crudeli tormenti; la dissoluta femmina, pensando con pietosa considerazione di quanto pregio fusse lo santo e venerabile nome dell’amistà, non facendogli forza, acciocchè egli perdonasse in alcuna cosa, primieramente costrinse il suo animo per lungo spazio con maravigliosa costanza, che ella non dicesse quello di che era domandata; e finalmente crescendo i tormenti, e e mancando la forza del corpo; temendo quella virile femmina, che indebolendo la corporal virtù, s’indebolisse lo mortale proposito, mutossi in maggior fortezza, e fece che la sua potenza di dire mancasse similmente con la forza: con aspro morso si tagliò la lingua, e sputolla fuori: e così con un atto famoso tolse tutta la speranza di saper da lei quello che domandavano i tormentatori. Chi dirà, che Lena abbia abitati in luoghi disonesti, se non per difetto di fortuna? E per certo ella non fu conosciuta da quello che disse, che le femmine tacevano quello che elle non sapevano. Ahimè! che alcuna volta la lasciva abbondanza della casa, e il troppo perdonare dei parenti ha condotto le fanciulle a farle cadere; delle quali la prima morbidezza se non è costretta col ferro dell’asprezza, e se non sono ritenute col continuo tenere a mente delle madri, alcuna volta cade quella che non è sospinta; e se ella, caduta, è calcata dalla disperazione dell’onore della prima onestà, non torna a casa per alcuna forza. E pensò che per questa viltà Lena cadesse, e non per malizia di natura, e specialmente se guardo alla sua virile forza circa i tormenti. E per certo prima mutola e poi tagliandosi la lingua, acquistò gloria, la quale con ornata orazione ispesse volte meritò presso i suoi Demostene.
CAPITOLO XLIX.
Attalia, Reina di Gerusalem.
Attalia forse fu famosa per la crudel mente appresso gli Egizj e quegli di Soria, più che non fu di bisogno alla schiatta di David; benchè la sua casa, bruttata d’ogni parte del sangue de’ suoi, e di morte di molte maniere, aggiunse non meno di chiarezza al suo nome di crudel fama, che le corone de’ re. Primieramente questa fu figliuola di Achab, re di Giuda, e di Jezabele reina, malvagissima femmina, e fu moglie di Joram, figliuolo di Josafa, re di Gerusalem. Finalmente Josafa e Ozia suo maggiore figliuolo, il quale era rimaso successore nel regno per la morte di suo padre, tolti di vita, Joram, marito di quella, oltre all’opinione di ogni uomo fu coronato re di Gerusalem, lo quale eziandio, volle che questa donna fusse reina; alla quale, dopa la morte di Acab, suo padre, Joram suo marito, sostituito al padre non diede poco di chiarezza. E succedendo il tempo, che fu stimolata di molte sciagure, e dopo la morte del marito vide Ochozia, suo figliuolo, sedere nella sedia del padre; acciocchè ella da ogni parte fosse splendida di reali onori. E certo essendo Ochozia morto d’una ferita d’una saetta, l’ardita donna, accesa dal desiderio del regno, avendo pensato maravigliosa opera, e preso assai animo a compierla; cacciata via la pietà di donna, non solamente lasciò di dare pianto al morto figliuolo, ma passata in più ampio pianto, se ella avesse avuto cuore di femmina, essendo ancora bagnata la terra del sangue del suo figliuolo; trasse lo suo coltello contro a tutta la successione della schiatta di David; e la perseguì tanto lungamente, infino che ella non lasciasse alcuno maschio che non fusse morto. E non campò dalla sua crudeltà se non Joas di Ochozia re, piccolo figliuolo, portato sì, che ella non se ne accorse. Perchè Iosabe sua figliuola, e innanzi sorella di Ochozia, furtivamente avea tolto quel fanciullo, e messo, che fusse salvato e nutricato, in casa di Ioadam sacerdote suo marito. E così fatta ardita donna, per lo sangue di tanti morti, malvagiamente ardì montare nella sedia reale come in possessione vôta per sua opera, e ordinare tutte le cose del regno. Perchè ci maravigliamo di Atreo, di Dionigi e di Giugurta, uomini di rigido ingegno, se noi udiamo, quegli tratti da cupidità di signoria, per le piaghe d’alcuno dei suoi essere montati ad altezza di signoria, poichè noi vediamo una donna avere morta la schiatta reale, e non avere perdonato ai suoi proprj per venire a quel grado? Dunque Attalia fu chiara di reale corona, ma certamente più riguardevole, essendo bagnata più di sangue, che ornata di dignità reale. E certo come ella volontariamente crudele era stata aspra con la spada contro alle innocenti anime della schiatta di David; così potè sentire gli altri aspri contro i suoi. Se ella volle potè vedere Joram, re di Israel, suo fratello dar, morto di molte ferite, lo suo sangue ai cani nel campo di Nèbal: così Jezabel sua madre, ornata di ornamenti reali, gittata d’una torre, e calpestata da’ piedi di quegli che correvano, e intanto trita da’ piedi e dalle ruote, che convertita in fango, non rimase alcuno vestigio dello infelice corpo. E così potè vedere diciassette suoi fratelli morti per comandamento del vincitore in un’ora presso Samaria, e circa Jezinele sua città le teste fitte su i pali, che era argomento di scellerata opera: e gli altri suoi parenti uccisi, acciocchè non campasse alcuno che non fusse morto dalla spada del nimico. E finalmente; acciocchè la scellerata donna non passasse senza pena, avendo regnato sette anni; per fattura di Joadam sacerdote, allevato Joas suo nipote re, lo quale, ella pensava esser stato morto cogli altri, ella videsi strascinata della sedia reale, gridando contro lei lo popolo; e per le mani, dei servi e dei ribaldi essere strascinata vituperosamente, gridando ella aiutorio, infino alla porta, e minacciando; e in quel luogo essere degnamente tagliata: sicchè la malvagia non andò per altra via allo inferno, che per quella per la quale vi avea mandati per innanzi tanti innocenti. Così opra la giustizia divina; la quale se indugia, non si smentica; e con più aspro giudicio adopera contro a quegli, i quali ella non vide mutare gli aspettati costumi: il quale infino che noi lo dispregiamo, non lo vogliamo credere, e non curiamo di emendarci; leghiamo noi medesimi a maggior peccato; infino che nol pensiamo, siamo devorati dalla tempesta e quando non giova piangiamo i nostri peccati. E certo la cupidigia della signoria senza ragione, è crudele: alla quale rade volte si arriva per fortuna; ma è di necessità che monti a quella per fraude o per forza. Chi vi monta per fraude, conviene che il suo pensiero sia stimolato d’inganni, insidie, agguati, sospiri e tradimenti; se per forza, soggiace agli tumulti, rumori, crudeltà, rabbia: per la qual via ti è mestieri avere possanza piuttosto dalle opere tutte degli scellerati uomini, alli quali chi non diventa servo, non è signore del regno. Che diremo finalmente? arriva alcuno a signoria: di necessità è che serri gli orecchi alle lamentanze; che egli rimuova gli occhi dai pianti, dagli peccati, e dalle morti; che il cuore induri come uno sasso, la crudeltà s’armi, la pietà sia cacciata, la ragione sia dispregiata, l’ingiuria sia onorata, le possanze sieno tolte alle leggi, sieno date alla volontà, sia mandato per la malizia, e la semplicità lordata; la rapina, la lussuria e la gelosia lodate, le quali sono rendite primiere del glorioso re: non si perdona alle divine, nè alle umane cose; le cose sacre e le maledette sieno mischiate insieme, la misericordia premuta per sommo peccato vada in sangue, gli animi pietosi abbattuti, i malvagi sieno elevati; sieno isforzate le vergini, sieno adulterati i nobili fanciulli; sia dannata la Virtù, sia perdonato il vitio e la discordia trionfi in ogni luogo cacciando la pace. O quanto è il montare di re maraviglioso! se pur quando sono arrivati alla signoria per qualunque modo, vivessero senza nocimento! ma incontanente costrignendo lo sospetto, i maggiori sono mandati in esilio, i ricchi sono ridotti a povertà, gli antichi amici sono bandeggiati, i frategli, i figliuoli, i nipoti, i padri come insidiatori, sono messi in prigione, sono morti; non si osserva fè, non si serva pietà, si vive con ansia, si dorme con difficoltà, nè si gusta cibo senza paura; tutta la vita si commette agli scellerati, cacciando prima quegli che sono fedeli. Oh, possessione desiderevole e laudabile acquistata! quanto era meglio entrare nella piccola casa del povero uomo, piena di pace, forte per sicurtà, e vota di sospetto! Queste grandi cose si tengono con tanta paura, quanto lo sangue con che elle s’acquistano. E avendo noi cacciati quegli che noi abbiamo sospetti, essendoci commessi agl’infedeli, procurando lo peccato, avviene ispesso che per opra di quegli noi abbiamo sì fatta o peggiore la fine, quale è stato lo principio, ed in un’ora con nostra morte si perde quello che per molti sciagurati giorni è raunato. La qual cosa tardi conobbe Attalia (C).
CAPITOLO L.
Clelia, vergine Romana.
Clelia, maravigliosa vergine: romana; di che parenti ella s’avesse principio, o gli antichi non l’hanno lasciato a noi di drieto; o è venuto meno per l’antichità. Ma assai si può pensare, che ella nascesse di nobile gente, perchè così mostra la nobiltà del suo attimo; e perchè ella era data per ostatica di pace tra gli altri nobili Romani al tempo di Tarquinio Superbo a Porsenna, re de’ Toscani. È da lodare lo suo ardire in più parole, e da considerare, che essendo cacciato Tarquinio Superbo per iscellerato peccato di Sesto suo figliuolo in Lucrezia; e avendo effetto i suoi inganni di tornare, vennesi in manifesta guerra. Alle quale essendo venuto a Roma Porsenna, re di Chiusi, a’ prieghi di Tarquinio, e essendo rimossi i Toscani dal passare il Ponte Sublizio per la gagliardia d’Orazio Coclite, lo quale la difendeva, ed essendo impaurito Porsenna per l’audacia di Muzio Scevola, e per la congiurazione di quello, venne a concordia co’ Romani, e per salvare quella, tolse più ostatichi; e avvenne che con più altre vergini fu mandata Clelia. Alla quale forse perchè pareva men che onore della repubblica, che tante vergini fossero tenute prese appresso uno re forestiere; armò il petto di sè, che era una fanciulla, d’audacia d’uomo; e ingannate le guardie, montò in su uno cavallo, lo quale a caso ella trovò di notte pascere sopra la riva del Tevere, non essendo stato altra volta a cavallo: e avendo tratte fuori molte delle prese fanciulle, tornolle ai suoi, non temendo la profondità del fiume. La qual cosa la mattina veduta da Porsenna, dolsesi; e fu comandato nel pieno Senato, che quella, che era stata guida di quelle che erano fuggite fosse restituita al re. Ma il re maravigliatosi della virtù della fanciulla, dilettandosi del suo ardire, non solamente concedè a lei, che ella tornasse a’ suoi, ma diedele arbitrio che ella menasse con seco degli ostatichi quegli che ella volesse; la quale di tutti tolse solo i fanciulli. La qual cosa parve laudabile onestà di quella vergine: e agli Romani fu grata simigliantemente, perchè avea liberati quegli che erano più atti a ritenere l’ingiuria. Per la qual cosa ella fu onorata da’ grati cittadini di una maniera di non usato onore, e fu conceduto a quella una statua di cavalleria, la quale posta al fine della Sacra via per lungo tempo stette salva.
CAPITOLO LI.
Ippo donna Greca.
Ippo fu una donna greca secondo assai si vede manifesto per li libri degli antichi; la quale appena crederò essere stata volente per una sola opera: e perchè noi montiamo ad alte cose per gradi, perciò niuno diventa subitamente sommo sia poichè per malignità di smenticanza la schiatta sua, la patria e l’altre cose sono perite, acciocchè non perisca quello che è pervenuto insino a noi, e che non le sia tolto lo debito onore, vennemi in animo di farlo manifesto: Dunque dico che avemo trovato questa Ippo per caso essere stata presa da’ naviganti nemici; la quale a caso essendo bella, sentendo che quegli che l’avevano presa facevano consiglio contra a lei, e contro a sua onestà; stimò di tanto pregio l’onore della castità, che non vedendo poterla salvare se non con la morte, non aspettò d’essere sforzata, ma gittossi in mare, nel quale ella perdè la vita, e l’onestà fu salvata. Chi non loderà sì costante deliberazione d’una donna? poichè ella con pochi anni, che ella poteva con dubbio allungare la vita, ricomperò la castità, e con acerba morte ella acquistò a sè perpetuale onore. La quale virtuosa opera non potè tenere nascosto lo tempestoso mare, nè lo deserto lido le potè torre che non le fusse servata in luce con suo onore in perpetua testimonianza delle lettere. Ma poi lo corpo, che per alcuno spazio fu sbattuto dalle onde, per modo, d’uno gioco fu gittata da quelle medesime sul lido Eritreo, dove da quelli del paese fu seppellito, come quelli che pericolano. Ma finalmente per nominanza detto dai nemici chi fusse stata quella e perchè ella fusse morta, fu fabbricato sopra lo lido con grande altezza dagli Eritrei, con somma rererenzia, una sepoltura, dove era era stata seppellita, acciocchè noi conosciamo, che la chiarezza delle virtù non si può oscurare per alcuna avversità di fortuna.
CAPITOLO LII.
Megulia Dotata.
Megulia, la quale gli antichi Romani chiamarono Dotata, penso io, essere stata romana in quella rozza, e, acciocchè io la chiami così, santa età, nella quale quegli che cercarono le splendide cose d’Asia e le ricchezze dei grandi re, non usciti ancora dalle braccia della povertà ottima nutricatrice, dispregiata quella, non aveano guastato lo nobile animo. La quale donna acquistò per soprannome Dotata, secondo che io penso, piuttosto per chiarezza de’ suoi, che per merito d’alcuna sua opera. Perchè in quel tempo parve sì maravigliosa cosa dare in dote cinquecento migliaia di danari, che fu posto nome, a chi si dava, Dotata: e perseverò per molti tempi intanto, che se, oltre all’usato costume, fusse aggiunto alcuna cosa alla dota d’alcuna fanciulla, incontanente era chiamata Megulia Dotata. O buona semplicità! o laudabile povertà! quello che la povertà faceva parere maravigliosa cosa giustamente, ora parrebbe uno scherno alla lascivia presente. Perchè noi abbiamo intanto passato d’ogni parte la misura, che appena lo calzolaio, appena lo marangone, appena lo bastagio ovvero lo villano troverai, che per sì piccola cosa ovvero dote voglia tor moglie. E non è maraviglia, perchè eziandio una femmina di popolo ha preso le corone delle reine, fibbiale d’oro, fregiature ed altri ornamenti le usano quegli, non dirò superbamente, ma senza vergogna. E non so se io dica, gli animi, sono sì ingranditi, troppo consentendo, a noi; o se piuttosto, che penso sommamente vero, per nostro difetto sono sì amati i vizi e gl’insuperabili desiderj degli uomini.
CAPITOLO LIII.
Veturia, donna Romana.
Veturia, nobile donna romana, essendo già vecchia, con laudabile opera trasse gli suoi anni a laudabile verdezza. E questa avea uno figliuolo Gneo Martio d’ardita virtù, e pronto di consiglio e di mano. E avendo assediato i Romani Coriolo, terra de’ Volschi per la gloriosa virtù di quello, parve che fusse vinta; di che egli acquistò per soprannome Coriolano, e sì grande benevolenza dei nobili, che ardiva fare ogni cosa, con parole e con fatti. Per la qual cosa, avendo Roma carestia di biada, e per opera de’ senatori essendone condotta molta di Cicilia; con aspra orazione vietò, che non fusse venduta e partita tra il popolo, infino che non fussero restituiti ai nobili gli onori che il popolo gli avea tolti poco avanti per la tornata, quando il popolo era partito da Roma, e andato al Sacro Monte. Contro al quale lo popolo affamato si sarebbe mosso, se non fusse che il Tribuno, come bisognò, determinò lo dì a disputar la questione. Egli non obbedì; ma sdegnandosi, fu sbandeggiato, e fuggì appresso i Volschi, poco innanzi nemici de’ Romani, dai quali fu ricevuto graziosamente, perchè la virtù ha pregio in ogni luogo, E questo ridusse i Volschi a guerra con i Romani per la sua fraude siccome per l’inganno di Accio Tullio Volsco. E fatto capitano di quegli, condusse l’oste alle fosse Duxille quattro miglia presso a Roma; e ridusse i Romani a tanto, che mandarono ambasciadori a quello bandeggiato, dimandando pace con giuste condizioni; i quali Marzio rimandò nella patria con aspra risposta. Per la qual cosa furono rimandati da capo, ma non furono ricevuti; la terza volta furono mandati i sacerdoti con le loro veste è co’ loro ornamenti, e tornarono senza effetto. E già da ogni parte la disperazione era entrata negli animi dei Romani. Ecco che molte donne con lamentanza andarono a Veturia, madre di quello, e a Volumnia, sua moglie; e ottennero, che quella donna già vecchia, con la moglie di lui andasse al campo de’ nemici, con prieghi e con lagrime a mitigare lo figliuolo, poichè la repubblica non si poteva difendere dagli uomini con le armi, e con lei andarono molte altre donne. La cui andata come Coriolano seppe, benchè egli avesse enfiato l’animo, ismarrito nondimeno per l’andata della madre, smontò di sedia, e uscì della tenda, andandole incontro per riceverla. Ma Veturia, tenendo dall’una parte la moglie, dall’altra i figliuoli di Coriolano, come vide lo figliuolo, messa giue la pietà della madre, levossi in ira; dove ella era uscita da Roma umile, andando al campo de’ nemici diventò riprenditrice; e preso forza nel debole petto, disse: Sta fermo, furioso giovane, io vorrò sapere innanzi che io ti abbracci, se tu vieni a ricevermi come madre, o come nimica; che io ti stimo nimico. Dovevami la lunghezza della vita desiderata dagli uomini condurre, che io misera, vedessi te dannato in esilio, e poi nimico della repubblica. Dimando, se tu conosci in qual terreno tu sii armato? conosci tu la tua patria, la quale tu hai presente? e se tu nol sai, questa è la patria dove tu fosti ingenerato, dove tu sei nato, dove per mia fatica tu se’ nutricato. Dunque con che animo, con che pensiero, con che furore hai tu potuto muovere l’armi di nimico? non t’è venuto a mente l’onore dovuto a tua madre, lo dolce amore della tua donna, la pietà dei figliuoli, e la naturale reverenzia della patria? non poterono queste cose muovere l’aspro petto, non poterono ammortare l’ira, quantunque fusse presa giustamente? Non ti tornò a memoria, quando tu vedesti dapprima quegli edificj, che dentro a quegli sono le tue case, e gli tuoi idoli e li miei; che dentro a quel luogo sono, tua donna e tuoi figliuoli e la infelice madre per sua sciagura e per mia opera? Sono venuti i sacerdoti, e non hanno potuto muovere lo tuo petto, pregandoti che tu facessi quello che tu dovevi fare di tua volontà. Assai misera mi considero, che sei, o figliuolo, e mia avversità, e della patria? Dove io pensava avere partorito figliuolo e cittadino, veggo che ho partorito nimico odioso e implacabile. Certamente era assai meglio non aver partorito; e Roma avrebbe potuto stare senza assedio per la mia sterilità, e io, miserella vecchia, poteva morire in libera patria. Ma io non posso sostenere alcuna cosa, che, a te vituperosa, può durare lungamente: di questi tuoi figliuoli e figliuole considera, che se tu segui, o morranno innanzi al tempo, o verranno in lunga servitù. E dopo le parole seguì lo pianto, e dopo i prieghi della moglie lo abbracciare de’ figliuoli, e lo gridare delle donne che piangevano e pregavano. Per le quali parole pianti e prieghi, avvenne, l’ira dello aspro Capitano si mosse per reverenza della madre; la qual cosa non avea potuta fare la maestà degli ambasciadori; e lo proposito fu mutato. Poi, abbracciato i suoi e data licenza a quelli, fece cessare indietro lo campo da Roma. Della qual cosa avvenne, acciocchè, la gloria di quella donna non fusse tratta, dalla ingratitudine, che per decreto del senato in quel luogo dove Veturia avea mollificata l’ira del figliuolo fu edificato uno tempio di pietre cotte a perpetua memoria di quella cosa, e uno altare alla Fortuna delle donne. La qual cosa certamente, benchè sia vecchissima, dura infino alla nostra età, non diminuita quasi in alcuna cosa. Ancora determinò lo senato, che passando le donne alle quali infino a quella età non era fatto niuno, ovvero piccolo onore dagli uomini, che gli uomini si levassero, e dessero loro la via; la qual cosa si serva ancora nella nostra patria per l’antica usanza: e che fusse loro lecito portare l’ornamento antico delle donne d’Oriente nelle orecchie, vestimenta vermiglie, fibbiale, e presure d’oro. E sono alcuni che affermano, che per quello medesimo dicreto del senato fu aggiunto, che potessero acquistare ereditadi di ciascuna persona, la qual cosa non era lecito innanzi. E pensano alcuni, che la sentenza sia in dubbio, se questo pagamento fu più odioso agli uomini, o se egli dee essere più grato alle donne: la qual sentenza io penso, essere certissima: per che per gli ornamenti si consumano le ricchezze de’ mariti, e le donne vanno adornate d’ornamenti di re, i mariti impoveriscono consumando l’eredità de’ suoi passati, s’arricchiscono le donne acquistando, sono onorate eziandio quelle che non sono nobili; molte cose sono seguite a quegli disconce, a queste comode. Io maladirei Veturia per la superbia che è seguita alle femmine da queste cose, se non fusse stata salva la romana libertà per gli suoi prieghi. Ma io non posso lodare quella troppa cortesia del senato, e il costume durato dannoso pero tanti secoli: le donne sarebbero state contente di minor danno; e pareva grandissima cosa lo tempio consacrato alla Fortuna delle donne. Ma che diremo noi? lo mondo è cosa di femmina, e gli uomini è cosa femminile. E quel che è stato avverso agli uomini, l’età che consuma molte cose utili, non ebbe potuto consumare o menomare alle donne la sua ragione, servandola quelle con tenace perseverazione. Dunque lodino Veturia, e onorino la suo nome e lo suo merito, quante volte elle s’adornano di care pietre, di porpora e di fibbiale; e andando, gli uomini si levino da sedere; e poi che sono morti s’annoverino le ricchezze dei morti.
CAPITOLO LIV.
Tamiri dipignitrice.
Tamiri, a suo tempo fu nobile dipignitrice, della cui virtù benchè l’antichità n’abbia forse tolto molto, non gli ha potuto torre ancora la sua nobile nominanza, nè lo suo artifizio. E dicesi, nella nonagesima Olimpiade, che ella fu figliuola di Micone dipintore; ma perchè noi abbiamo letto, che in un tempo furono due Miconi famosi ad Atene amendue dipintori, non è fatto differenza se non in queste poche parole: Ella fu figliuola di quello Micone, che fu chiamato Minore per soprannome. E certo, di quale ella fusse, fu di sì maraviglioso ingegno, che, dispregiati gli esercizj delle donne, seguì l’arte di suo padre. Sicchè, regnando in Macedonia Archelao, acquistò gran gloria nella pintura; intanto che dagli Efesj, appresso dei quali Diana era adorata di speziale onore, fu servata la sua figura dipinta con la propria mano di quella in una tavola, e tenevano come rara: e durando quella in lunghissimo tempo, diede grande testimonianza di questo artificio, che infino a questo tempo pare maravigliosa cosa, e più da lodarla, se noi consideriamo le fusa e gli strumenti dell’arte.
CAPITOLO LV.
Artemisia, Reina di Caria.
Artemisia fu reina di Caria, e fu una donna di gentilissimo animo, e di santissimo e molto rado amore, e fu intiero sempiterno esempio di vedovità. E benchè non sia pervenuto alli nostri dì di che parenti o di che patria questa sia nata, basti averla conosciuta per lode di sua nobiltà, che ella fusse moglie di Mausuleo, in quel tempo re di Caria, lo quale amò tanto sua vita, che vivendo ella dopo di lui, non potè dimenticarlo morto. Della qual cosa per lungo spazio stettero le vestigia maravigliose. Perchè, se fè si dovesse poi dare ai famosi scrittori, come l’amato marito morì, fece la sua sepoltura con meravigliosi onori; e non comportò dopo la combustione del corpo, che fusse riposto il cenere per conservarlo in un’urna d’oro; stimando ogni altro vaso insufficiente a sì amato marito, salvo che il petto, nel quale lo fuoco dell’antico amore ardeva molto più che non era usato, dopo la sua morte. Per la qual cosa quello che era avanzato dalla parte terrena, acciocchè stesse dove stava la perpetuale memoria della passata vita, ricolse, e mischiandolo nella bevanda, appoco appoco bevvelo tutto. E il resto di sua vita fu consacrato a perpetue lagrime; e consumando sua vita, credendo andare al marito, morì allegra. Ma per ispazio di sua veduità fece gran fatti. Fu antica usanza, a’ nobili uomini. edificare maravigliose sepolture: acciocchè lo edificio convenisse con l’amore in apparenzia, Artemisia pensò fare maravigliosa sepoltura di somma spesa, mettendo giuso ogni avarizia; e, non contenta dello ingegno d’uno maestro, chiamò a sè quattro maestri, li quali in quel tempo Grecia riputava più eccellenti di tutto il mondo, Scofa, Briasse, Timoteo, e Leotare; e secondo lo consiglio di quegli fece disegnare a Mausulo, suo marito, magnifica sepoltura. E apparecchiati i marmi, fecelo edificare; acciocchè per quello maraviglioso edifizio la fama del suo diletto marito diventasse eterna, se per altro modo non fosse. Del quale certamente, perchè quegli passò quasi tutti gli edifizj del mondo, sì per lo edifizio, e sì per la spesa, e sia stato chiamato per lungo tempo uno de’ sette miracoli dello mondo, non sarà da biasimare se io farò di quello speziale menzione, perchè durerà la fama di quegli ingegnieri, e diventerà più chiara la magnificenza di quella femmina. Formarono di comandamento della Reina quella sepoltura in forma quadra presso Alicarnaso, città di Caria; e quelle due facce che guardavano ad austro e a tramontana erano lunghe di misura di LXIII piedi, le altre due facce non erano sì lunghe, elevate CXL piedi; e vollero che egli fosse circondato intorno di XXXVI colonne di marmo. Poi quella parte che guardava a levante, dicono che Scofa la intagliò, e quella ch’era volta a tramontana intagliò Briasse, e quella che è volta a ponente intagliò Leotare, la quarta fu lasciata a Timoteo. I quali dello intagliare delle statue, delle storie, e l’altre cose che appartenevano all’opera, con tanta sollecitudine desideravano esprimere la forza del suo ingegno per ciascuno di maraviglioso magistero, che era creduto da quegli che guardavano alcuna volta i volti di marmo essere vivi, e non solamente parve allora, ma dappoi per lunghi tempi parevano, che in quello edificio le mani degli artigiani avessero combattuto per la gloria. E non avvenne che Artemisia vedesse compiuta la maravigliosa opera, perchè morì innanzi: e nondimeno i maestri non abbandonarono l’opera per la morte della Reina; anzi pensando, quella esser certissima testimonianza a quegli che seguissero degli loro ingegni, condussero a fine quello che eglino aveano cominciato. E aggiunsesi di nuovo quinto maestro, lo quale uguagliò l’altezza del colmo di sopra per XXIV scaglioni; e a questo fu aggiunto il sesto intagliatore, lo quale fece un carro di marmo intagliato sopra l’altezza di tutto questo eccellente edificio, chiamato per nome del re, Mausuleo, per lo quale fu fatto: dal quale, come da più degno, sono chiamate Mausolei le sepolture dei re. Fu famoso l’amore del matrimonio di Artemisia; e ancora fu più famosa la perseveranza della veduità e delle lagrime; e non meno la sepoltura maravigliosa, o che tu voglia dire quella che fu intagliata, o il petto di Artemisia, nel quale riposò la posta cenere del marito. Ancora non fu da chiudere la virtù d’Artemisia solamente con queste lodi; perchè quella donna per virile vigore e ardire, e per disciplina di milizia, e con trionfi adornò la maestà del suo nome. E benchè spesso altre volte pigliasse arme, abbiamo letto, che dopo la morte del marito ella, messo giù il pianto al tempo, prese l’arme, almeno due volte; primieramente per difendere la salute della patria, la seconda per servare fè di compagnia, essendo ella richiesta. Perchè dopo la morte di Mausolo, essendo indegnati quegli di Rodi, i quali non sono molto di lungi d’Alicarnaso, che una donna signoreggiasse lo regno di Caria; con una armata quasi con certa speranza d’occupare quello andavano con gran moltitudine. È Alicarnaso una città posta sopra il mare Icario in luogo forte per natura; la quale ha due porti, de’ quali quello che è chiamato minore è dentro della terra, con istretto introito, e quasi nascosto, sì che in quello dalla casa reale si può portare ogni cosa che bisogna, non vedendo alcuno della città, non che quegli di fuori; l’altro, che è maggiore, e congiunto alle mura della città con aperto mare. Nel quale sapendo Artemisia, che quegli di Rodi dovevano entrare, comandò che i suoi fossero armati, e tolti con seco alcuni amici di Nautico e d’Epipate nocchieri per compagni, e apparecchiati quelli, i quali erano di bisogno compiere il fatto già pensato, comandò ai cittadini, che facessero carezze a quegli da Rodi, infino che ella facesse segno, e che dessero loro speranza, e, se potessero, che gli conducessero infino alla piazza. Finalmente, come la cosa fosse non accorgendosi i nemici, uscì fuori per lo minore porto al largo mare; e vedendo già fatto segno, quegli da Rodi chiamati in terra, lasciata l’armata, come vincitori correndo in piazza n’andarono, con altre sei navi pigliate per forza le navi di quegli da Rodi che erano abbandonate, e levato il romore, comandò, che da ogni parte i suoi cittadini corressero contro a quegli da Rodi. Per la qual cosa avvenne, che pon potendo quegli fuggire d’alcuna parte, furono tutti morti da quegli di Alicarnaso. Fatto questo, Artemisia con l’armata de’ nemici, ornando quella con segno di vittoria, drizzò le prode verso Rodi: onde vedendo i Rodani da lontano le loro navi laureate, pensando, che gli loro cittadini tornassero vincitori; aperte le porte della città, non accorgendosi che quegli che venivano erano nimici, ricevettero quegli in luogo di cittadini, e così subito la loro città fu presa da Artemisia. E fu comandato da quella che fossero morti i principi della città; e poi comandò che in segno della vittoria fossero rizzate due statue di bronzo, delle quali l’una presentava la figura d’Artemisia vincitrice, l’altra la figura della città di quegli da Rodi; e in quelle eran versi che significarono le cose fatte da lei: fatta quell’isola sua tributaria, lasciolla e tornò a casa. Ancora venendo Serse, re di Persia potentissimo, contro ai Lacedemoni con grandissimo oste per terra e per mare, coprendo tutti i lidi con le navi, credendo, per suo giudicio, non pigliare solamente, ma divorare tutta la Grecia, richiese Artemisia la quale andò con lui alla guerra con navi armate. E già essendo sconfitto l’oste di Serse per terra, e l’armate di Serse venendo a navale battaglia con quegli d’Atene sotto Temistocle capitano, stando Serse a vedere in luogo sicuro, Artemisia tra i suoi primi principi, confortandogli, combatteva arditamente, quasi come ella avesse mutato natura, intanto che, se Serse avesse avuto sì ardito e sì robusto animo, non facilmente la sua armata si sarebbe voltata a fuggire. Sono nondimeno alcuni che dicono, che questa Artemisia non fu questa, anzi fu Artemedora, similmente reina di Alicarnaso: e affermano, per testimonianza di sua credenza, che la battaglia navale di Serse fu appresso a Salamina la settuagesima Olimpiade. Ma io mi accosto a quegli che pensano, Artemisia e Artemedora fussero una medesima cosa. Ed è manifesto, che Artemisia fe’ edificare lo Mausoleo la centesima Olimpiade: conciossiacosachè quelle cose che si contano di Artemisia siano molto credute, e diano molta fede di sè, e tolgano fede all’altrui. E nondimeno qualunque leggerà creda quello che vuole: o due o una che fossero, fu opera di femmina ciascuna. Ma noi, considerati i fatti di Artemisia, che possiamo pensare, se non essere fatto per errore della natura, che sia dato a un corpo sesso di femmina, nel quale sia infonduto da Dio un’anima virile e magnifica?
CAPITOLO LVI.
Virginia, figliuola di Virginio.
Virginia per lo nome e per lo fatto fu una romana vergine da farne menzione con pietosa memoria, perchè la fu di maravigliosa bellezza, e fu figliuola di Virginio, uomo di popolo, ma onesto; la quale benchè fusse di ottima onestà, non è sì famosa per sua continenzia, quanto per la scellerata nominanza del suo amante, e per quello che fece lo suo padre, e per quella libertà romana che seguì. Questa per certo, signoreggiando in Roma i Decemviri, fu promessa per moglie da suo padre a Icilio Tribuno, ed aspro giovane, e a caso erano indugiate le sue nozze, perchè erano i Romani ad Algida contro agli Equi, e perchè Virginio era in quella milizia. Le quali cose stando così, avvenne per isciagura di Virginia, che Appio Claudio Decemviro, lo quale era rimaso solo a guardare Roma con Ispurio Appio di tutti i compagni, s’innamorò si della bellezza di quella, che egli moriva. E non piegandosi la tenera Virginia per sue lusinghe e gran doni, nè per prieghi, nè per minaccia, salvando ella il suo petto pieno di santità; accesosi Appio di matto furore, e volgendosi l’animo vago a diverse cose, non pensando essere assai sicuro isforzarla pubblicamente; Tolse l’animo a inganno, e dispose che Marco Claudio, suo servo, uomo di gran presunzione, come più tosto quella fanciulla passasse per piazza, pigliasse quella come sua serva fuggitiva, e menassela a casa; e se alcuni gli contraddicessero, incontanente gli facesse citare innanzi a Appio. Dopo pochi dì con presuntuoso ardire, passando ella, lo servo la prese, dicendo: Ch’ella era sua serva: ma gridando la Fanciulla, e facendo resistenza allo malvagio uomo, ajutandola le donne con le quali ella andava; subito la gente cominciò a correre, tra i quali corse Icilio: e dette molte parole dall’una parte e dall’altra, avvenne che ella fu menata in palagio innanzi allo amante come giudice; e appena si potè ottenere dallo ardente giudice, che la sentenzia si fusse indugiata infino al dì seguente: nel quale fatto non giovò lo inganno di Appio; il quale, perchè Virginio era al campo, avea ordinato agli capitani, che non fusse lasciato venire a Roma, se fusse mandato per lui. Ma subito come padre si presentò advocato della figliuola, e cogli amici e con Icilio, impolverato si presentò in palagio; dove dall’altra parte Marco Claudio domandando la serva, lo lussurioso giudice, non udito Virginio, sentenziò che Virginia era serva fuggitiva; e volendola pigliare Marco, e Virginio avendo dette molte belle parole indarno contro a Appio, appena ottenne potere favellare alquanto con la balia, acciocchè fusse trovata la verità dello antico errore, e egli lasciasse la serva con minore sua indegnazione: e essendo uscito fuori in luogo pubblico, nondimeno presso al palazzo presso alle taverne Gloatine, pigliò un coltello da beccaro, e disse: Figliuola mia cara, io difendo la tua libertà per quel modo ch’io posso; e lo ficcò nel petto della figliuola con grandissimo dolore di quegli che erano presenti. Della quale ferita la infelice Fanciulla in presenza di quegli cadde morta, e così fu vana la vituperosa speranza del lussurioso Appio. Per la morte di quella innocente e per opera di Virginio e di Icilio avvenne che partendosi la seconda volta lo popolo, i Decemviri furono costretti a rifiutare la signoria, e che egli lasciassero la libertà, che eglino aveano occupato, al popolo. E non molto dappoi per procurazione di Virginio, Tribuno del popolo, fu citato Appio Claudio; lo quale andando al palazzo a rispondere, di comandamento di Virginio fu tratto in prigione, e fu legato con catene; e acciocchè nocente fuggisse la vergogna, della quale egli era degno, e purgasse l’ingiuria dell’innocente Virginia; in quel luogo finì sua vita con uno coltello, o con uno laccio, o di veleno. Ma lo presentuoso famiglio Marco Claudio non per la debita via pianse lo peccato commesso, perchè egli fuggì; e i suoi beni e quelli del padrone furono pubblicati al comune. Non è niuna cosa più mortale che il malvagio giudice: e quante volte questo segue la signoria della scellerata mente, è necessario che tutto l’ordine della ragione si perverta, la possanza delle leggi si rompa, l’opera della virtù indebolisca suo stato, venga lasciato lo freno alle cose scellerate, e brievemente ogni bene comune vada in rovina. La qual cosa se non è assai ben manifesta, la scellerata impresa d’Appio, e le cose che seguirono di quello la chiariscono. Affanno a dire, perchè, male infrenando lo potente uomo la sua lussuria, poco meno fece per lo suo fraudolente liberto serva quella che era libera, adultera quella che era vergine, puttana quella che era maritata; per la sua vituperosa sentenzia, avvegnachè il padre prese le armi contro alla figliuola, la pietà si convertì in crudeltà: e acciocchè quello scellerato uomo non godesse di suo desiderio, acquistato con fraude, fu morta quella innocente Giovane, fu levato il romore in Roma, fatto tumulto nel campo, partissi lo popolo dal Senato, e quasi tutto il fatto di Roma fu posto in pericolo. O come quello era rettore glorioso, e nobile punitore delle genti! quello che egli doveva punire in altri con aspro tormento, egli non temeva commetterlo. O quante volte per questa pestilenzia periscono gli uomini! e quante volte senza colpa noi siamo tratti alla morte, siamo gravati di brutta servitù, siamo stretti, rubati, e morti, superchiando la crudeltà! Che è cosa di male che non si faccia? non temono i possenti convertire a licenza di crudeltà non atterriti da alcuno timore di Dio, quello che si trovò in temperanza di crudeltà. E dovendo quello che è signore avere ugualmente gli occhi e l’animo allo parlare umile, i costumi gravi e santi, e al postutto avere le mani nette di fatti di donne, non solamente sono lascivi cogli occhi, ma con furiosa mente non seguono la sentenzia delle leggi, anzi quella de’ ruffiani. Diventano superbi e non umili, se qualche puttanella non lo comanda, e se loro non mitiga: e non solamente ricevono i doni, ma dimandano e fanno mercatanzia e inganno; e procedono infino alla forza accesi di furore, se non possono fare altrimenti quello che egli desiderano. E così essendo diventate ottime esponitrici di leggi la lussuria e la moneta, indarno si domanda ragione al banco, se quelle o alcuna di quelle non ajutino.
CAPITOLO LVII.
Irene, figliuola di Cratino.
Non è assai certo se Irene fu greca, e in che tempo fiorisse, nondimeno fu creduto che ella fusse greca perchè è manifesto che ella fu figliuola d’un Cratino pintore, e fu sua discepola nell’arte, nella quale penso tanto degna di laudabili parole, quanto dell’arte, e della fama ella avanzò lo maestro; stando ancora in più cose la sua nominanza; e essendo lo padre non nominato se non per quella; salvo se egli fu quello del quale si legge, che descrisse in propria formola la eccellente scienzia delle foglie, e delle radici delle erbe, benchè sia stato chiamato da alcuni Cratinas e non Cratinus. E questa Irene ebbe singolare ingegno, e artifizio di ricordanza; del cui magistero certo durò la pruova per lungo tempo: questa figurò una fanciulla la quale fu in una tavola veduta presso di Eleusi città, e così figurò Calipso vecchio, e ancora Teodoro gladiatore, e Absistene, al suo tempo eccellente saltatore. Le quali cose, perchè quell’arte è per la maggior parte rimossa da ingegno di femmina, non possono essere fatte senza grandissima velocità d’ingegno, lo quale suole essere in quelle sommamente tardo, pensai essere degna di avere alcuna fama.
CAPITOLO LVIII.
Leonzia, filosofa.
Leonzia, se penso bene, fu una donna di Grecia, e forse fu famosa al tempo di Alessandro Magno, re di Macedonia, la quale avrebbe avuto molto più chiaro e più glorioso nome, se ella avesse serbata l’onestà di donna; perchè ella ebbe somma fortezza d’ingegno. Perciocchè ella valse tanto in istudio di lettere, secondo la testimonianza degli antichi, che ella ardì scrivere contro a Teofrasto, famosissimo filosofo in quel tempo, riprendendolo; o che ella fusse mossa da invidia, o da temerità di femmina. Che dirò io, poi che la sua fama è durata tanti secoli infino alla nostra età? dirò che non fu piccolo argomento, non indizio di piccola scienza, benchè noi possiamo stimare che ella avesse invidioso animo. È certissimo argomento dunque, se ella fu valente in sì splendidi studj, non crederò lievemente che ella abbia avuto origine di bassa nazione, perchè rade volte di quella bruttura sorge eccellente ingegno. E se alcuna volta egli è infuso dal cielo, la chiarezza di quello è oscurata dall’ombra della prima sorte. Che può dare di vero splendore lo nobile sangue de’ passati, dove è la indulgenzia dei costumi? Se noi diamo fede agli approbatissimi scrittori, questa, messa giù la vergogna di donna, fu meretrice, anzi piuttosto puttanella. E come è gran peccato che quella potesse rivolgere la filosofia, maestra di tutte le cose, tra i ruffiani e brutti adulteratori, tra le meretrici per bordegli, e bruttare quella tra le disoneste camere di vituperose macchie, e calpestarla oon brutti passi, e avvilupparla per puzzolente chiaviche, se lo splendore di filosofia si può oscurare per la bruttura di disonesto petto. Dunque è da dolersi certamente, che singolare ingegno, dato dal cielo per sacro dono, sia potuto essere sottomesso a sì brutto esercizio. E certo io non so se io dica quella più forte, traendo la filosofia in così scellerato luogo, o più debole, lasciando, lo ammaestrato petto essere sottomesso alle lascivie.
CAPITOLO LIX.
Olimpiade, Reina di Macedonia.
Olimpiade, reina di Macedonia, fa famosa per molte degnità. Primieramente, se la schiatta può dare alcuna chiarezza agli uomini, ella figliuola di Neottolemo, re de’ Molossi, ebbe origine dal sangue degli Eacidi; lo quale in quel tempo, oltre agli altri di tutta Grecia, ovvero di tutto il mondo, era famoso. E avendo avuto nome Mustola, poi che fu maritata a Filippo, re di Macedonia, in quel tempo, secondo che dicono alcuni, fu prima chiamata Olimpiade. Ancora ebbe per fratello Alessandro, re di Epiro, e in Macedonia Alessandro per suo figliuolo; quale dopo la morte di Filippo fece sì gran fatti, che non fu udito, che alcuno che fusse nato, e che dovesse nascere che lo avanzasse di gloria. La qualcosa non aggiunse poco d’onore ad Olimpiade, se alle madri è gloria partorire eccellenti figliuoli. Ma questo splendore non passò al postutto, che egli non fusse alcuna volta oscurato di brutte macchie, benchè per quello Olimpiade divenne più famosa. Perchè in fiorente età ella cadde in infamia d’adulterio; della quale cosa poco o meno, niente potè avvenire più vituperoso a quella reina. E ancora, che fu più brutta cosa, fu sospetto che Alessandro fusse generato da adulterio: la quale sospezione certamente mosse tanto Filippo, che non solamente disse alcuna volta palesemente, che Alessandro non era suo figliuolo, ma ancora diffamò Olimpiade, e rifiutolla, e tolse per moglie Cleopatra, figliuola d’Alessandro Epirota. La qual cosa quanto Olimpiade portasse molestamente non si potè fingere; perchè ella la quale infino a quel dì era famosa di reali splendori, salvo di quella infamia, più chiara fu con la crudeltà. È creduto certamente, che ella stimolasse e inducesse Pausania, nobile giovane, nato dal parentado di Oreste, a uccidere Filippo suo marito; e questo di saputa d’Alessandro: perchè fu trovato per fattura d’Olimpiade a Pausania messo in testa una corona lo dì seguente, per la morte di Filippo, essendo egli in su la croce; e dopo pochi dì, di comandamento di Olimpiade lo corpo di quello fu posto sopra le reliquie di Filippo re; e secondo l’usanza di Macedonia, fu arso e seppellito onorevolmente: e ’l coltello con lo quale Pausania avea morto lo re, ella comandò che fusse posto nel tempio d’Apollo sotto lo nome di Nuscale! E fatta menare a sè Cleopatra, la cui figliuola fece prima battere a un sasso, poi vituperandola, indusse quella misera a impiccarsi a uno laccio. E finalmente fatto grande lo figliuolo di grandissime vittorie, morì di veleno in Babilonia, e Alessandro suo fratello morto in Lucania, e ella andata da Epiro in Macedonia per favore degli antichi di Macedonia, fece morire Arideo, re di Macedonia e Eurice sua moglie, vietando quelli che ella non entrasse in Macedonia; e sola vedova reina tenne lo regno di Macedonia. Ma furiando ella d’ogni parte come fiera contro allo sangue così de’ popolari come de’ nobili di Macedonia, fu assediata da Cassandro in Epidua città; e fu tanto stretta, che insieme con quelli della terra vennero a fame di tutte cose: a’ quali costringendoli, avvenne, che con patti si arrendesse a Cassandro: la quale poi che si arrendè, per tradimento di quelli ai quali ella avea morti gli parenti fu dimandata per ucciderla. Alla quale essendo mandati da Cassandro gli ucciditori, come eglino entrarono nel luogo dove ella era tenuta; ella se n’accorse: veduta la brigata di quelli, levossi senza paura alcuna; e vestita e pettinatisi i capelli, acciocchè cadendo, non paresse alcuna cosa disonestamente: feceseli incontro, appoggiandosi a due serve; e non comportò di pregarli, e non fece alcuna lamentanza nè alcuno pianto; ma volontariamente offerse lo suo corpo agli ucciditori; quasi come ella dispregiasse quello che gli robustissimi uomini sogliono molto temere: e in quell’atto si confessò veramente madre di sì eccellente imperadore, come fu Alessandro Magno.
CAPITOLO LX.
Claudia, vergine vestale.
Claudia, vergine Vestale, degnamente crederò essere stata generata dal nobile sangue dei Romani, guardando io alla maravigliosa pietà che ella ebbe verso suo padre. Per dicreto del senato con gran pompa faceva lo suo trionfo in presenza di frequente moltitudine del popolo di Roma; quando un Tribuno del popolo per ispeziale odio corse contro a quello, come contro a uno che avesse fallito; e mossosi nella frequenza con un’audacia di superbo ardire de’ Tribuni, mise le mani a pigliare per forza lo trionfante, e faticandosi di tirarlo giuso dal carro. La qual cosa vedendo Claudia vergine, la quale era tra gli altri che stavano a vedere, subito costretta da pietà, mossasi trista, e smenticandosi esser femmina con l’onestà delle bende con le quali ella era velata, non potè comportare; anzi subito correndo impetuosa in mezzo della moltitudine, facendosi furiosa far la via per mezzo la turba, misesi in mezzo, non stancandosi per fatica, dell’arroganza del Tribuno, e della gloria del padre; e, come si fusse fatto, l’ardita, cacciato via lo Tribuno, concedè a suo padre libera via a montare in Campidoglio. O come questo fu dolce amore, e invincibile pietà! Che cosa crediamo noi avere dato forza al debile corpo di quella vergine? che cosa crediamo noi avere fatto dismenticare la religione, se non vedere essere superchiato ingiuriosamente colui, lo quale si ricordava nutricatore e lusingatore con pietose lusinghe, datore de’ suoi desiderj a sua salute, cacciatore di tutte le cose nocive, e ammaestratore di più provetta età? Sia di questo si è detto assai. E domando chi riprenderà per questo di disonestà una vergine monaca, essersi mischiata nel tumulto degli uomini? chi dirà, che ella sia stata presontuosa? chi la dannerà della ragione, come ardita contro alla potenza de’ Tribuni, avendo ella adoperato a difendere suo padre sì bella e sì mirabile opera di pietà che eziandio robustissimo giovane con aspro animo non lo avrebbe potuto fare? E certo io dubiterò non senza cagione quale di due portò più maraviglioso trionfo, o il padre in Campidoglio, o la figlia al tempio di Vesta.
CAPITOLO LXI.
Virginia, moglie di Lucio Volumnio.
Fu un’altra donna vergine diversa da quella di sopra, appresso de’ Romani famosa donna, benchè questa fu figliuola d’un Aulo, uomo dell’ordine de’ patrizj. E questa, oltre agli ornamenti della nobiltà, a suo tempo fu da mettere innanzi alle altre Romane: un laudabilissimo atto di quella basterà a conoscere tutta la sua vita, e a darle debita fama. Dunque, come è assai manifesto, nella città di Roma fu già nella piazza Boaria un famoso piccol tempio d’Ercole, consegrato alla Pudicizia della patria santamente dalle nobili donne, nel quale, essendo consoli Quinto Fabio, e Quinto Publio Decio, facendosi di consentimento del senato supplicazione in tutti gli altri templi per pigliare augurj; in quello solamente le donne dei patrizj facendo sagrifizj, secondo l’usanza antica; avvenne, che Virginia con l’altre donne andò a fare sagrificio: dal quale essendo rimossa superbamente per comandamento delle donne de’ patrizj, perchè ella era moglie di Lucio Volumnio, uomo di popolo (benchè l’anno davante fusse stato console), nel sacro tempio cominciò una brieve contenzione di donne. Dove finalmente Virginia, levata da incendio d’animo maggior che di sdegno di donne, disse, sè essere onesta e patrizia, e non dovere essere mossa dal tempio della Pudicizia, benchè ella fusse stata maritata vergine a un uomo di popolo: e magnificati i fatti del marito con maravigliose lodi, indegnata tornò a casa, lasciate le donne dei patrizj. E sopra le parole aggiunse maravigliose opere; perchè avendo ella molte case della contrada Lunga, nella quale ella abitava allora, insieme con suo marito partì dall’altre in quel luogo da una parte quanto pensò che bastasse a uno piccolo tempio, e in quello luogo pose un altare, e chiamate le donne di popolo, contò l’arroganza delle patrizie; e lamentandosi della ingiuria ricevuta da quella, aggiunse: Dunque io vi priego e conforto, che come voi vedete che gli uomini di questa città hanno continuamente pugna della virtù; così tra noi voi pigliate pugna dell’onore e dell’onestà di donne, acciocchè questo altare, lo quale io ho consacrato all’onestà delle donne di popolo in vostra presenzia, in alcuna cosa più sia creduto, che ella sia coltivata da più sante e da più caste donne, che in quello; e coltivandola noi, apparirà che li celestiali altari non solamente sono dati ne’ petti dei patrizj. Oh, come furono degne, e santissime parole di donna, e come laudabile ardire e invenzione da levare alle stelle con lieta festa! Non giurò Virginia contro alle ricchezze degli uomini, nè a pigliare ornamenti di lascivia; anzi contro agli lascivi e disonesti occhi de’ giovani, e contro agli appetiti di quelli; e a meritare la gloria della sua castità procede con ottimo ragionamento e con sante ragioni, intanto che allora fu cominciato, e per lungo tempo dappoi fu fatto, che non potendo fare sacrificio in quel tempio alcuna se non di singolare onestà; e chi avesse avuto un solo marito, fusse uguale all’altare delle patrizie in santità; essendo tolta via la invidiosa speranza alli disonesti occhi de’ guardatori. E non dubito, che ella diede a molte fatica e sollecitudine di conservare la castità per la cupidità della gloria, e a fuggire la vergogna se elle fussero rimosse dal sacrificio.
CAPITOLO LXII.
Flora, meretrice Romana.
Gli antichi parono provare , che Flora fu una donna romana, alla quale quanto tolse lo vituperoso guadagno, tanto le aggiunse di nominanza la favorevole fortuna. E questa secondo che conferma ogni uomo, fu ricchissima femmina; ma è discordia come ella acquistasse le ricchezze; perchè alcuni dicono, che ella consumò tutto il fiore di sua gioventù e di bellezza del corpo per gli bordegli cogli ruffiani e scellerati giovani in pubblica lussuria; e spogliando delle ricchezze or questo or quello con lascivie e con lusinghe, come è usanza di così fatte femmine, da ogni parte radendogli e pelandogli, venne a sì gran ricchezze. Altri hanno pensato di lei più onestamente; e di lei contano piacevole e sollazzevole storia, affermando, che essendo in Roma il tempio d’Ercole Ozioso, essa incominciò il giuoco del tessere con amendue le mani; e avendo diterminato a Ercole la destra, e a sè la sinistra; fece pericolo a sè che se Ercole fusse vinto, apparecchiasse della rendita del tempio la cena a lei come amica; e se Ercole fusse uccisore, disse, de’ suoi danari fare quel medesimo. Dappoichè Ercole vinse, usato eziandio di vincere le cose maravigliose, dicono, che gli apparecchiò la cena Flora nobile meretrice; alla quale, dicesi che dormendo ella nel tempio, le parve avere commesso adulterio con Ercole; e che da lui le fu detto, che ella riceverebbe lo pagamento dell’adulterio da quello che ella trovasse prima uscendo dal tempio. La mattina scontrando uno ricchissimo uomo, innamorossi di quella, e menolla a casa: e dormendo lungo tempo con lui, quando egli venne a morte lasciolla sua erede, e così arricchì. E sono alcuni che dicono, che questa non fu Flora, anzi fu Accia Laurenzia, la quale aveva nutrito innanzi Romolo e Remo, ovvero nutrito quegli dappoi; ma di questa discordia non curo; perchè sia manifesto che Flora sia stata meretrice e ricca. E questa, acciocchè io arrivi a quello che io voglio dire, venendo al termine della mortale vita, non avendo ella alcuno figliuolo, e avendo voglia di fare perpetuo lo suo nome, secondo che io penso, con uno scaltrimento di femmina, per futura gloria di sua fama, lasciò suo erede lo popolo di Roma delle sue ricchezze; salvando nondimeno parte di quelle a questo fine, che quella utilità che si ricevesse ogni anno, per annuale della sua natività fusse speso tutto in giuochi fatti pubblicamente. E non fu ingannata di sua opinione; perchè avendo acquistato la grazia del popolo di Roma per la eredità lasciata, lievemente ottenne, avere giuochi a memoria di suo nome. Nei quali giuochi in presenza del popolo (secondo che io penso, a mostrare come ella avea acquistato) tra l’altre brutte cose meretrici nude si esercitavano nell’ufficio de’ mimi con sommo diletto di quelli che guardavano, facendo atti brutti e disonesti. Per lo quale disonesto spettacolo avvenne, che quelli giuochi furono chiamati Florali dal nome di quella che gli trovò; e, o che fusse per lo modo, o che fusse per la pubblica moneta, furono dimandati ogni anno dal popolo con istanza sì fatti giuochi come cosa santissima, lo quale popolo era corrivo a lascivia. Ma per ispazio di tempo sapendo lo senato l’origine di quegli, e vergognandosi che la città, già donna del mondo, fusse bruttata come di scellerata macchia, e che tutta la città corresse alle lodi di una meretrice, e conoscendo che non potevano lievemente tor via la vergogna, aggiunse alla bruttezza un detestabile e sollazzevole errore. E finse per fama, di Flora gloriosa testatrice, una favola, e fu recitata al popolo ancora ignorante; affermando, quella essere stata innanzi una ninfa di maravigliosa bellezza, abitatrice del luogo chiamato per nome Clora; e che ella era stata amata ardentissimamente da Zeffiro vento, lo quale in latina lingua Eoi chiamiamo Favonio; e finalmente che egli l’avea tolta per moglie: egli, lo quale per loro matterìa chiamarono Dio, avevale commesso per dono delle nozze a modo di dote, como suole avvenire, la deità con questo ufficio, che nel principio della primavera ella adornasse gli alberi e le montagne e i prati di fiori, e fusse donna sopra quegli, e dappoi fusse chiamata Clora Flora: e perchè di fiori seguiron frutti, acciocchè lusingata cogli occhi la sua deità, concedesse quegli con ampia liberalità, e conducesse quegli a frutto, fu conceduto a lei dagli antichi sagrificio, tempio e giuochi. Per la quale falsità mossi, pensarono, quella, che avea abitato per li bordelli, e che eziandio per ogni minimo pagamento era stata adultera, sedere con Giunone reina e con l’altre Dee, quasi come Zeffiro l’avesse portata in cielo con le sue ali. E così Flora con suo ingegno, e con dono della fortuna, con la mala acquistata moneta, di puttana diventò ninfa, e avendo acquistato lo matrimonio di Zeffiro, e da quello la deità, fu onorata dagli uomini per li templi con divini onori, intanto che non solamente di Clora Flora, ma in ogni luogo di famosa meretrice a suo tempo, diventò famosa dea.
CAPITOLO LXIII.
Una Giovanetta Romana.
Fu una romana Giovanetta, e se io non m’inganno, non ebbe origine di viltà popolare: lo cui nome perduto per malignità di fortuna, e lo conoscere de’ suoi passati e del marito, forse parrà aver sottratto alquanto di onore; ma acciocchè non paia che io l’abbia tolto, non dandole luogo fra le famose donne, voglio porla fra quelle, e far menzione della età d’una innominata donna. Questa Giovanetta ebbe una madre d’onesta schiatta, ma sciagurata; perchè innanzi alla sedia dei Tribuni, non so per che cagione, ella fu dannata a morte, e dal Pretore era data a un Triumviro, acciocchè egli le desse la pena già determinata per la sentenzia, e dal Triumviro era data al soprastante della prigione: ma per esser nobil donna li fu imposto che fosse morta di notte. In questo mentre il guardiano, mosso da pietà, avendo compassione alla gentilezza di quella donna, non volle fare crudeltà in quella con le mani, ma, lasciandola morire di fame, tenendola serrata senza mangiare. E a questa andava una sua figliuola per vederla; e cercata quella diligentemente che non le portasse alcuno cibo, ebbe permesso dalla guardia che ella entrasse in prigione, e essendo già affamata la madre, sovvenivala del latte, dello quale ella abbondava, perchè era fresca del parto. Finalmente continuando più dì, quel della prigione cominciò a maravigliarsi che quella donna dannata vivesse sì lungamente; e guardando nascosamente che facesse la madre con la figliuola, accorsesi, che tratto fuori le mammelle, le porgeva alla madre e allattavala. E maravigliatosi di quella pietà, che la figliuola avesse trovato non usato modo di nutricare la madre, lo riferì al Triumviro, e il Triumviro lo disse al Pretore, e il Pretore lo riportò al pubblico consiglio. Per la qual cosa avvenne che fu dato per sentenzia e per dono alla pietà della figliuola la pena che debitamente dovea portare la madre. E se gli antichi donavano la corona della quercia a quegli che salvaron lo cittadino, con che corona orneremo quella figliuola che salvò la madre col latte? e certamente non si troverebbe tra le frondi grillanda sufficiente. Quest’opera non fu solamente santa, ma maravigliosa; e non solamente fu da equarla, ma premetterla al dono della natura; per lo quale siamo ammaestrati a condurre i figliuoli piccoli a più ferma etade a salvare i padri dalla morte. Dunque la pietà è maravigliosa forza, perchè non solamente passa i cuori delle donne, le quali lievemente si muovono a compassione e alle lagrime, ma alcuna volta passa i crudeli e indurati cuori per alcuna pertinacia di diamanti, e entrata dentro mollifica ogni durezza; e investigando la bisogna, e trovandola, adopera, che mischino le lagrime con le infelicitadi che seguono le turbazioni, e i pericoli, almeno col desiderio; e alcuna volta se mancano rimedj sottomettesi per quegli alla morte: e produconsi siffatti effetti, acciocchè noi meno ci maravigliamo, se noi figliuoli adoperiamo alcuna cosa di pietà verso le madri, parendo piuttosto per quello rendere nostro debito, e restituire con debito pagamento quello che altra volta avemo ricevuto.
CAPITOLO LXIV.
Marzia di Varone.
Marzia di Varone fu già trovata a Roma servare perpetua verginità: ma qual Varone si fosse, non mi ricordo avere trovato, e in che tempo. E penso, questa verginità osservata essere degna d’essere magnificata con lode; quando io penso che quella femmina di sè, di sua volontà l’abbia servata integra, e non perchè sia stata costretta da superiore, perchè non la trovo legata per sacerdozio, nè per Vesta; nè per voto fatto a Diana, nè rimpacciata per altra professione. Per le quali cose sola integrità della mente servò lo suo corpo infino alla morte, immacolato d’ogni consorzio d’uomo, vincendo lo stimolo della carne, dal quale li scelleratissimi uomini sono stati vinti. E benchè Marzia sia degna di lode per questa laudabile astinenzia, non è meno da lodarla per la virtù di suo ingegno, e per l’artificio delle mani. Questa certamente, o che ella imparasse dal maestro, o che ella l’avesse per industria naturalmente, è incerto, parendo questo certissimo, che, dispregiati gli esercizj delle donne, acciocchè non si marcisse nell’ozio, diedesi in tutto a pintura, e intagli d’immagini. E finalmente con tanto artificio e pulitamente dipinse col pennello e intagliò immagini d’avorio che superò Sopolino o Dionisio, famosissimi maestri a suo tempo: e di questo fu famosissimo argomento alcune tavole che ella dipinse, le quali furono di più pregio che l’altre. E, che è più maravigliosa cosa, non solamente, dicono che ella dipinse eccellentemente, la qual cosa avvenne a molti; ma ella ebbe le mani sì preste a dipingere, che niuno l’ebbe mai simili. Ancora per lungo tempo rimasero esempj di sua arte: ma fra l’altre la sua figura, la quale ella ritrasse con l’aiutorio dello specchio sì interamente con le linee e co’ colori in una tavola, servando l’abito della faccia, che a ciascuno di suo tempo, veduta quella, era certo quale ella fusse. E, acciocchè noi veniamo a’ suoi particolari costumi, tra le altre ebbe per usanza in ispezialità, secondo che si teneva, o che ella dipignesse col pennello, o che ella intagliasse con lo scarpello, fare ispessissime volte figure di donne, e di uomini rade volte, e non mai ignudi. E penso, che la vergogna fusse cagione di questa usanza; perchè anticamente per la maggior, parte figurandosile immagini ignude, o mezzo ignude, parevale le bisognasse o fare gli uomini imperfetti, o, se ella gli facesse perfetti, parevale che ella avesse smenticato la vergogna d’una vergine. E acciocchè non avvenisse alcuna di queste cose, pensò, esser meglio d’astenersi da ciascuna.
CAPITOLO LXV.
Sulpicia, moglie di Fulvio.
Sulpicia fu già una onorabilissima donna, la quale acquistò non meno lode, secondo la testimonianza delle donne romane, per la servata castità, che Lucrezia uccidendosi col coltello. E questa fa figliuola di Servio Patricolo, e moglie di Fulvio Flacco; e quegli amendue nobili uomini. E avendo lo senato, per ammaestramento dei libri Sibillini veduti dai Decemviri, determinato che fusse consacrata la statua di Venere Verticordia in Roma; acciocchè le vergini e le altre donne non solamente sostenessero da disonestà, ma eziandio più leggiermente si convertissero a più laudabile onestà; era stato comandato, secondo lo comandamento de’ Decemviri, per lo quale s’attendeva, che la più casta fra le donne romane consacrasse quello. E di tutta la moltitudine, della quale allora abbondava Roma, avvenne che furono elette cento, le quali fussero più famose di castità fra le altre; tra le quali fu eletta Sulpicia; e di comandamento del senato, secondo lo giudizio di quelle, ne furono elette dieci le più famose, e fra quelle dieci fu Sulpicia: e ultimamente essendo domandata una delle dieci, di consentimento di tutte fu presentata Sulpicia: alla quale benchè fusse in quel tempo bella cosa consacrare la statua di Verticordia, molto fu maggior bellezza che ella fusse in tanta moltitudine messa innanzi a tutte le altre per castità, perchè non solamente fu guardata con ammirazione di tutti quegli che erano presenti quasi come una celestiale Dea, ma eziandio parve lo suo nome portato con ogni reverenzia per tutto lo tempo da venire a gloria incorruttibile. Ma dirà alcuno: Io domando se ne furono altre cento oneste; che potesse essere aggiunto a questa più che all’altre d’onestà, perchè giustamente ella fusse messa innanzi? Manifesto è, quelle solamente parevano oneste, che sono pensate continenti di ogni altro consorzio che del marito. La quale onestà certamente, se noi vogliamo guardare con migliore occhio, non solamente sta dal contenersi del toccare degli stranj uomini, la qual cosa molti fanno per forza, ma conviene che la donna, acciocchè interamente possa tessere tenuta onesta innanzi alle altre, freni gli occhi cupidi e vaghi, e che ella gli costringa tra suoi confini; le parole poche e oneste, e favellare a tempo, fuggire l’ozio come certissimo e mortalissimo nemico dell’onestà; astenersi dal soverchio mangiare e bere, che la disonestà si tempera secondo le vivande e il vino; schifare cantare e ballare come saetta di disonestà; dar opera alla temperanza e sobrietà; aver cura delle cose della sua casa; aver serrati gli occhi a’ ragionamenti disonesti, rifiutare unzioni e odori; rifiutare soperchi ornamenti; mettere i piedi sopra i cattivi pensieri e appetiti, e a tutte forze e santi pensieri soprastare e vegghiare: e acciocchè io non trascorra ogni testimonianza d’integra onestà, amare solamente suo marito con somma dilezione, sprezzar gli altri, se non gli amasse con una carità di frategli; e ancora al marito non n’è d’appressarsi senza alcuna vergogna dell’animo e della faccia a fine di fare figliuoli. Le quali cose forse non trovandosi nell’altre manifeste, furono trovate in Sulpicia; e giustamente fu messa innanzi all’altre.
CAPITOLO LXVI.
Armonia, figliuola di Gelone.
Armonia fu siciliana figliuola di Gelone, fratello di Gerone, re di Siracusa, la quale, benchè fusse di schiatta reale, fu nondimeno molto più degna di farne menzione per la sua pietà; e sono alcuni che dissono quella essere morta vergine; alcuni dicono che ella fu moglie di Temistio; ma di queste cose sia qual più piace, poichè la diversità di queste opinioni non toglie alcuna cosa di sua pietà. Dunque essendo crudele lo popolo per occulto e subito tradimento di quegli dì Siracusa, contro a tutti quegli che erano della schiatta reale, e avendo morto Gerone, re giovanetto, e Andrenodoro, e Temistio di schiatta reale, e facendo la moltitudine tumultuoso romore contro Damarata e Erachia, figliuola di Gelone, e contra Armonia, figliuola di Gelone; avvenne per sagacità della balia di Armonia che una fanciulla adornata d’ornamenti reali, dell’età d’Armonia, fu messa dinanzi agli ucciditori per Armonia. La quale per alcuna cosa non fu contraria all’azione di quella, che l’apparecchiava; anzi vedendo la moltitudine correre contro a sè con le odiose spade, non s’impaurì, nè fuggi; e non riconfessò la sua intenzione a quegli che la ferivano; e non accusò Armonia, che era nascosta, in luogo della quale ella era morta; ma tacita, non movendosi, ricevendo i mortali colpi morì. Armonia fu insieme felice e infelice; perchè ella perdè quella che era fedele; e vedendo Armonia di lungi nascosta la perseveranzia della innocente fanciulla, e lo forte animo a morire, e vedendo uscire delle ferite lo sangue di quella fanciulla, maravigliandosi, stupida della fè di quella, con tutto lo petto sopra la morta fanciulla, già partendosi gli ucciditori, fu presa dalla gloriosa pietà, spargendo lagrime, non comportò di vedere senza pena l’innocente sangue, e allungare la vita salvata per altrui fè con tanta sollecitudine; giudicando essere meglio di scendere all’inferno con acerba morte con sì fedele fanciulla, che aspettare la canutezza cogli non fidati cittadini. O quanta pietà! o quanta ferma fè! Ella si manifestò in luogo patente; e tornati indietro gli ucciditori cogl’insanguinati coltegli, confessò lo inganno della balia, la fè di quella che era morta; e ferita di molte ferite, cadde, quanto lo potè, presso al corpo di quella che era morta: innanzi alla quale quanto la pietà le tolse di tempo, fulle renduto degnissimamente nelle scritture. È difficile a vedere, quale avesse maggior fè, o quella che morì, o quella che sopravvisse: quella pietà fè eterna la virtù della prima, questa pietà fè eterno il nome della seconda.
CAPITOLO LXVII.
Busa di Canosa.
Busa fu una donna per la prima origine da Canosa, la quale acciocchè io creda essere nata di nobile sangue, e per altri più meriti famosa, ne fa fede quello magnifico atto lo quale singolare gli antichi hanno lasciato di lei a quegli che seguono. Dicono, che facendo aspra guerra Annibale Africano contro i Romani, e guastando tutta Italia con ferro e con fuoco, bruttando quella di molto sangue, avendo appresso Canne, terra di Puglia, in una gran battaglia non solamente isconfitti i nemici, ma quasi abbattuta tutta la potenza d’Italia, avvenne che di quella sconfitta e gran mortalità la notte fuggendo per luoghi diserti, di molti dispersi e vaghi n’arrivò a Ganosa, città dieci migliaja, la qual città allora servava fè alla parte de’ Romani: i quali tutti sendo deboli, e stanchi, bisognosi, disarmati, nudi e percossi di ferite, non impaurita del caso, nè della potenzia dei vincitore, Busa gli ricevè nelle proprie case amichevolmente, e ritennegli in albergo. Innanzi all’altre cose confortò quegli, dicendo, che eglino avessero buon animo; e trovato i medici fece curare i feriti con un’affezione di madre, quegli che erano nudi rivestì, e a tutti sovvenne con maravigliosa cortesia, a’ disarmati diede arme, e continuamente de’ suoi beni fece loro le spese. E fortificati quei miseri, volendosi partire, pigliando speranza, volontariamente diede da spendere a tutti, e in niuna bisogna di quegli fu scarsa. E certo egli fu maraviglioso a dire, e in femmina molto più laudabile, che se fusse avvenuto ad uomo. Gli antichi ebbero per usanza di magnificare per cortesia Alessandro di Macedonia, assalitore di tutto il mondo: tra l’altre sue cose affermano, che non solamente ebbe per usanza di donare preziosi giojelli, molta moneta, e simili doni, secondo la cortesia degli altri principi; ma soleva alcuna volta dare agli amici signorie speziali di regni, e alcuna volta agli amici re donava i suoi regni. È certamente bella e magnifica cosa, da contarla con molte famose lodi; ma, secondo che io penso, non è da assomigliare quelle alla cortesia di Busa; perchè Alessandro fu uomo, e quella fu una femmina; e le donne sono naturalmente dimestiche e tenaci delle ricchezze: egli era un grandissimo re, questa una privata donna; quegli faceva cortesia di quello che rubava e toglieva per forza, e questa di quello che ella possedeva di suo matrimonio e patrimonio; quegli, quello che forse non poteva conservare, questa dava quello che lungamente ella avea posseduto e tenuto, e ancora poteva tenere, se ella avesse voluto; quegli dava agli amici, ed a quelli che l’avevano servito, questa dava agli stranj e non conoscinti; quegli dava, essendo i suoi fatti in prosperità; questa, stando i suoi in dubbio, e pericolando gli amici; quegli dava in paesi stranj, questa dava nella sua patria e tra suoi, essendo presente; quegli per acquistar gloria di cortesia, e questa per sovvenire a bisognosi. Perchè dico io molte parole? se noi guardiamo l’animo del maschio e della femmina, e la qualità d’amendue, non dubito, che sotto giusto giudice, Busa acquistò più gloria di sua generosità, che Alessandro di sua cortesia. Ma abbia chi vuole chiara fama: a mio parere Busa usò ottimamente le sue ricchezze; perchè la natura madre non produsse fuori l’oro dall’intrinseco della terra perchè fussero tramutate dal ventre della madre nelle arche per farne adunanza, la quale fanno gli avari, riponendole negli scrigni, e con gran guardia soprastando a quelle, quasi come l’uomo dovesse rinascere; anzi sopra tutte le altre cose le produsse, perchè siano spese a comune utilità della compagnia degli onesti amici; e se avanzano, acciocchè ajutiamo con liberale animo a quegli che sono battuti da ingiuria di fortuna, stanchi dall’ira del cielo, gravati indegnamente dalla povertà, e a quegli che sono in prigione per altrui difetto, e ciascuni che sono soperchiati da faticosa fortuna; non per guadagno, ma per fare queste comoditadi, per lo dono e ajuto, usando quello temperamento di ragione, che noi non troviamo per noi, ajutando gli altri, la povertà per la quale noi siamo costretti metter mano alle altrui ricchezze, non dico per forza, ma ancora non desiderarle con gli occhi.
CAPITOLO LXVIII.
Sofonisba, moglie di Siface, Reina di Numidia.
Sofonisba, benchè fusse famosa perchè fu reina di Numidia, diventò molto più famosa per l’asperità della morte, la quale ella elesse senza paura. E questa fu figliuola di Giscone, grandissimo principe di Cartagine nel tempo che Annibal affliggeva Italia; la quale venne data per moglie da suo padre, essendo ella vergine, a Siface, potentissimo re di Numidia; e certamente non tanto per desiderio del parentado del re, quanto quegli come uomo sagace desiderava, durando la guerra con gli Romani, non solamente sottrarre ai Romani i re barbari, ma ancora pensava, per sollecitudine di sua figliuola, con lusinghe convertire quello alla parte de’ Cartaginesi contro ai Romani: e non fu ingannato da fallace pensiero: perchè come Siface ebbe compiute le nozze, fu tratto con tanto ardore d’amore da quella fanciulla la quale era innanzi ammaestrata, ajutandola la bellezza, che niuna cosa pensava cara e dilettevole a sè se non quella. Così egli infelice usando con quella, essendovi nuova che Cornelio Scipione era per passare di Sicilia in Africa con l’oste, Sofonisba informata da Asdrubale, con lusinghe e prieghi trasse tanto a’ suoi desiderj l’animo di Siface, che non solamente egli abbandonò i Romani, ai quali egli avea promesso servare fè, e aggiunsesi ai Cartaginesi, ma volontariamente fecesi principe della guerra. Per la qual cosa, avendo sottomessa la fè alla perfidia, la quale avea promessa a Scipione, essendo egli in casa sua, innanzi che Scipione arrivasse in Africa, interdissegli per lettera la sua andata. Ma Scipione, giovane di grandissimo animo, dannata la malvagità dello barbaro re, messo in terra l’oste non molto lungi da Cartagine, vinse quello innanzi all’altre cose per Massinissa re suo compagno, e Lelio suo legato; per lo quale, avendo egli sconfitto lo suo oste, fu preso e legato, e menato a Cirta città reale in Numidia. E come egli fu mostrato legato con le catene ai suoi cittadini, fu arrenduta la terra a Massinissa; lo quale, non essendo ancora arrivato Lelio, entrò nella città, essendo tutte le cose in tumulto; e, come egli era armato, andando al palazzo del re, Sofonisfa gli si fe’ incontro; la quale conoscendo la sua fortuna, vedendo quello entrare nel portico, più adorno d’arme che gli altri, pensato che fusse il re, come egli era; servato l’animo della prima fortuna, inchinata innanzi a quello, disse così: Glorioso re, è piaciuto alla tua felicità che tu possa contro a noi, i quali poco innanzi eravamo re, ogni cosa che tu vuoi; ma se egli è permesso che io serva innanzi a te vincitore e signore della mia morte e della mia vita, possa favellare, e che io possa toccare i tuoi ginocchi, e la tua vincitrice mano; umilmente priego per la tua maestà, nella quale poco innanzi io era per la schiatta reale, e per lo comune nome di Numidia; benchè tu se’ ricevuto con migliore onore, che egli è partito di qui Siface; adopera verso me, la quale l’avversa fortuna fece di tua ragione, quello che a’ tuoi occhi parrà pietosa e buona cosa; purchè io non venga viva nel fastidioso e superbo arbitrio dei Romani. Tu puoi vedere essai lievemente quello che io, nimica de’ Romani, Cartaginese, e figliuola di Asdrubale, posto che io non fossi moglie di Siface, possa temere. E se non ci è altro modo, priegoti, e ripriegoti, faccia che io muoia piuttosto per la tua mano, che io venga viva nella potestà de’ nemici. Massinissa, lo quale era eziandio di Numidia, pronto a lussuria (come egli sono tutti gli Africani) guardando alla bellezza della faccia di quella, la quale lo pregava; e perchè lo caso avea aggiunto alcuna pietosa e non usata bellezza a lei che pregava, mosso da umanità, e tratto da lussuria, non essendo ancora sopravvenuto Lelio, come egli era, armato porsele la mano, essendo ella tra lamentevole romore di femmine, e lo tumulto de’ cavalieri, i quali discorrevano da ogni parte; levò suso lei la quale pregava, e subito la fece sua moglie, e in mezzo lo romore delle armi compiute le nozze, penso che per questa via egli credette avere trovato modo alla sua lussuria e agli preghi di Sofonisba. Poi lo seguente dì venne Lelio: e per comandamento di Scipione tornarono al campo con tutto lo reale apparecchiamento, e con la preda e con la nuova moglie. E primieramente per le benfatte cose amichevolmente ricevuti da Scipione; poi amichevolmente essendo ripreso per lo matrimonio contratto con quella, che era serva del popolo di Roma, e essendo tornato alla sua tenda, rimaso solo; dolsesi per lungo spazio con sospiri e con lagrime, intanto che egli era udito da quelli d’intorno. E costringendolo la condizione di Sofonisba, fecesi chiamare lo più fidato dei suoi servi, lo quale avea servato lo veleno in sua guardia per certi casi di fortuna; e comandogli, ch’egli portasse quello disfatto in una coppa a Sofonisba, e che le dicesse: Che volentieri le avea promesso fè per osservargliela, se potesse; ma perchè gli era tolto la speranza da quegli che potevano, davale la fè che ella avea domandata, e non senza sua tristizia; così che dovesse usar quella bevanda, acciocchè ella andasse viva in potestà de’ Romani; e nondimeno, che ella si ricordasse chi fu suo padre, e di che patria ella fusse; e che ella si ricordasse di due re ai quali poco innanzi era stata maritata; e che ella deliberasse quello che le paresse. La quale per certo, udito il messo, con costante volto disse: Io accetto il dono delle nozze, se il mio marito non può dare altro dono: ma rapportagli, che io moriva meglio se non avessi preso marito alla mia morte. E disse più aspramente queste parole, che ella non pigliò lo veleno: e non mostrando alcuno segno di paura, subito bevvelo tutto; e non insuperbita contro alla morte, che ella avea cercata, miserabile cadde. E certo sarebbe fatto grande, e mirabile cosa a uno annoso uomo che avesse avuto la vita per rincrescimento, e non avesse avuto altra speranza che di morire, non che a una fanciulla reina, la quale allora entrando nella vita (avuto rispetto alla notizia delle cose) e cominciando a conoscere che dolcezza sia in quella, è cosa degna di ricordazione, che senza paura ella andasse incontro alla morte.
CAPITOLO LXIX.
Teosena di Tessaglia.
Teosena di Tessaglia fa una donna nobile per nazione, la quale lasciò a quegli che devono seguire, gloriosa testimonianza di sè, da una parte per dolce pietà, dall’altra per costante atrocità. Questa fu figliuola di Erodico, principe di Tessaglia, nel tempo che Filippo, figliuolo di Demetrio, signoreggiava in Macedonia: e questa ebbe una sorella di padre chiamata per nome Arco. E essendole primieramente morto suo padre per malizia di quel medesimo Filippo; in processo di tempo, confortandolo la malvagità, quello medesimo uccise i mariti di quelle sorelle, rimanendo a ciascuno uno figliuolo di suo marito. Dunque essendo quelle vedove, Arco primieramente si maritò a uno principe di sua gente chiamato per nome Poride, e di quello ella ebbe molti figliuoli: ma Teosene con più costante animo domandata per moglie da molti principi indarno, stette vedova per più lungo spazio. Ma essendo morta Arco; avendo compassione a’ nipoti che non venissero nelle mani d’un’altra matrigna, ovvero temendo che eglino fussero nutricati dal loro padre meno diligentemente, maritossi a quello medesimo Poride, non essendo vietato in quel tempo per alcuna legge; e cominciò a nutricare quegli con pietosa diligenzia, come se ella gli avesse partoriti, acciocchè assai apparisse, che quella fusse maritata a Poride più per servigio di quegli, che per suo comodo. Le quali cose stando in questo modo, avvenne, che Filippo, re di Macedonia, perchè non avea animo da non istare in posa, pensava far guerra cogli Romani, gli quali in quel tempo erano famosi di chiara felicità; e avendo vôte, con grandissimo movimento del suo regno, quasi tutte le città di Tessaglia presso la marina, d’antichi abitatori; e avendo comandato, che quegli si mutassero a schiera fatta in Poema, la quale dappoi fu chiamata Emazia, paese di marina; e avendo conceduto a quegli di Tracia le sue terre come più atti e fedeli alla guerra che dovea fare; e avendo udito, che quegli i quali si partirono lo bestemmiavano; pensando, non essere sicuro, se egli non uccidesse similmente tutti i figliuoli di quegli i quali avea morti; e avendo comandato, che eglino fussero presi e messi in prigione, per farli morire non tutti in uno tratto, ma saccessivamente in processo di tempo, avvenne che Teosena sentì lo scellerato comandamento di quello; e ricordandosi di suo marito, e di sua morte, e del marito di sua sorella, pensò che fussero cercati i suoi figliuoli, e i suoi nipoti; e se venissero nelle mani del re, non solamente sarebbero uno scherno di sua crudeltà, ma eziandio sarebbero suggetti per necessità ai dispregi e fastidj delle guardie. E a schifare quello subitamente pose l’animo a crudele fatto, e ardì dire a suo marito, il padre di quegli, se non si potesse fare altrimenti, ella con le sue mani piuttosto ucciderebbe quegli; che ella comportasse, quegli essere menati alla potestà di Filippo. Ma Poride biasimando sì scellerato consiglio, per confortare la moglie, proferse per salute di quegli figliuoli, portargli via, e metterli appresso d’alcun fedele amico, e di fuggire via per sua compagnia. E non fece indugio; ma fatto vista di andare a Tessalonica per lo sagrificio alla statua di Enea edificatore, alla quale ogni anno sacrificava, partitosi da Tessalonica, e avendo consumato in quel luogo un dì nel sagrificio e mangiare e bere; entrò nell’apparecchiata nave alla terza ora della notte con la moglie e co’ figliuoli nascosamente, come egli volesse tornare nella patria, con intenzione d’andare in Eubea, e non di tornare a Tessalonica. Ma dappoi avvennegli diversamente da questo: appena egli era partito dal lido, ecco nell’oscurità della notte si levò un vento contrario lo quale nol portava dove egli desiderava andare, ma ritornavalo onde egli partito era, e sforzandosi indarno al contrario i nocchieri, fecesi dì e mostrogli che egli, era presso allo lido. Ma guardando le navi che eran nel porto la nave che era in fortuna, e pensando che eglino si sforzassero di fuggire, per menarla in porto, subito vi mandarono una barca armata e le posero gran comandamento che non entrassero nel porto senza quella nave per la quale egli erano mandati. Ma Poride, vedendo la barca, e conosciuto lo presente pericolo, alcuna volta pregava i nocchieri che vogassero con tutte forze, e alcuna volta pregava gli Dei che dessero aiutorio a quegli che perivano. La qual cosa vedendo Teosena, e conoscendo lo presente pericolo (quasi come gli Dei le avessero dato il tempo) vedendo Poride che pregava, rivolsesi per lo suo pensiero la prima pensata scelerità; e subito disfece il suo veleno in una tazza, e trasse fuori uno coltello, e mise innanzi queste cose al figliuolo e a’ nipoti, e disse: La sola morte può dare a noi tutta la difesa e salute: la bevanda e il coltello sono vie da morire, e fuggire la superbia del re per quella via che diletta a ciascuno: dunque, figliuoli miei, destate gli nobili animi, e voi che siete maggiori francamente pigliate lo ferro e la bevanda, e se vi diletta più crudel morte, rendetevi a quello, poichè il furore dell’alto mare vi vieta andare alla vita. Già i nemici erano presso alla crudel donna: essa stando confortatrice della morte, stimolava i giovani che indugiavano. Per la qual cosa già i giovani, essendo presso alla morte, essendo eglino ancora mezzi vivi, e sbattendosi, confortandogli Teosena, gittaronsi dalla nave, e ella avendo per la libertà indotto alla morte quegli che pietosamente avea nutricati; acciocchè ella non servasse per sè la servitù, la quale ella avea scostata dagli altri, con ardito animo abbracciò lo marito, confortandolo in sua compagnia alla morte, e indusse quello con seco insieme a gittarsi in mare; pensando, esser meglio morire in libertà, che, servendo, consumarsi in brutta servitù. E così lasciata vota la nave ai nemici, tolse a Filippo lo sollazzo della sua crudeltà, e l’aspra donna acquistò a sè ammaestramento degno di ricordanza.
CAPITOLO LXX.
Berenice, Reina di Cappadocia.
Berenice da Ponto, la quale fu eziandio chiamata Leodice, benchè parrà, aver luogo fra le famose donne per la chiarezza di sua nazione, molto è più giudicato averlo meritato non per lo caldo amore di suo figliuolo, per lo quale la maggior parte delle madri sono accese, ma per lo merito di sua maravigliosa audacia a fare vendetta di quello. Costei fu figliuola di quel Mitridate, re di Ponto, il quale avea fatto guerra colli Romani contro Aristonio, poco innanzi poi morto di morte subitana; e sorella di Mitridate, figliuolo del maggiore Mitridate, e nemico dei Romani per lunga guerra, la quale fu moglie del re Ariaralto di Cappadocia, del quale rimasero due figliuoli, essendo egli morto da Cordio a tradimento per opera di Mitridate fratello di Berenice. E avendo Nicomede, re di Bitinia, in quel tempo occupata la Cappadocia quasi vôta per la morte del re Mitridate, cupido di quel legno, mostrò pietà: e dicendo di ricoverare il regno ai nipoti, pigliò le armi contro a Nicomede, re di Bitinia. E avendo saputo, che Berenice vedova era maritata a Nicomede, convertì la finta pietà in guerra; e cacciato per forza d’arme Nicomede di Cappadocia, restituì lo regno di suo padre al maggiore figliuolo d’Arieralto; il quale dappoi, pentendosi del fatto, lo fece morire a tradimento. E richiamato d’Asia l’altro più giovane dagli amici, chiamato per nome Ariaratto, vedendo che regnava (secondo che alcuni dicono) per fattura di quel medesimo Mitridate; eziandio l’ebbe morto a tradimento. La qual cosa la sciagurata madre portò sì molestamente, essendo privata di due figliuoli; che, costretta dal dolore, smenticandosi esser femmina, furiosa pigliò l’armi, mise ai cavagli ’l giogo, montò in sul carro; e non cessò di seguire Cineo, famiglio del re, esecutore dello scellerato fatto, fuggendo egli prestissimamente, infino che ella lo gittò per terra, percossolo d’uno sasso, avendolo fallito con la lancia, e con isdegno menò lo carro sopra lo corpo di quello, avendolo abbattuto per terra, e fra l’arme de’ nemici, non percossa d’alcuna paura di suo fratello nemico allora; infino che ella arrivò alla casa, dove ella pensava essere serrato il corpo del morto fanciullo; e miserabile pianselo come madre, e pagò lo suo debito. O Dio! come le forze della natura sono inespugnabili! fortezza invincibile di amore! Che maggiore, e che maravigliosa cosa poteste voi fare? Voi faceste, che una femmina senza paura, armata per vostro stimolo, passasse per l’oste di formidabile re, la quale oste era temuta da tutta Asia, e forse già da Italia; e le deste vigore e ardire di vendicarsi contro l’odio portatole da lui, che come vincitore aspettava avere ad essere richiesto di grazie e non sforzato di potenza. E nondimeno alcuni hanno detto, che quello fanciullo morì per naturale infermità, il quale noi abbiamo detto essere stato morto per fraude di Mitridate, e del quale,come la madre potè, fece vendetta.
CAPITOLO LXXI.
La moglie d’Orgigante Gallogreco.
Pareva che lo non saputo nome avesse potuto torre lo degno onore e premio di speciale fama della moglie di Orgigante, re dei Gallogreci, la quale nominanza l’idioma del volgare barbaro invidioso, io penso, d’avere nascosto alle nostre lodi tra i passi del mare Mediterraneo, e le spelonche d’Asia, e tolselo agli Latini; ma non voglia Iddio che abbia potuto fare questo peccato di sciagura che sotto titolo di suo marito non le fusse dato quello splendore che possono le nostre lettere. Dunque essendo vinto da’ Romani sotto la capitanza di Scipione, lo grande Antioco, re di Soria e d’Asia; Gneo Manlio Torquato console ebbe per sorte la provincia d’Asia: e acciocchè egli non paresse aver condotta l’oste indarno, e non tenesse i cavalieri in ozio, spacciati alcuni nimici che restavano circa delle parti della montagna; contro ai Gallogreci, aspri popoli barbari, mosse guerra aspra, perchè avevano mandato aiutorio ad Antioco contro a’ Romani, e perchè alcuna volta turbavano, facendo scorrerie per tutta l’Asia. E diffidandosi già i Gallogreci di tenere le terre, lasciate quelle, partironsi, e andaro verso la montagna, luoghi forti per natura, con le mogli e coi figliuoli, e con l’altre lor cose, e difendevansi con quella possanza ch’egli avevano, da’ nimici che gli assediavano. E pure soperchiati della gran forza della gente dei Romani furon cacciati, e morti per le pendici delle montagne, e quelli che camparon s’arrenderono, e confessarono essere Manlio vincitore. Eran presi di questi gran quantità e maschi e femmine; alla guardia de’ quali posto uno centurione come egli vide la moglie d’Orgigante re, forte per l’età e maravigliosa per la bellezza, mosso a concupiscenza di quella, smenticandosi la romana onestà, contrastando quella quanto potè, adulterò quella. La qual cosa portò con tanto sdegno, che ella non desiderò più la libertà che la vendetta; ma ella cauta compresse lo desiderio tacendo; e come venne la moneta promessa per ricomperare i prigioni, la rinnovata ira nello petto casto di quella donna s’inasprì; la quale avendo pensato quello che ella dovesse fare, sciolta dalle catene, co’ suoi si trasse da parte, e disse al centurione, che pesasse l’oro. Alla quale opera il centurione teneva intenta la mano e gli occhi, ove ella in suo linguaggio non inteso da’ Romani, comandò a’ suoi servi, che eglino gli tagliassero la testa, dappoichè fusse morto; con la quale tornò in grembo a’ suoi. E arrivata alla presenza di suo marito e contata a quello la ingiuria ricevuta, essendo ella in prigione, gittò a’ piè di questo la testa che ella avea portata quasi per pagamento della ricevuta vergogna; e quasi come s’ella portasse la vendetta di una ingiuria. E chi dirà, questa non solamente Romana, ma della setta di Lucrezia piuttosto che barbara? ancora erano in sua presenza la prigione, e suonavanle intorno le catene dei vincitori; e sopra il capo apparecchiate le mannaje dell’aspro vendicatore; e non bastava a quella donna che le fusse renduta la sua libertà; perchè l’indegnazione del macchiato corpo avea sospinto l’onesto petto a sì gran forza, che l’animosa femmina, e vendicatrice dello scellerato fatto, non temè, se fusse bisognato esser menata presa con le catene, entrare in prigione, e sottomettere la testa alle mannaje, intanto che con costante comandamento ella indusse i servi a fare morire l’adultero scellerato. Dove troverai più aspro uomo, più animoso capitano, e più costante imperadore contro a quegli che hanno mal meritato? dove udirai tu più sagace e più ardita femmina, e più sollecita servitrice d’onestade di donna? Vedeva questa donna con maravigliosa sottilità di mente, che meglio è andare a certa morte che tornare a casa del marito con incerto onore, e non poteva pruovare se non con grande pericolo, che la mente fosse stata casta nello sforzato corpo. Dunque in questo modo si salva l’onore delle donne; e così si fa la testimonianza del casto onore: e perciò guardino quelle ch’hanno in animo cura di gloriosa onestà; e che non è assai a provare la purità dell’animo dire con lagrime e con lamentanza, essere state sforzate, se non procedono alla vendetta, quando possono, con nobile opera.
CAPITOLO LXXII.
Emilia, moglie del primo Scipione.
Terzia Emilia, benchè per la nominanza della famiglia degli Emilj, dei quali ella avea tratta famosa nazione, per lo matrimonio del valentissimo marito, primo Scipione Africano, fusse famosa, molto più ella fu splendida per le chiare opere. E avendo questo in sua prima gioventù innanzi restituito a Lucio principe la sposata moglie vergine in primo fiore di fanciullezza, maravigliosa di spettabile bellezza, con lo tesoro profferta da’ parenti per ricomperare quella vergine; diventato vecchio non potè temperare sè medesimo dalla dannata concupiscenza, anzi si piegò allo suo adulterio, e allo amore d’una sua serva: la qual cosa non potendo ingannare lo pensiero dell’onesto amore, non potè stare occulto a Terzia, anzi in processo di tempo seppe ogni cosa. Ma chi dubiterà che ella lo sopportò molestamente? Perchè molti affermano che niuna cosa si può fare alle donne maritate, oltre alla vergogna, più grave nè più ingiuriosa, che concedere dallo marito a un’altra femmina la ragione dello letto, lo quale dicono essere suo. E io certamente di lieve lo concederò, perchè o che avvegna per la debilità di sua natura, o che lo faccia la non buona opinione di sè, la donna è sospettosissimo animale; perchè incontanente pensa se il marito s’inchina ad un’altra che adoperi danno all’amore debito a lei. Ma quantunque paresse faticosa cosa, quella gloriosa donna lo comportò con costante animo, e tenne nascosto lo peccato di suo marito con tanto silenzio, che non che lo sapesse altro, ma lo marito medesimo non se ne accorse, che ella sapesse quello che faceva. E pensava l’onesta donna, che, procedendo troppo innanzi, fusse saputo quello, che colui, lo quale con gloriosa virtù avea soggiogato i re e le forte nazioni, soggiacesse all’amore di una serva. E non parve assai a quella santissima donna, che quello peccato stesse nascosto, vivendo Scipione, ma, essendo egli già morto, a torre via la memoria di quella infamia, se per alcun modo o alcuna parte potesse espiare quello peccato, tolse via la cagione. E acciocchè quella la quale avea dato diletto allo marito, non potesse essere rimproverata d’alcuno rimprovero di servitù, e non si mischiasse con alcuno per non dicevole lascivia, per la quale potesse invilire l’appetito del magnifico marito, primieramente diede libertà a quella con liberale animo, poi la maritò a un suo famiglio. O quanto si deve levare al cielo con sacre lodi quella donna! Da una parte con giusto e paziente animo patì le ingiurie, e dall’altra pagò lo debito del marito verso la serva sua compagna di letto: la qual cosa quanto noi vediamo avvenire più rade volte, tanto dobbiamo stimare quella virtuosa. Un’altra donna avrebbe gridato e fatto radunanza de’ parenti, delle vicine, e di tutte le conoscenti donne, e avrebbe ripieno quelle di molte parole, e avrebbe caricato di lamentanze senza numero, dicendo, sè abbandonata, sè dispregiata, e sè essere vedova vivendo quello, e esser posta drieto a una fanciulla serva e di vil sorte, e puttanella, e avrebbe cacciato subito, anzi avrebbe venduto a incanto la serva; e avrebbe pubblicamente stimolato per lo marito con lagrime e con lamentanze; e non avrebbe curato, purchè ella avesse ricoverate le sue ragioni col gridare, s’ella avesse macchiato la gloriosa fama del marito.
CAPITOLO LXXIII.
Dripetrua, figliuola di Mitridate.
Dripetrua abbiamo letto che fu reina di Laodicea, e figliuola del gran Mitridate, la quale benchè fusse da commendarla per la fè che siamo tenuti a’ nostri padri; più assai, mio parere, la fece degna di lode la natura madre per alcuna inaudita opera; perchè se noi dobbiamo dar fè agli libri degli antichi, ella, nata con due ordini di denti, fu ammirabile mostro a tutta Asia al suo tempo, la quale benchè non ricevesse alcuno impedimento di mangiare da sì inusitata quantità di denti, nondimeno non fu senza maravigliosa bruttezza, la quale, come già io ho contato, con laudabile fè ella fece tacita; perchè essendo vinto Mitridate suo padre dal gran Pompeo, non rifiutando alcune fatiche ne’ pericoli, sempre lo seguì mostrando con sì fedele servigio, che il suo difetto si dovea imputare alla natura e non al padre.
CAPITOLO LXXIV.
Sempronia de’ Gracchi.
Sempronia fu figliuola di Tito Sempronio Gracco, famosissimo uomo al suo tempo; la quale egli generò di Cornelia, stata innanzi figliuola del grande Scipione Africano, e poi fu moglie di Scipione Emiliano, famosissimo uomo, lo quale di poi acquistò lo soprannome di suo avolo per la distruzione di Cartagine; e fu sorella di Tiberio e di Cajo Gracco; e non dischiattò da’ suoi passati in grandezza e fermezza d’animo. E dicesi, che dopo la morte de’ suoi fratelli per le loro discordie, avvenne che ella fu menata in giudizio da uno tribuno del popolo in consiglio del popolo, e non senza grande spavento di mente. E in quel luogo confortandola la moltitudine, e tutto l’ufficio dei tribuni stimolando quella, che baciasse Equizio da Fermo della Marca, suo nipote, e figliuolo di Tiberio Gracco suo fratello, era costretta ad accettare quello come della famiglia de’ Sempronj. La quale per certo, benchè fusse in luogo dove solevano tremare i principi, e che ella fusse stimolata dall’una parte e dall’altra di scordevole rumore della ignorante moltitudine, e che con aspra faccia fusse minacciata dalla parte dell’autorità dei tribuni, la costanzia di quella donna non si piegò in alcuna cosa; anzi ricordandosi che Tiberio suo fratello, non avea avuto se non tre figliuoli, de’ quali l’uno era morto giovane, essendo nella milizia di Sardegna, l’altro era morto fanciullo poco innanzi che morisse suo padre, e il terzo fanciullo poco dopo la morte di suo padre era morto appresso la balia, il quale era similmente nato postumo, con costantissimo animo, ed aspro volto, non impaurita in alcuna parte, rifiutò vituperosamente Equizio, stranio, e presuntuoso, il quale con falsa pruova si sforzava di bruttare la nobile schiatta de’ Gracchi; e non potè essere piegata nè indotta per alcuna signoria o minacce a fare quello che poteva. Essendo rifiutato Equizio sì animosamente, e essendo fatta vana la malvagità di sì presuntuoso uomo; e essendo conosciuto da’ tribuni il fatto, fu lodata la perseveranza del nobile animo di quella donna. E forse saranno alcuni, i quali diranno, che benchè Sempronia fusse degna per li suoi passati, nondimeno per questa fortezza non fu da porre tra le famose donne, perchè le donne in ciascun proposito sono d’ostinata e pertinace opinione; ma io benchè non lo nieghi, nondimeno penso che elle siano da lodare, se elle s’accostano alla verità nella quale per certo Sempronia si fermava. Sono ancora alcuni, che vogliono, che ella fusse di sì indomabile testa, che, se ella avesse potuto, non sarebbe stata fatta alcuna cosa contro al suo giudicio, la quale ella avesse lasciato senza vendetta. E per questo fu pensato che ella consentisse alla morte di Scipione suo marito: perchè poi che egli guastò Numanzia, domandato se gli pareva, che giustamente fusse stato morto Tiberio Gracco, non avendo, rispetto al parentado, lodò l’aspra morte di quello discordevole uomo.
CAPITOLO LXXV.
Claudia Quinta romana.
Claudia Quinta fu una donna romana; ma non è assai manifesto di che parentado ella nascesse, ma per alcuno maraviglioso ardire ella acquistò perpetual fama. Questa usando continovi e varj ornamenti e molto dilicati, e andando con la faccia troppo coltivata, fu pensato dalle donne di maggior gravità non solamente poco onesta, ma disonesta. E essendo consoli Marco Cornelio, e Publio Sempronio, nello quintodecimo anno della guerra degli Africani, avvenne, che la Madre degli Dei fa portata da Pessinunte a Roma per lo fiume del Tevere: e a ricevere quella dalla nave, secondo la risposta dell’oracolo, essendo giudicato Nasica ottimo uomo da tutto il Senato, andato in quel luogo con tutte le donne fino alla prossima nave, avvenne che volendo arrivare i nocchieri appresso al lido, la nave, nella quale era portata la statua, essendo arrivata in secco, e non potendo essere mossa da molti nocchieri; Claudia, mescolata tra le altre donne, conoscendo la sua virtù, palesemente inginocchiata pregò quella Dea, che se ella conosceva, sè essere casta, ella seguisse la sua cintura. E subito levata suso con fidanza, sperando quello che ella avea pregato, comandò, che la nave fusse legata alla sua cintura, e che tutti i giovani fussero rimossi dalla nave: e come fu fatto, Claudia lievemente trasse la nave dalla secca; e, maravigliandosi ogni uomo, condusse quella dove ella voleva. Per la quale sì maravigliosa prosperità seguì incontanente, che l’opinione di ogni uomo della non conservata onestà si convertì in contrario con somma lode di Claudia; e così ella, che era andata allo lido macchiata di vituperosa nota di lascivia, tornò a casa ornata di maraviglioso onore d’onestà. E benchè la cosa venisse secondo lo desiderio di Claudia; non è chi stimi, essere di sano intelletto (quantunque ella fosse innocente) ardire fare sì fatte cose, perchè volere fare quello che è fuori di natura, acciocchè alcuno mostri, sè essere senza colpa, è piuttosto tentare Iddio, che purgare lo biasimo dell’imposto peccato. Ma noi dobbiamo vivere santamente: e se noi saremo biasimati, Iddio non lo porterà senza nostro bene; e certamente egli vuole, acciò confermi la nostra pazienza, sia tolta via la superbia, e sia adoprata la virtù; e acciocchè noi ci allegriamo, con noi medesimi sapendo gli altri essere indegni. Assai è a noi, anzi è grandissima cosa, se noi viviamo bene, essendo conosciuti da Dio; e perciò se gli uomini non credono buoni noi, non è da curare, purchè noi facciamo bene; e se eglino pensano male, è da curare con tutta nostra forza in contrario, acciocchè piuttosto lasciamo quegli con lo reo pensiero, che noi operiamo male.
CAPITOLO LXXVI.
Ipsicratea, Reina di Ponto.
Ipsicratea, benchè non sappia sua schiatta, nondimeno ella fu moglie del gran Mitridate, e gran reina di Ponto: fu di maravigliosa bellezza, e d’invincibile amore verso suo marito, e intanto da lodarla, che per quello merito perpetuo splendore al suo nome. E essendo Mitridate in lunga guerra, e grande spesa con gli Romani, benchè egli, secondo l’usanza barbara, avesse altra moglie e amica; accesa di grandissimo amore, o che egli andasse in battaglia, o che egli apparecchiasse armata, sempre ella era fidatissima e inseparata sua compagna. E questa certamente portando molestamente la sua assenzia, e pensando niuno poterlo meglio servire, e che la maggior parte de’ servi non fussero strani; acciocchè ella potesse fare al marito amato sommamente da lei le cose bisognose, benchè le paresse fatica, deliberò di seguirlo. E perchè a sì grande opera l’abito di donna non pareva convenevole, e indecente che una donna andasse accanto ad uno re sì fatto a battaglia; acciocchè ella paresse maschio, innanzi all’altre cose tagliossi i biondi capegli, de’ quali hanno infinita gloria le donne, per esser principale ornamento del loro delicato volto; nè solamente consentì coprir quelli con l’elmo, ma bruttare quegli di sudore, di polvere, di ruggine d’armi, e metter giuso i fregi d’oro, i giojelli e le vesti di porpora lunghe infino alli piedi, ovvero tagliarle corte infino a’ ginocchi e coprire con la corazza lo bianco petto, e calzarsi le gambiere, lasciare l’anella e ornamenti delle mani, in luogo di quegli portare lo scudo e la lancia, e cignersi l’arco e lo turcasso di Partia in luogo degli ornamenti del collo; e faceva ogni cosa sì attamente, che di dilicata reina pareva fatta uno antico cavaliere. Come se queste cose fussero state leggiere, ella usata alle reali camere, all’ozio e alle delicatezze, e a vedere l’armi rade volte, lasciate quelle cose, con virile animo avea imparato a cavalcare, e infaticabile, caricata d’arme, seguire lo marito, lo dì e la notte per aspri monti e per valli, vincendo il freddo e il caldo, spesse volte correre era trovata; e in luogo di reale letto alcuna volta, costringendola il sonno, giaceva nella dura terra senza paura, e avendo indurato il corpo alla fatica, giaceva per le tane delle fiere; e vincendo il marito, o che fuggisse, sempre era in sua compagnia, e aiutatrice delle fatiche, e in ogni luogo partecipava dei suoi consigli. Perchè più parole? ella imparò potere vedere senza paura colli pietosi occhi le ferite, l’uccidere degli uomini, il sangue, il quale spesse volte combattendo con le saette, ella spargeva; e ridusse le sue orecchie, usate a udire cantare, a udire senza spavento della mente lo sbranare e annitrire de’ cavalli, lo romore dei cavalieri, e lo suono delle trombe. Finalmente avendo portate molte fatiche, e gravi a un forte cavaliere, ella seguì Mitridate vinto da Gneo Pompeo per lo paese d’Armenia, e per gli occulti luoghi di Ponto, e per le aspre nazioni di ciascuna gente con pochi suoi amici; confortando quello afflitto alcuna volta con migliore speranza, alcuna volta lusingandolo con piaceri, dei quali ella sapeva egli essere cupido; acciocchè dovunque egli fusse menato, e in solitarj luoghi, paresse che si confortasse nella camera della moglie. Oh come quello era petto sacro di matrimoniale dolcezza, e come era quell’amicizia senza difetto! con che forza fu fortificato l’animo della donna! Niuna moglie mai per lo marito certamente portò simili, non che maggiori cose. Per lo quale merito, se gli antichi si convertirono a sua lode perpetuale, non se ne devono maravigliare quelli che sono venuti drieto. Finalmente di sì gran fatti, e di sì grande e gloriosa fè quella degna donna non ebbe dal marito degno premio; perchè, essendo egli già vecchio, e avendo morto, sopraffatto dall’ira, uno suo figliuolo generato di quella, soperchiando la potenza de’ Romani, ridottosi non solamente nel regno, ma nella casa reale, benchè egli tentasse gran cose con l’animo, e con ambascerie indurre alla guerra contro a’ Romani varie e lontane nazioni, fu assediato da Farnace suo figliuolo; lo quale si ribellò per la crudeltà del padre contro ai figliuoli e agli amici: la qual cosa vedendo e trovando quello costante, e pensando quella essere rovina dei suoi fatti, avvelenò Ipsicratea con tutte le sue mogli e amiche e con le figliuole, avendo quella alla sua vita dato tanti aiutorj affaticandosi, acciocchè ella non vivesse dopo lui. E per certo la ingrata opera di Mitridate non potè menomare la debita gloria di Ipsicratea: lo corpo che era mortale fu spaccialo per morto innanzi tempo col veleno; ma lo suo nome è pervenuto a noi, e viverà perpetualmente in gloriosa fama per la testimonianza dei venerabili scrittori; e non potè essere soperchiato per futura lunghezza di tempo.
CAPITOLO LXXVII.
Sempronia, Romana.
Ricordiamoci aver letto essere stata un’altra Sempronia di famoso ingegno, oltre a quella che è detta di sopra: ma per la maggior parte abbiamo letto, quella essere stata inchinevole a cose scellerate, e questa, per testimonianza degli antichi, tra le Romane famosa e per nazione e per bellezza: e fu assai avventurata di marito e di figliuoli, dei quali non ricordandomi de’ nomi, veniamo a questo che è quello di che ella può essere lodata; e quelle cose che la testimonianza e nominanza fa chiare, sieno poste nel primo luogo. Dunque questa fu di presto e di sì pronto ingegno, che subito ella intendeva e contraffaceva eziandio, seguendo, ogni cosa che ella vedeva ad alcuno dire o fare. Per questo avendo imparato non solamente lettere latine, ma eziandio greche, ardì, e non a modo di donna, comporre versi, e sì sottilmente, che ella faceva maravigliare quelli che li leggevano, non come cosa nobile e laudabile in donna semplice, ma eziandio ad uno letterato uomo maravigliosa. Fu ancora di tanta e sì ornata eloquenza, che, se voleva, poteva confortare a modestia, muovere giuochi, indurre a ridere, eccitare dilicanza e vaghezza; e, ch’è più, di sì piacevoli costumi favellando, che in qualunque maniera di parlare ella si convertiva, mandava agli orecchi degli audienti dolcezza ed ornamento. Ancora seppe ornatamente cantare e ballare, le quali virtù se alcuna le usa sanamente, sono molto da commendare in una donna. Poi piena di molte rie opere, parve molto diversa da questa; perchè stimolata da troppo ardore, alcuna volta arrivò a presunzione di uomo, e molto dannabile. E usando lo cantare e lo ballare, che sono strumenti di lussuria, per saziare quella, dispregiata al postutto l’onestà di donna, più spesso cercava gli uomini, che egli non era cercata da quegli. Di questo male (che noi vediamo sì forte in alcuni) stimi le radici come tu vuoi, mai dannerò la natura, della quale, comechè la forza sia grande, circa il principio delle cose puossi sì piegare, che con poca fatica potrai quasi menare come tu vorrai la cosa nata; e così dispregiando sempre, si volge a peggio. E per certo, io penso che nella puerizia delle fanciulle lo perdonare de’ padri spesse volte guasta gl’ingegni, le quali per abitrio piegandosi alla lascivia, a poco a poco dà luogo la trepidità delle donne, e cresce incontanente l’audacia moltiplicata da alcuna matta opinione; per la quale dicono essere decente quello che piace; e poichè sono andate una volta, affatichiamoci indarno che non sia bruttato l’onore delle fanciulle, e che non sia messa giuso la vergogna della fronte, e di ritrarre quelle caduche; poi non solamente le femmine si fanno incontro alla lussuria degli uomini, ma elleno gli stimolano ancora. Sempronia fu cupida di moneta sommamente; e come ell’era cupida d’acquistare vituperosamente, così era larghissima a compiacere a ogni scellerata cosa, intanto che non servava alcuno modo in avarizia o in prodigalità. Mortale male è in alcuna donna la cupidità della moneta, e manifestissimo testimonio di vietato peccato; e così è da vituperare la prodigalità, la quale quante volte l’entra nell’animo contrario a sè naturalmente, come quello d’una femmina, la quale per natura dee essere scarsa, non si può avere alcuna speranza di salute senza povertà. Dell’onestà e di sue ricchezze è fatto, perchè non cessano infino che non arrivano ad estrema vergogna e miseria. Fare masserizie attiene alle donne, e a quelle tocca servare drente la casa quello che acquistano dai mariti. Questa, quanto è da dannare la cupidità e immoderata larghezza, tanto è più da lodarla quanto ella è manifestamente nobile accrescitrice delle ricchezze, e salute delle cose di casa, testimonio di integra mente, consolazione delle fatiche, e colonna ferma d’intera successione. E certamente acciocchè noi conchiudiamo insieme, e, secondo che io penso, lo estremo suo fatto e tutti i suoi peccati; ardendo quello fuoco di quello perfido uomo Lucio Catilina, la malvagia femmina si mischiò a malvagi consigli nel numero de’ congiurati a desolazione perpetua della romana repubblica; levandosi continuamente a maggior possanza a pigliare licenzia più piena di sua lussuria, desiderando quello che sarebbe stato terribile a malvagi uomini, fecesi compagna ai congiurati, e la sua casa sempre era apparecchiata in segreto a crudeli parlamenti. Ma resistendo Iddio alle malvagitadi, e dalla sollecitudine di Tullio essendo scoperto lo trattato dei congiurati; essendo già partito Catilina e andato a Fiesole, penso che ella ingannata cadde nel pericolo degli altri. Per la qual cosa, benchè noi possiamo lodare lo suo ingegno e per quello magnificarla, è necessario dannare lo suo esercizio; perchè essendo macchiata la vesta della donna con più lascivie, adoperò Sempronia, arrivare a sua vergogna; dove, se ella avesse servata modestia, poteva diventare gloriosa.
CAPITOLO LXXVIII.
Delle Donne de’ Fiamminghi e dei Tedeschi
La moltitudine grande delle mogli de’ Cimbri, vinti da Cajo Mario in aspra battaglia, fu degna di lode per lo sacro e costante proposito d’onestà, anzi in ispezialità fu da magnificarle; perchè quanto più quelle furono, più alto pare da levarle con maggiori onori: e questo perchè molto spesso abbiamo letto, poche essere arrivate a osservanza di castità; ma non abbiamo letto, che molte vi sieno arrivate, e radissime volte l’abbiamo letto e udito. Donque essendo in fiore i fatti de’ Romani, i Tedeschi e i Fiamminghi, e altre nazioni barbare del Settentrione fecero congiurazione contro alla fama de’ Romani, e prima ragunati insieme, acciocchè niuno sperasse poterli mettere in fuga, condussero con loro le mogli e i figliuoli, e tutte sue masserizie in gran moltitudine di carrette: poi acciocchè egli percotessero in uno assalto tutta Italia, deliberarono d’entrare in quella con tre osti, e per tre cammini, per li quali impauriti i Romani per tumulto, fu mandato incontro a quegli Cajo Mario, nel quale in quel tempo tutto lo stato della repubblica romana si pareva fermare. Lo quale prima scontrò i Tedeschi, contro ai quali non rifiutando in alcuna cosa la battaglia, venne alle mani con quegli, e combattendo in lunga battaglia, stando per lungo spazio in dubbio la fortuna delle parti, finalmente dopo molta effusione del sangue i Tedeschi volsero le spalle. Poi andò contro ai Cimbri; e com’egli aveva isconfitti i Tedeschi appresso l’acque Sestie, così sconfisse quegli ne’ campi Claudj con gran mortalità d’uomini. Della qual cosa accorgendosi le mogli, posti da parte gli loro arnesi, non seguirono la fuga de’ mariti, ma condussero i carri, de’ quali elle avevano gran moltitudine, in forma d’uno steccato, con matto e animoso proposito di difendere, quant’elleno potessero, la loro libertà e castità con pali abbruciati, e con pietre e con le spade. Ma sopravvenendo con ischiere fatte la gente di Mario, non facendo lunga resistenzia, conobbero che indarno si sforzavano, e per quello domandarono se elle potessero avere concordia col capitano. E avevano fermato nell’animo, almeno, per qual via elle potessero, salvare la loro libertà e la loro onestà, se elle perdessero i mariti in battaglia, e se perdessero le sedi de’ loro passati, e tutte le loro ricchezze. E perciò domandarono non la pace per i loro mariti che fuggivano, e non tornare alla patria, nè che i loro danni fussero loro rifatti con moneta, ma d’essere tutte condotte a Roma, e poste monache con le vergini Vestali. La qual cosa, parendo onestissima testimonianza di pura mente, non ottenendo, accese con furore in ostinata perseveranza di loro desiderio, cercarono crudel fatto; e primieramente isbattuti in terra i piccoli figliuoli, e morti quelli per liberarli dalla servitù per che modo che elle potessero, la seguente notte s’impiccarono con capestri e briglie de’ cavagli dentro allo isteccato che elleno avevano fatto, acciocchè elle non fossero tratte a vergogna di loro castità, e a dispregio de’ nemici vincitori, e non lasciarono ai nemici altra preda, che i loro corpi appiccati. Altre donne sarebbero andate umili incontro ai vincitori, rotta la ragione umana, con capegli sciolti, con le mani legate, empiendo ogni cosa di prieghi e di pianto; e, che sarebbe stata più scellerata cosa, alcune avrebbero domandato con lusinghe e abbracciare, se avessero potuto conservare la loro roba, e tornare nella patria, non ricordandosi d’alcuna onestà di donna; o avrebbero lasciato straziarsi a modo di bestia; ma quelle Fiamminghe con fermo petto salvarono gli animi di migliore fortuna, e non comportarono bruttare la gloria di sua gente con alcuna vergogna di sua maestà: e fuggendo ostinatamente con lo laccio la servitù e la vergogna, mostrarono gli suoi uomini vinti non per forza, ma per difetto di fortuna; e alla loro castità acquistarono lunghissima vita, perdendo pochi anni, i quali elle avrebbero potuto sopravvivere se non si fossero appiccate; e lasciarono a quegli, che dovevano seguire, onde eglino si maravigliassero, che sì grande moltitudine di femmine, non per congiurazione nè per deliberazione pubblica, in ispazio d’una notte s’accordarono ad una opinione di morire, come se quelle avessero avuto un medesimo spirito.
CAPITOLO LXXIX
Giulia, figliuola di Cajo Giulio Cesare.
Giulia forse fu la più famosa donna di tutto il mondo, e per sua schiatta e per suo marito; ma più famosa per lo santissimo suo amore, e per la subita sua morte. Ella fu sola figliuola di Giulio Cesare, generata di Cornelia sua moglie, figliuola di Cinna, stato quattro volte console. Il quale Giulio ebbe origine per molti re e altri successori da Enea duca de’ Trojani per parte di padre, e per parte di sua madre da Anco Marzio, stato innanzi re de’ Romani; e fu onorato molto di glorie, di battaglie, di trionfi e di perpetua dittatura. Poi ella fu moglie del gran Pompeo, uomo famosissimo tra i Romani in quel tempo, il quale per lungo spazio affaticò non solamente la terra, ma il cielo, vincendo i re, e mettendogli giuso e facendogli di nuovo, soggiogando le nazioni, perseguendo i corsari, acquistando benevolenza del popolo di Roma, acquistando favore con gli re di tutto il mondo: lo quale quella famosa donna, benchè ella fusse giovinetta e egli già vecchio, sì ardentemente l’amava, che per quello ella acquistò la morte innanzi tempo. Perchè facendo sacrificio Pompeo, essendo ammazzata la bestia la quale egli teneva, e quella per lo colpo scotendosi in diverse parti, imbrattossi di molto sangue, e perciò spogliandosi le vestimenta, e mandando quelle a casa, avvenne, che quello che le portava trovò prima Giulia; la quale vedendo insanguinate le vesti del marito, prima che ella domandasse la cagione, sospettando che Pompeo fusse stato morto, come ella non volesse vivere dopo la morte di suo marito, subito in terra con sinistra paura cadde cogli occhi rivolti e con le mani strette, e incontanente finì con grandissimo danno non solamente del marito e de’ cittadini romani, ma a quel tempo eziandio di tutto il mondo.
CAPITOLO LXXX.
Porzia, figliuola di Catone Uticense.
Porzia fu figliuola di quel Marco Catone lo quale s’uccise a Utica, poichè egli condusse d’Egitto in Africa quegli che restavano dell’oste di Pompeo, per le ardenti parti di Libia. E non parve che quella donna fusse dissimiglievole in alcuna cosa dalla paterna fortezza e perseveranza. E questa, acciocchè noi lasciamo l’altre sue virtudi, o gli altri suoi fatti famosi, vivendo il padre, fu maritata, a Decio Bruto, lo quale ella amò sì perfettamente e sì costantemente, che tra gli altri suoi pensieri questo suo marito era lo maggiore e ’l più speziale; e al debito tempo non potè nascondere l’oneste fiamme dell’amore nel casto petto; le quali cose perchè arrivano a sua perpetua lode, proferisconsi a sua maggiore fama. Già era acquetato lo pestilenzioso romore delle civili guerre, essendo in ogni cosa soperchiati da Cesare quegli della parte di Pompeo; nondimeno contro a lui perpetuo Dittatore, assai desideroso di sua signoria, la parte migliore del senato fece congiurazione. Fra i quali fu lo detto Bruto, lo quale sapendo la fermezza di Porzia, avendole aperto il secreto dello scellerato fatto, avvenne, che in quella notte, alla quale seguì lo die che Cesare fu morto da’ congiurati, uscendo Bruto dalla camera, Porzia pigliò uno rasojo da barbiere, quasi com’essa si volesse tagliare l’unghie; e facendo vista, che a caso le fusse caduto, istudiosamente si ferì. E come le sue cameriere videro uscire fuori lo sangue, temendo che la cosa fusse più grave, levato lo romore, Bruto, che era partito, tornò nella camera, riprendendo Porzia che toglieva l’ufficio al barbiere. Partite le serve, Porzia disse: Quel che tu pensi mattamente fatto, non è, ma io l’ho fatto per tentare come io potrei comportare la morte se la tua impresa non succedesse come tu volessi. O amore d’invincibile forza! e oh! quell’uomo era beato di sì fatta moglie! Ma chè, seguo più innanzi? I congiurati eseguirono il peccato e, morto Cesare, gli ucciditori fuggirono, ma non senza pena: e procedendo ogni cosa contro a quello che era pensato, furono dannati dall’altro senato quegli micidiali, i quali fuggirono in diverse parti. Bruto e Cassio andati verso Oriente ricolsero molta gente verso Ottaviano e Antonio eredi di Cesare; contro ai quali conducendo l’oste Ottaviano e Antonio, combatterono ai campi di Filippi: e essendo vinta e cacciata la parte di Bruto e di Cassio, Bruto ancora fu morto. La cui morte, come Porzia udì, pensando non avere alcuna cosa allegra per innanzi dopo la morte di suo marito, istimò comportare la morte con quel proposito che innanzi avea comportata la ferita del coltello del barbiere, e subito tornò all’antico proposito: e non avendo alcuno strumento alla volontaria morte, sì tosto, come richiedeva lo furore, gittossi in bocca gli carboni accesi senza alcuno dubbio, i quali ella avea presenti, e ardendo quegli la parte di drento, la vita fu costretta a partirsi. E non è dubbio che quanto quella fu più inusitata maniera di morte, tanto più diede dimostranza a quella che morì, che ella amasse lo marito; eziandio in niuna cosa si potè mettere dinanzi alla sua fortezza quella di suo padre, lo quale s’aperse la via già con le sue mani.
CAPITOLO LXXXI.
Curia, moglie di Quinto Lucrezio.
Curia fu una donna romana; e se noi daremo fede al nome, fu della schiatta de’ Corioni; e se noi daremo fede alle opere, fu splendido esempio delle antiche donne di maravigliosa costanza e d’integrissima fè, perchè nelle turbazioni delle cose, quando per comandamento de’ triumviri foron poste nuove tavole de’ proscritti, Quinto Lucrezio fu trovato proscritto insieme con molti, e fuggendo gli altri prestamente dalla patria, e appena trovando luogo sicuro nascosto fra le tane delle fiere e per solitarj luoghi delle montagne, ovvero appresso i nemici della nominanza de’ Romani; solo, seguendo lo consiglio dell’amatissima moglie, stette nascosto a Roma senza paura nella propria casa pazientemente in istretto luogo della camera appresso la moglie; e fu conservato con tanta sollecitudine della moglie, e con tanta industria e sagacità e con tanta integrità di fè, che niuno de’ parenti e famigli lo potè pensare non che sapere, salvo che una fanciulla. E possiamo credere, che a compiere lo fatto con arte, molte volte quella donna appariva tra le genti con umili vestimenti, brutto abito, trista faccia, con gli occhi lagrimosi, co’ capegli disordinati, non ornata, secondo l’usanza, d’alcuni veli, con lo petto pieno di faticosi sospiri, e con uno finto smarrimento di smemorata trascorreva per tutta la città, entrava ne’ templi, andava per le piazze con la voce tremante e debole; perchè paresse ch’ella andasse agl’Iddii, con prieghi e con voti domandava quegli che ella trovava per la via; domandava gli amici s’eglino avessero veduto il suo Lucrezio, e se eglino sapessero quello essere vivo; domandava verso qual parte egli fusse fuggito, con che compagnia e con che speranza; ancora, diceva, che sommamente desiderava sè essere sua compagna; fuggendo nella esilio e ne’ suoi disagi, e faceva molte cose somiglievoli, le quali erano fortificazioni a tenere nascosto il marito: ancora con molte lusinghe, piacevolezze e conforti ella conservava l’animo di quella serva, e faceala ferma; e finalmente dirigeva con conforti e speranze lo affaticato petto del marito, lo quale stava con paura, e traeva quello tristo ad alcuna letizia. E così stando gli altri in quel tempo con fatica per l’aspre montagne, per le tempeste del mare, per le fortune del cielo, tra le insidie dei barbari, e gli odj de’ nemici; e alcuna volta pericolando miseramente per le mani di quegli che li perseguivano, solo Lucrezio fu conservato sicuro in grembo della preziosa moglie, per la quale santissima opera Curia cercò eterna fama non indegna a sè.
CAPITOLO LXXXII.
Ortensia, figliuola di Ortensio.
Ortensia, figliuola d’Ortensio famoso oratore, è degna d’essere magnificata con degne lodi, perchè non solamente ella comprese nel vivace petto la eloquenzia di Ortensio suo padre, ma eziandio servò quello vigore di pronunciare che la bisogna richiedeva, e che spessissime volte suole mancare agli espertissimi uomini: questa, nel tempo de’ triumviri, parendo gravare molte donne di pagare quasi intollerabile gravezza di moneta per la necessità della repubblica, e non trovandosi uomini che volessero fare difesa di sì fatta cosa, sola ardì con costante animo pigliare la difesa delle donne dinanzi a’ triumviri, e trattare quella con sua orazione sì efficacemente, che con grandissima ammirazione degli auditori pareva che ella fusse trasmutato in maschio, o Ortensio fusse tornato vivo. E così nobile impresa non fu fatta nè compiuta da quella donna sciaguratamente; perchè come ella non avea mancato in alcuna parte rompendo la sua orazione e laudabile dimostrazione di sua ragione; così non fu mancata alcuna cosa di quello che ella desiderava dai triumviri: anzi le fu conceduto che fusse tolto via la maggior parte della moneta imposta; e pensarono, che quanto sotto l’abito di donna parrà da lodare il silenzio, tanto sia da lodare l’ornato parlare, quando la bisogna lo esige. Per lo quale fatto fu riscosso dalle donne leggiermente l’avanzo, che era minima cosa, non senza grandissimo onore d’Ortensia. Che dire io avere veduto, se non che lo spirito della antica schiatta abbi tanto spirato in Ortensia donna, che ella acquistò l’onore di Ortensio?
CAPITOLO LXXXIII.
Sulpicia, moglie di Lentulo.
Sulpicia, moglie di Lentulo Truscellione, con giusta quasi benevolenzia trovò a sè perpetua fama: perchè Lentulo fu proscritto dai triumviri in quella medesima avversità che è detta di sopra; il quale essendo campato, per questa fuga in Sicilia, stando in quel luogo in esilio, povero; essendone Sulpicia fatta certa, subito deliberò volere patire insieme col marito, pensando che non fusse cosa dicevole le mogli ricevere cogli mariti gli lieti onori, e stare tra quegli alla prospera fortuna; e rifiutare l’avversità di quegli e non fuggire con quegli, s’egli è di bisogno. Ma Sulpicia non potè ottenere leggiermente andare al marito: con gran diligenza era guardata dalla madre Giulia, acciocchè non andasse dietro a Lentulo. Ma lo vero amore inganna ogni guardia. Dunque ella prese il tempo, e, vestita a modo di una serva, ingannò la madre e l’altre guardie; e da due serve accompagnata quella nobile donna uscì dalla patria lasciando la sua casa, e seguì lo abbandonato marito, e bandeggiato; potendo ella, secondo le leggi, abbandonare quel marito e rifiutarlo, e fare nuovo matrimonio. E non s’impaurì quella gloriosa donna seguire la via incerta di suo marito per nascosta via e fuga, per la fortuna del mare e per le montagne d’Italia, e cercare quello per non conosciuti paesi, infinochè trovato quello s’aggiunse con lui, pensando essere più onesta cosa seguire suo marito per costo della fortuna, che, stando egli in esilio con fatica, ella stesse a casa fra le delizie, e piacevole riposo. E per certo siffatta opinione è piuttosto di savio uomo che di femmina, perchè non si dee sempre stare in isplendore d’oro e di gemme, e non sempre stare adornato; non si deve sempre fuggire il sole di state, e d’inverno la piova; non si dee sempre abitare nelle camere; non si dee sempre risparmiare; ma devono cogli mariti, quando la fortuna il dà, entrare alle fatiche, e andare in esilio, comportare la povertà, portare i pericoli con forte animo. E questa è la laudabile milizia delle donne, queste le sue battaglie e vittorie, e gloriosi trionfi, avere soperchiati con l’onestà e con la fermezza e castamente la morbidezza, i diletti e i riposi di casa; da questo acquistano perpetua fama e gloria. Dunque vergogninsi non solamente quelle che seguono l’ombra della felicità con tutti i piedi; ma più quelle che per comune acconcio del matrimonio temono la noja del mare, salvansi per lieve fatica, temono le esterne nazioni, e diventano pallide per uno mugghiare di bue; lodando fuggire cogli adulteri, piacerle andare con quegli per lo mare, e, essendo scelleratissime, d’avere l’animo forte ad ogni bisogno.
CAPITOLO LXXXIV.
Cornificia poetessa.
Non mi ricordo avere trovato se Cornificia fu Romana, o s’ella fu una donna d’altro paese, ma, per testimonianza degli antichi fu degnissima da farne memoria. E signoreggiando Ottaviano imperadore, fu sì armata di poetica scienza, che non parea nutricata in Italia, ma in Grecia, e fu in uguale gloria famosa con Cornificio famoso poeta, il quale fu suo fratello. E, non contenta solamente di sì famosa scienza, secondo che io penso, stimolandola le sacre Muse, spessissime volte pose le ammaestrate mani alla penna a scrivere versi Eliconj, lasciata la rocca: e scrisse versi molto notabili, i quali erano in pregio al tempo di San Gironimo. E questa fu onore delle donne, perchè dispregiò l’arte delle femmine, e pose lo ’ngegno agli studj dei grandissimi poeti. Vergogninsi quelle che sono di vile animo, e che si diffidono di sè medesime, le quali, come nate in ozio e per istare nelle camere, fanno credere a sè medesime, non essere utili a’ diletti degli uomini, a nutrire nè ad allevare i figliuoli, avendo di comune con quegli tutti quegli esercizj che fanno gli uomini gloriosi, se vogliono esercitarsi negli studi. Questa potè, non abbandonate le forze della natura, con sollecitudine e studio avanzare lo sesso delle femmine, e acquistarsi con onesta fatica perpetua nominanza.
CAPITOLO LXXXV.
Marianna, Reina de’ Giudei.
Marianna fu ebrea per nazione, nata per Aristobolo, re di Giudea, e d’Alessandra, reina figliuola di Irtario re; e fu di tanta e sì inusitata bellezza per nominanza, che non solamente era creduto che avanzasse in suo tempo in bellezza l’altre donne, ma piuttosto essere immagine divina che mortale: a questa credenza fu aggiunto la testimonianza di Marco Antonio triumviro. Aveva Marianna uno fratello nato d’un medesimo padre e di una medesima madre, chiamato per nome Aristobolo, e quello d’una medesima età e uguale bellezza con quella; al quale Alessandra madre dopo la morte d’Aristobolo suo padre, desiderò e procurò che fusse dato lo principato del sacerdozio da Erode re, marito di Marianna; e dicesi, che per conforto di Gallio suo amico, fu mandato dipinta la figura di quegli in Egitto in una tavola per mano d’un ottimo dipintore ad Antonio triumviro, il quale era uomo sommamente lussurioso, per attizzare contro a sè la cupidità di quello, e per quella trarlo a suo desiderio. Le quali immagini come Antonio vide, prima si maravigliò molto, poi, si dice, che disse, che quegli quanto alle bellezze erano figli di Dio certamente, e con sacramento affermò, che non avea veduto in alcuno luogo, nè mai simiglievoli a quegli, non che più begli. Ma ritorno solamente a Marianna: questa benchè fusse per certo di non udita bellezza, ella fu eccellente di grande animo e di gran fortezza. E come ella arrivò ad età di marito, fu data per moglie a Erode Antipa tre, re de’ Giudei, e con sua grandissima sciagura fu sommamente amata da lui per la sua bellezza. E gloriandosi quello, sè solo essere in tutto il mondo, posseditore di sì divina bellezza, pigliò sì gran pensiero, che niuno altro potesse essere uguale a lui: e in questo cominciò a temere che Marianna vivesse dietro a lui. E per ischifare quello, essendo mandato per lui in Egitto, dove egli dovè andare ad Antonio per difendersi dall’accusa della morte d’Aristobolo, fratello di Marianna, il quale egli avea morto; e poi dopo la morte d’Antonio dovendo andare ad Ottaviano imperadore a scusarsi dello aiutorio che egli avea dato ad Antonio contro a lui; impose a Ciprinna sua madre e agli amici, che se fusse fatto alcuna cosa da Antonio e poi da Ottaviano, per la quale seguisse la sua morte, o fusse costretto in alcun’ altra cosa, incontanente uccidessero Marianna. Questa fu una matteria da ridersene, lui, in altre cose sagacissimo re, per altrui incerto piacere o utile dolersi, e dopo la sua morte avere invidia. La qual cosa fatta segretamente, Marianna per ispazio di tempo seppe: e avendo già per la indegna morte d’Aristobolo preso maledetto odio contro a Erode, vedendo sè non essere amata, se non per usare sua bellezza, multiplicò l’ira, portando molestamente che egli avesse dannato la sua vita due volte ingiustamente. E benchè ella avesse generato di lui Alessandro e Aristobolo, due bellissimi figliuoli, non potè temperare lo suo pensiero in alcuna cosa: e per questo pensiero essendo stimolata, dispose negare sua lussuria allo amante marito; e dispregiandolo, quasi come in lei fosse risuscitata tutta la virtù dell’antica schiatta reale, con alcuni superbi atti s’ingegnava calcare tutta la sua potenzia, non temendo palesamente dire spesse volte: Erode essere di altra nazione, e non Giudeo, e che egli non era di schiatta reale, anzi uomo di Idumea e senza nobiltà; e che egli non era da avere per moglie una reina, come crudele, superbo, disleale e scellerata bestia. Le quali cose benchè Erode portasse con difficoltà, nondimeno perchè l’amore lo vietava, non ardiva fare contro a lei alcuna crudeltà. Ma finalmente procedendo le cose a peggio, secondo che dicono alcuni, avvenne, che Marianna fu accusata a Erode da uno suo donzello contaminato da Ciprinna madre di Erode e da Salamonia sua sorella, alle quali Marianna era sommamente grave: era l’accusa, che Marianna s’era sforzata di contaminare quello famiglio, che desse a Erode una bevanda amara, la quale ella avea apparecchiata. E secondo che dicono alcuni, avvenne, che di proprio movimento, e non per opera della madre al tempo che abbiamo detto avea mandato la sua bellissima immagine ad Antonio, per trarlo alla cupidità di sè e odio contro a lui, poichè ella avea preso odio contro a Erode. Le quali cose poichè Erode credette, e quello gli faceva credere la malevolenzia di Marianna, irato e acceso di faticoso furore, lamentassi cogli amici in una lunga orazione, e per questo confortandolo quegli, ed Alessandra madre di Marianna per acquistare la sua grazia, fu indotto, ch’egli facesse comandamento ch’ella fusse morta e dannata a pena capitale, come quella che cercava la morte contro alla reale maestà. La quale per certo incitò in sè tanto lo generoso animo, che dispregiando la morte, riserbata in sè intiera la bellezza non piegata in alcuna cosa a modo di femmina, udiva tacendo la madre che riprendeva; e con la faccia asciutta guardava gli altri che piangevano; senza alcuna paura come ad allegrissimo trionfo, con lieto volto e non facendo alcuno priego di sua salute, andava alla morte, e quella riceveva dal manigoldo come cosa desiderata. Per la quale sì ferma crudeltà non solamente s’attirò l’odio del crudele re, ma ella accrebbe alla sua nominanza più secoli, che non avrebbe potuto concedere Erode mesi alla sua vita s’egli fusse stato piegato per lagrime e prieghi.
CAPITOLO LXXXVI.
Cleopatra, Reina d’Egitto.
Cleopatra fu una donna d’Egitto, e fu in favola per tutto il mondo, benchè per molti re che furono in mezzo ella avesse origine da Tolomeo, re di Macedonia, figliuolo di Lago, e fu figliuola di Dionisio, ovvero, secondo che piace ad alcuno, fu figliuola di Minos re; nondimeno venne a signoria di quel regno per vizj, e quasi non fu famosa per alcuna ragione, se non per sua bellezza; ma per contrario fu conosciuta per tutto il mondo per avarizia, crudeltà e lussuria; e, secondo che dicono alcuni, acciocchè noi facciamo cominciamento dal principio di sua signoria, Dionisio o Minos, com’egli avesse nome, sommamente amico del popolo di Roma, venendo a morte sotto lo primo consolato di Giulio Cesare, per segreto testamento lasciò, che il maggiore de’ figliuoli, il quale alcuni pensan che avesse nome Lifania, togliesse per moglie Cleopatra, la quale eziandio era la maggiore figliuola; e questi morto, regnassero insieme: la qual cosa seguì; perchè presso gli Egizj era in uso sommamente per disonestà torre per moglie le madri e le figliuole. E certo desiderando Cleopatra avere solo lo reggimento del regno, secondo che alcuni hanno detto, ella avvelenò quello giovane d’età di quindici anni, suo fratello e marito, e rimase sola al reggimento del regno. Poi dicono, che avendo già Pompeo lo Grande occupata tutta l’Asia, andato in Egitto, sostituì un altro fratello in luogo di quello fratello che era morto, e fecelo re d’Egitto: per la qual cosa indegnata Cleopatra, pigliò animo contra a lui. E così stando le cose, essendo sconfitto Pompeo da Cesare in Tessaglia, e poi essendo morto quello fanciullo che egli avea fatto re, in suso il lido d’Egitto; arrivato Cesare a quel luogo, trovò che quegli facevano guerra tra loro; i quali furono chiamati a dire le sue ragioni innanzi a lui. E, tacendo di Tolomeo, Cleopatra, maliziosa per natura, fidandosi molto di sè, presentossi ornata realmente; e pensando d’ottenere lo regno, se ella traesse Cesare domatore del mondo a sua lascivia; e essendo ella bellissima; e pigliando quegli che ella voleva con l’arte degli occhi, e con l’ornamento delle parole; con poca fatica trasse a sè a suo sollazzo lo lussurioso principe; e in mezzo allo mormorare degli Alessandrini stette con lui in sollazzo, e di lui ingenerò, secondo che si accorda quasi ogni uomo, uno figliuolo, il quale dappoi per lo nome del padre ella chiamò Cesarione. E finalmente Tolomeo fanciullo, lasciato Cesare, e stimolato da’ suoi volse l’armi contro lo suo liberatore, e andò a Delta contro a Mitridate Pergameno, il quale andava in aiutorio di Cesare, il quale era pervenuto per altra via; e in quel luogo fu vinto da Cesare, e fuggì in una barca, la quale per lo peso di molti che sopravvennero entrando in quella si affondò. E così quietate le cose, e gli Alessandrini essendo arrenduti; dovendo Cesare andare contro a Farnace, re di Ponto, il quale era stato favorevole a Pompeo; quasi come egli dovesse dare pagamento a Cleopatra del suo diletto, e perchè era stata leale; non desiderando ella altro, concedette lo regno d’Egitto, rimossa Arsinoe sua sorella; acciocchè forse per guida di quella non fusse tentata alcuna novità contro a lui. E così già avendo acquistato lo regno di doppio peccato Cleopatra, s’allargò a’ suoi diletti; e fatta quasi una puttana de’ re d’Oriente, cupida di tesoro e di giojelli, non solamente lasciò nudi di sì fatte cose i suoi adulteratori con sue arti, ma eziandio fu detto, che ella lasciò voti i sacri templi degli Egizj de’ vasi, delle statue, e degli altri tesori. Poi dopo la morte di Cesare, essendo già vinti Bruto e Cassio, e Antonio andando in Soria, ella gli si fece incontro, e lievemente pigliò quello miserabilmente in suo amore, e condusselo a tanto, che dove ella avea fatto morire il fratello con veleni per tor via tutta la sospezione della signoria, fece, che per mano d’Antonio fusse morta Arsinoe sua sorella nel tempio di Diana da Efeso, dove, cercando sua salute, quella infelice era fuggita; ricevendo quello per pagamento de’ suoi adulterj da uno nuovo amico in luogo del primo dono. E conoscendo già la scellerata donna li costumi d’Antonio, non temè domandare a quello lo regno di Soria e di Arabia. E certo parendo a lui quella grandissima e non convenevole cosa, nondimeno, per soddisfare al desiderio dell’amata donna, diedele alcuna particella di ciascuno di quelli, e aggiunsele eziandio tutte le terre e cittadi che sono poste presso al lido di Soria dentro Eleutreo, fiume d’Egitto, ritenendo a sè Sidone e Tiro. Le quali cose, poichè ella ebbe ottenute, seguì Antonio che andava contro agli Armeni, e, secondo alcuni, andando contro a’ Parti fino all’Eufrate: e ritornando in Egitto per Soria, fu ricevuta magnificamente da Erode Antipatre, re de’ Giudei in quel tempo; al quale ella non si vergognò per messi a profferirsi in adulterio per torgli lo regno de’ Giudei in luogo di pagamento se egli avesse consentito: lo quale regno non molto innanzi egli avea acquistato per opera d’Antonio. Anzi per liberarlo dalla infamia di sì scellerata femmina, aveva deliberato di ucciderla, se non che gli amici ne lo sconfortarono. Ma Cleopatra non avendo sua intenzione, quasi come s’ella fusse indugiata per quello, affittò la rendita di Gericonte, dove nasceva lo balsimo, lo quale poi ella tramutò a Babilonia in Egitto, dove egli è fino a questo tempo; e di quel luogo avendo ricevuto da Erode grandi doni, tornò in Egitto. Poi tornando Antonio fuggito di Parzia, ella gli andò incontro. Lo quale Antonio per certo avendo preso a tradimento Artabazane, re d’Armenia, il quale era stato figliuolo di Tigrane, cogli figliuoli e principi del regno; e avendolo rubato di grandissimi doni e tesori, menandolo preso con una catena d’argento, acciocchè provocasse quella cupida a suo diletto, egli effemminato le presentò, venendogli ella incontro, il re preso con tutti gli ornamenti reali. Del quale dono ella fatta lieta come cupidissima donna, accarezzollo sì lusinghevolmente, che egli rifiutò Ottavia sorella di Ottaviano Cesare, e fecesi moglie lei con somma affezione. E lasciate le Arabiche untazioni, e le odorifiche profumazioni di Saba, e le vivande; egli uomo ghiotto si faceva continuamente di ghiotte vivande; e per magnificare Cleopatra sua compagna, venne in parole, che cosa magnifica si potesse presentare nelle continue cene: al quale rispose quella lasciva femmina, che se egli volesse, ella gli darebbe in una cena una vivanda di spesa di cento sesterzi. La qual cosa pensando Antonio non potersi fare, e nondimeno desiderando di vedere, e di divorare, misesi alla pruova; e fu tolto per giudice Lucio Plauto. E non passando lo dì seguente l’usanza delle vivande; e già Antonio facendosi beffe delle promesse; Cleopatra comandò ai famigli che le portassero incontanente la seconda mensa: quegli non portavano altra cosa se non una tazza d’uno fortissimo aceto, e ella presa subito una pietra che ella portava da uno degli orecchi per ornamento, secondo l’usanza delle donne di Oriente, la quale era di sommo pregio, e disfecela nell’aceto: e quella disfatta bene, poi prese l’altra che ella portava all’altra orecchia di simile pregio per fare in simigliante guisa; ma subito Lucio Plauto pronunziò che Antonio avea perduto, e così rimase la seconda pietra, avendo vinta la reina. La quale pietra portata a Roma, fu posta all’orecchia di Venere, per fare per lungo tempo testimonianza della mezza cena di Cleopatra a quegli che la guardassero. Poi crescendo ogni dì la ’nsaziabile cupidità in quella donna, acciocchè tutto si comprendesse insieme, essendo forse ebbro Antonio, levandosi da sì nobile cena, ella domandò lo imperio de’ Romani, quasi come se fusse stato in mano di Antonio poterlo dare: lo quale egli promise darle, non essendo egli in buono senno, non pesando egli la sua forza opportunamente, nè la potenzia de’ Romani. Oh Iddio! come fu grande l’audacia di quella che domandò! e non fu minore la matteria di quello che prometteva! Oh, come quello uomo era cortese donando inconsultamente! quasi come subito egli lo volesse fare, non altrimenti che se fusse stato la signoria d’una casella, a una femmina che domandava lo imperio appena ancora acquistato in tanti secoli con difficoltà, spargendo il sangue, e con la morte di tanti notabili uomini ed eziandio di tanti popoli, e con tante notabili opere e con tante battaglie! E perchè più parole? già era sparto il seme della guerra fra Ottaviano ed Antonio; e per questo avvenne che radunati gli sforzi dall’una parte e dall’altra, seguì la guerra. E Antonio e Cleopatra si fecero innanzi con l’armata di vele vermiglie d’oro, infino in Epiro; dove cominciata la battaglia cogli nemici in terra, e essendo rotti; cessaronsi indrieto a Azio, dove eglino dovevano provare la fortuna della battaglia navale: contro i quali andò Ottaviano con Agrippa suo genero, e con grande armata e maraviglioso ardire assalì quelli; e cominciata la battaglia, stette sospesa per lungo spazio. Ma finalmente parendo perdere la parte d’Antonio, Cleopatra superba cominciò a fuggire con l’ornata nave nella quale era, e con sessanta navi con lei, la quale incontanente Antonio, messe giuso le insegne della nave, seguì e tornati in Egitto indarno disposero sua potenzia a difesa del regno, avendo primieramente mandati tutti i suoi figliuoli al Mare Rosso. Ma Ottaviano vincitore, seguendo quelli in più prospere battaglie, abbattè la sua potenzia: e domandando quegli tardi condizioni di pace, e non potendo ottenerle, disperandosi Antonio, secondo che alcuni dicono, egli entrò nella cappella dove erano le sepolture dei re, e quivi con un coltello s’uccise. E presa Alessandria, Cleopatra avendo tentato con ingegno trarre a suo amore Ottaviano giovane, come ella avea tratto innanzi Cesare e Antonio; come udì sè essere servata al trionfo, disperandosi di salute, ornata a modo reale, seguì lo suo Antonio; e postasi appresso quello, fecesi aprire le veni delle braccia; e per morire posesi alle aperiture delle vene due aspidi; e dicono alcuni che quegli fanno morire dormendo; e addormentata quella infelice, mise fine all’avarizia e alla lussuria e alla vita, sforzandosi Ottaviano di servarla viva, levato il veleno dalle ferite. E sono alcuni i quali dicono, che morì innanzi, e per altra maniera di morte: perchè dicono, che Antonio temè le carezze di Cleopatra nello apparecchiare della battaglia d’Azio; e per quello pigliò per usanza di non ricevere bevanda nè cibo, se innanzi non fusse fatta credenza: della qual cosa accorgendosi Cleopatra, per purgare lo sospetto, ella avvelenò i fiori, de’ quali lo dì d’avanti ella aveva ornata la sua corona; e messosi quella in capo trasse Antonio a sollazzo; e seguendo il sollazzo, invitò quegli ch’egli beesse, e mise i fiori nella coppa: egli volendo bere, Cleopatra non lo lasciò, dicendo ella: O Antonio, mio dilettissimo, io sono Cleopatra, la quale con nuove credenze tu ti fai sospetta: e s’io potessi questo comportare che …
mancano 4 pagine
… tu bevessi, io ho tempo e cagione. E finalmente, vedendo egli l’inganno, come lei glie lo mostrò, Antonio la fece mettere in prigione, e per forza le fece bevere quella bevanda, la quale ella aveva vietata a lui. E così dicono che ella morì. Ma la prima è più famosa opinione: alla quale aggiungi che Ottaviano fece compiere un monumento, il quale Antonio aveva fatto incominciare insieme con Cleopatra, e che egli fece sepellire insieme ambedue in quello.
CAPITOLO LXXXVII.
Antonia minore, figliuola di Marco Antonio
Antonia minore, chiarissimo esempio di viduità, lasciò nominanza da non potersi consumare appresso a quelli che devono venire. E, secondo che si crede, questa fu figliuola di Marco Antonio triumviro, generata da Ottavia; e fu chiamata minore perchè aveva una sorella maggiore di tempo chiamata per quel medesimo nome. E questa fu moglie di Druso, fratello di Tiberio Nerone, e figliastro di Ottaviano Augusto. E di quella egli generò Germanico e Claudio, il quale fu di poi imperatore, e Livia. Il quale Druso, essendo con l’oste in Germania, secondo che alcuni pensano, per fattura di Tiberio suo fratello, morì di veleno. E dopo la morte di quello, essendo Antonia sua moglie in età assai giovine e d’assai ammirabile bellezza, pensando ella che ad onesta donna basta essere maritata una volta, da niuno potè essere indotta al secondo matrimonio. Anzi passò il seguente spazio di vita sotto Livia sua suocera, sì santamente e casta nella casa e nella camera di suo marito, che ella avvanzò tutte le passate donne vedove per famosa veduitate. E per certo santissima e splendida cosa è alle donne in provetta età, seguitatrici di Cato, condurre sua vita senza infamia di lascivia, e degne di molta lode tra i Cincinnati, i Fabrizii e i Curioni e tra le Lucrezie e le Sulpicie. E se così è, con che lodi magnificheremo questa giovane? La quale essendo bella e figliuola di Marco Antonio uomo disonestissimo, non nutricata nelle selve, né in luoghi solitarii, ma tra i diletti e i riposi imperiali, con Giulia avola, e Giulia figliuola d’Ottaviano, e moglie di Marco Agrippa, le quali furono fuochi ardentissimi di lussuria e di disonestà, tra le disonestadi di Marco Antonio suo padre, e di Tiberio, il quale dopo fu imperatore nella nobile patria stata innanzi onesta, ma al suo tempo data ad ogni bruttura; tra mille esempii di concupiscenza, con forte animo, servò, dico, la sua castità e non per piccolo tempo, nè sotto speranza di doversi maritare per innanzi, ma per seguire insino alla vecchiezza, e insino alla morte? E, certo, non è assai detto in parole; ma forse avanza alcuna cosa alla considerazione, la quale per certo, perchè avanza il sapere di quelli che scrivono, basti averlo lasciato a considerare, e con degna considerazione magnificare ai sacri ingegni.
CAPITOLO LXXXVIII.
Agrippina di Germanico.
Agrippina fu figliuola di Marco Agrippa, e di Giulia figliuola di Marco imperatore, benché Caio Caligola figliuolo della stessa Agrippina, essendo già imperatore del mondo, avendo a schifo la bassezza dell’avo materno, dicesse che sua madre non era stata generata da Agrippa, ma dall’adulterio commesso da Ottaviano con Giulia sua figliuola; desiderando stoltamente esser creduto più nobile, se sua madre fosse stata generata da sì adulterata madre, che se ella fosse stata generata da vile padre, secondo giusta legge. Ma di chi ella si fosse figliuola, fu maritata a Germanico, bello, di sua età, il quale molto fu di bisogno alla repubblica, e, per adozione fu figliuolo di Tiberio Cesare. Assai per questo lei fu famosa; ma più famosa fu perchè ella, con ostinato proposito, fece resistenza alla perfidia del superbissimo imperatore. E avendo questa già partorito tre figliuoli maschi di Germanico suo marito, de’ quali l’uno fu Caio Caligola, il quale da poi fu imperatore di Roma, e altrettante figliuole femmine, delle quali Agrippina madre di Nerone imperatore, essendo morto Germanico di veleno, per fattura di Tiberio suo padre, secondo che fu provato, ella portò molestamente e con molto pianto, secondo l’usanza delle donne, la morte del valentissimo giovane suo marito. E piangendo quello, ella cadde in odio di Tiberio, intanto che, tenendo egli quella per il braccio, e con rampogne stimolandola insino al pianto, e …
[fine pagine mancanti]
Continua capitolo LXXXVIII
… dicendo, che ella era troppo impaziente, non potendo signoreggiare, dappoi, stimolata quella pon più accuse appresso il senato, comandò che ella fusse messa in prigione. Ma la nobile donna pensando cosa indegna quello che l’era fatto dallo ’mperadore, deliberò fuggire, e finire con la morte i fastidj dello stomacoso principe: la quale non potendo aver ella assai comodamente, per altro modo deliberò avere quella per fame con magnifico animo: e così incontanente si cominciò astenere da ogni cibo. La qual cosa essendo riportata a Tiberio, come lo malvagio uomo s’accorse quale doveva essere lo fine dell’astinenza di quella donna, acciocchè ella non fuggisse le sue ingiurie per sì certa via nè per sì brieve spazio, non giovando alcuna cosa, le minaccie e le busse, a fare ch’ella pigliasse lo cibo a tanto si condusse, perchè non li fusse tolta l’occasione di usar crudetà contro di lei, che fece con violenza e per forza cacciarle il cibo giù per la gola, come che le fusse messo nello stomaco, acciocchè desse nutrimento a quella che non voleva vivere. Ma Agrippina quanto più era sforzata dalle ingiurie con tanto più aspro proposito perseverando a quello che ella avea cominciato, e morendo, vinse la superbia dello scellerato principe; dando ad intendere a quello, come egli volesse, potea farne morti molti, ma non poteva salvare niuno che volesse morire, con tutta la forza della sua signoria. Per la quale morte certamente, benchè ella acquistasse molto di gloria appresso de’ suoi, lasciò nondimeno molto più di vergogna a Tiberio.
CAPITOLO LXXXIX.
Paulina romana.
Paulina, romana donna, acquistò nominanza inestinguibile per alcuna sua semplicità. Questa, signoreggiando Tiberio imperadore dei Romani, come era tenuta innanzi alle altre di bellezza di corpo, così poi che fu maritata era riputata da ogni uomo, di gloriosa onestà: e oltre al marito non curava alcuna cosa con singolare studio, se non potere servire, e acquistare la grazia di Anubi, Dio degli Egizj, il quale con sommo amore ella amava. E essendo le belle donne amate dai giovani in ogni luogo, e in ispezialtà quelle che hanno sollecita cura di castità; un giovane romano preso dalla bellezza di quella, chiamato per nome Mondo, strettamente avea cominciato a sollecitare quella cogli occhi, con atti e con piacevolezze, quando con promesse e doni, e quando con prieghi e con lusinghe, se per ventura potesse ottenere quello che egli ardentemente desiderava; ma ogni cosa era indarno, perchè la castissima donna congiunta solo al marito rifiutava ogni cosa dell’amante. Il quale, seguendo sua impresa, accorgendosi per manifesti segni che gli era tolta la via per la costanza di quella donna, convertì lo ingegno all’inganno. Era usata Paulina di visitare ogni dì il tempio d’Isis, e con continui sagrificj onorava Anubi: la qual cosa come il giovane seppe, mostrandogli quello l’amore, pensò uno inganno non udito altra volta; e avendo pensato che i sacerdoti d’Anubi potessero giovare molto a suo desiderio, andò a quegli con grandissimi doni, e gli trasse a sua intenzione. E avvenne ai prieghi di quello, che lo più venerabile sacerdote per la vecchiezza disse con piacevoli parole a Paulina, sopravvenendo al modo usato: Che Anubi era venuto a lui la notte, e aveagli imposto che egli dicesse a quella, che egli molto s’era dilettato della divozione di lei; e che egli desiderava parlare con lei nel tempio, dormendo ella. La qual cosa come Paulina ebbe udita, pensando ella quello fusse avvenuto per la santità di lei, smisuratamente si gloriò in sè medesima di quelle parole, e credette quelle esser vere, come se l’avesse colle proprie orecchie udite da Dio Anubi: e tutte queste parole riportò a suo marito; il quale, più sciocco che la moglie, consentì alle di lei domande, che ella stesse nel tempio, nel quale Paulina dormì tutta la notte. Ma facendosi giorno, disse, ch’ella avea generato uno figliuolo: e fatto già riportare il letto fuori del tempio per gli sacerdoti, Paulina riportò al marito quello ch’era fatto: quel semplice uomo credette, e allegrassi con la moglie ch’ella dovesse partorire uno Dio. E non era dubbio ch’avrebbero aspettato il tempo del partorire, senonchè il giovane troppo ardente incautamente manifestò lo ’nganno. E fattosi incontro a Paulina che andava al tempio le disse con bassa voce: Paulina, tu sarai beata quando di me avrai generato Anubi Dio: di quella parola seguì, che maravigliandosi Paulina, e tornata a memoria più cose di quelle ch’aveva udite e ch’era fatto, subito s’accorse dello ’nganno, e turbata tornò indrieto al marito, e a lui disse l’ingiuria di Mondo e de’ sacerdoti, com’ella s’accorgeva. Della qual cosa seguì che il marito si lamentò a Tiberio; il quale trovato l’inganno, punì i sacerdoti con supplicio, e Mondo mandò in esilio: e Paulina sì schernita fu convertita in favola del popolo di Roma; e fu più famosa per la sua semplicità e per l’inganno di Mondo, che per la devozione di Anubi, e per la castità servatasi lecitamente.
CAPITOLO LXXXX.
Agrippina, madre di Nerone.
Agrippina, madre di Nerone imperadore, fu non meno famosa per sua schiatta, parentado, signoria, e per la mostruosità di suo figliuolo e sua, che per suoi fatti. Questa fu figliuola di Germanico Cesare, ottimo giovine, e di laudabile vita; da Agrippina detta fu generata, e fu chiamata Giulia Agripprina, sorella di Caio Caligola imperadore; e fu moglie di Gneo Dominio, uomo fastidiosissimo e grave, di famiglia de’ Iuli; Enobarba, del quale ella partorì cogli piedi innanzi Nerone, bestia a tutto il mondo famosa. Ma morto Domizio d’infermità di lebbrosia, essendo ancora Nerone uno fanciullo, essendo Agrippina bellissima, Caio suo fratello, uomo disonestissimo, trasse quella a brutto adulterio. E fatto quello imperatore, o perchè ella avea fatto fallo con Lepido per isperanza di signoria, o perch’egli fusse stimolato d’alcuno nimico di quegli, privò lei di tutti i suoi beni, e confinolla in un’isola. Ma essendo egli poi morto da’ suoi cavalieri, e Claudio essendo sostituito imperadore; egli la fece tornare. La quale per ispazio di tempo avendo fatto uccidere Valeria Messalina per varie cagioni, incontanente ella mise la speranza alla signoria del mondo: con la sua bellezza trasse a grande desiderio di suo matrimonio, per favore di Pallante, Claudio, casto principe, bench’egli fusse stato fratello di Germanico, padre di quella, contro Lollia Paulina, favoreggiando quella Callisto liberto, e contro Elia Petina, favoreggiandola Narciso. Ma pareva che l’onestà contrariasse il suo desiderio: perch’ella era sua nipote per lo fratello; ma per l’orazione di Vitellio, il quale era contaminato, avvenne, ch’egli fu stretto a quello ch’egli desiderava da’ prieghi del senato, pregando egli che il senato facesse uno dicreto che gli barbani potessino torre per moglie le nipoti; e così Agrippina, volendo Claudio, e pregando lo senato, fece matrimonio con lui; la quale finalmente fu chiamata Augusta, e andava in Campidoglio in carretta, la qual cosa era anzi solo concesso a’ sacerdoti; e cominciò a essere crudele contro quegli i quali erano stati suoi contrarj. Finalmente, come quella ch’era astutissima, preso tempo, avendo Claudio figliuoli maschi e femmine; indusse quello, confortandolo Memmio Pollione, il quale allora era console, e stimolando molto Pallante liberto, il quale perchè commetteva adulterio con Agrippina era sommamente suo fautore, indusselo ch’egli adottasse per suo figliuolo Nerone figliastro, la qual cosa niuno si ricordava essere stata fatta nella famiglia de’ Claudj; e ch’egli gli desse per moglie Ottavia, la quale egli avea generata di Messalina, la quale era sposata per lui con Lucio Sillano, nobilissimo giovane: le quali cose come ebbe ottenute, pensando che la fiera era caduta nella tavola, non solamente stimolata da tedio della contraria avarizia di Claudio, ma smarrita che Britannico suo figliuolo non arrivasse a ferma etade, pregando Narciso molte cose per Britannico, quasi pensando a suo proposito quello contrario, per innanzi trovò scellerata invenzione per fare morire Claudio. E avea per certo Claudio diletto de’ boleti; dicendo, quello era cibo degli Dei, e questi per sè nascevano senza semente: la qual cosa considerando Agrippina, studiosamente gli cosse e avvelenogli, e quella, secondo alcuni, gli mise innanzi a Claudio, essendo egli tocco di vino. Alcuni dicono, che mangiando egli nel tempio cogli sacerdoti, Agrippina glieli mandò per Paraloto, suo eunuco corrotto da lei, il quale gli facea la credenza. Ma parendo secura la salute di Claudio per vomito e per flusso di corpo, per fattura di Xenofonte medico furongli date penne avvelenate per aiutare lo vomito; e seguì quello che desiderava la moglie; e egli finalmente portato nella camera morì senza saputa d’alcuno, salvochè di Agrippina. La cui morte per certo non fu fatta palese per Agrippina infino che per aiutorio degli amici, lasciato Britannico come più giovine, Nerone già adulto, fu levato imperadore. La quale cosa, fu tanto grata a Nerone, che subito egli propose la madre, come quella che l’avea ben meritato, ad ogni uomo nelle cose pubbliche e nelle private; e pareva egli aver preso il titolo e la madre presa la signoria: e così Agrippina fu splendida a tutto il mondo nell’altezza di Roma. Poi questo splendore sì grande fu bruttato da sozza macchia, perchè ella diventò crudele, facendo ella morire molti, e molti mandandone in esilio: e ancora fu creduto che ella, fusse amata, consentendo ella, dal suo figliuolo, oltre al debito amore verso la madre, disonestamente; e dicono alcuni che ella trasse il figliuolo al peccato per ricoverare suo stato dal quale ella era caduta; perchè dappoi Nerone pareva fuggire sua brigata, e non si lasciava parlare in segreto. Nondimeno perchè ella avea tratto a suo matrimonio suo barbano, e avealo morto cogli boleti, e avea levato all’imperio lo disconcio giovane, con inganno e con forza fu condotta a detestabile morte, benchè ella l’avea meritato. E perchè ella era grave in molte cose al figliuolo, ella fu odiata da lui, di che egli la privò d’ogni onore di maestà d’imperadrice; e sdegnandosi ella, essendo stimolata da furore di femmina, minacciò di fargli perdere l’imperio come glielo avea procurato. Per le quali minacce impaurito, conoscendola molto avveduta, e per memoria di suo padre avere aiutorio degli amici, sforzossi per tre volte ucciderla con veleno, ma quella prevenuta con bevande, faceva resistenza. Finalmente avendo ella schifato i lacci che egli avea tesi contro a lei, Nerone s’accorse che gli conveniva procedere con più celato inganno, e cercando egli, fugli insegnato da Aniceto, prefetto dall’armata presso Miseno, il quale già in puerizia era stato suo balio, che si poteva fare una nave debile, nella quale entrando Agrippina, non accorgendosi dell’inganno, poteva pericolare. Lo quale piaciuto a Nerone, ricevè quella, venuta da Anzio, in braccio, quasi pentuto dell’odio passato, mostrandole affezione di figliuolo, e abbracciandola la condusse in casa. Poi essendo apparecchiata la nave per la sua morte, dovendo andare in quella, essendo accompagnato da Creperio Gallo, e Acerronia liberti, e navigando eglino di notte, fatto segno a quegli che sapevano lo fatto, cadde lo timone della nave, pesante per lo molto piombo, e uccise Creperio: poi sforzandosi li nocchieri, che, essendo lo mare in bonaccia, la nave si riversasse, chiamando Acerronia aiutorio, fu morta cogli remi e cogli spontoni; e Agrippina ferita nell’omero, e, finalmente gittata in mare, fu aiutata da quegli che erano per gli lidi e finalmente condotta per lo lago Lucrino alla sua villa. Poi di suo comandamento fu rapportato a Nerone, che ella era campata, per Egerino liberto di quella; il quale fu preso, quasi come fusse andato per ucciderlo a tradimento; e mandò Aniceto e Erculeo famigli, Tetrarco e un centurione dell’armata, i quali l’uccidessero. E essendo circondata la casa, essendo fuggita una serva dalla quale sola Agrippina era accompagnata, entrati i servi, a quella Eraclio diede d’uno bastone in su la testa; poi com’ella vide lo centurione apparecchiato a ucciderla di ferro, disteso innanzi il corpo, gridò ch’eglino la ferissero nel ventre, e così fu morta. In quella medesima notte fu arsa e sotterrata vilmente in una sepoltura nella Via presso Miseno, e presso alla villa di Iulio Cesare. Altri dissero che ella fusse veduta da Nerone poich’ella fu morta; e ch’egli biasimò alcune sue membra, e alcune lodò, poi la fè seppellire.
CAPITOLO LXXXXI.
Epitare serva.
Epitare serva, fu creduto piuttosto forestiera donna che romana; e non solamente ella non fu famosa perchè non fusse stata di nobile schiatta, ma ancora peggio, che, figliuola d’uno servo, fu libertina femmina; e, che molto più brutta cosa è, non essendosi dilettata di molte buone arti, circa la fine di sua vita mostrò avere nobile animo e virile fortezza. Crescendo certamente oppresso i Romani e tutti gl’Italiani la superbia e la lascivia di Nerone imperadore romano, avvenne che Lucio Pisone principe, e alcuni senatori e altri cittadini fecero congiura contro lui, e tentando mandare ogni cosa a termini con varj parlamenti, venne a notizia di Epitare predetta. Ma indugiandosi troppo la cosa a suo parere, quasi gravata di rincrescimento andò in campagna; e a caso stando a Pozzuoli, acciocchè non passasse il tempo vacuo, andò a Volusio Proculo, prefetto dell’armata dei Romani, il quale avea morto Agrippina, pensando dare grande aiutorio alla congiurazione, se ella lo potesse trarre a quella parte. E mostrato a quello con lungo ordine la perfidia, i fastidj, le disconcità de’ costumi, la superbia, e poi la ingratitudine di quello contro a lui, che per sì gran fatto (cioè la morte d’Agrippina) in niuna cosa lo avesse promosso, come l’avesse ben servito; manifestogli il tradimento, e con tutta sua forza adoperò aggiungerlo compagno dei congiurati. Ma seguì molto diversamente da questo che pensava Epitare; perchè Volusio volendo piegare a sè la grazia delllmperadore, riportogli tutte le parole di Epitare, benchè egli non dicesse quello che ella pensava, perchè quell’astuta femmina, dubitando ancora di lui, non gli avea manifestato alcuni de’ nomi de’ congiurati: e mandato per quella, non si potè fare che confessasse alcuna cosa di che ella fu domandata. E finalmente essendo tenuta presa, manifestata la congiurazione da’ congiurati medesimi a caso; da capo tornata alla disamina, quasi come ella fosse più impaziente che gli uomini agli tormenti, e da lei si potesse sapere quello che desideravano; dopo lunghi tormenti fatti a lei, non confessò alcuni segreti alli tormentatori. Finalmente servata al dì seguente, non potendo ella andare a’ suoi piedi, temendo, se ella fusse tormentata, la terza volta, non poter sostenere; disciolsesi una fascia dal petto e legolla a una carretta nella quale era portata, e fatto un laccio, messoselo al collo, e lasciatasi cadere, trovò a sè la morte, acciocchè ella non nuocesse ai congiurati; fallendo l’antico proverbio, che le donne non dicono quello che elle non sanno; e cosi lasciò Nerone ignorante e in paura. La qual cosa benchè paia grandissima in femmina, molto più maravigliosa parrà, se sarà considerata la incostanzia dei nobili uomini di quella medesima congiurazione, i quali si sapevano da altri che da Epitare: non fu tra quegli nessuno di sì robusta gioventù, che comportasse udire i nomi dei tormenti per la propria salute, che quella femmina comportò per la salute altrui: anzi incontanente confessarono quello che sapevano della congiurazione; nè niuno perdonò nè a sè nè agli amici, avendo quella gloriosa femmina perdonato a tutti se non a sè. Io crederei che la natura delle cose errasse alcuna volta, quando ella congiugne l’anima ai corpi degli uomini, cioè avere infonduta quella in un petto d’una femmina che credeva aver posto in un uomo. Ma perchè Iddio è datore di siffatte cose, è inconveniente credere che egli fusse negligente circa alla sua opera. Adunque è da pensare, che noi ricevemo ogni cosa, ma lo effetto dimostra se noi serviamo quella. Pensiamo, quegli uomini si debbono vergognare quando eglino sono vinti da lascivia di femmina, ma eziandio da ciascuna costantissima sofferenza di fatica; perchè se noi siamo eccellenti per esser maschi, perchè non lice che noi siamo eccellenti in fortezza? la qual cosa se non è, a ragione pariamo effeminati per li costumi.
CAPITOLO LXXXXII.
Pompea Paulina.
Pompea Paulina fu famosa moglie di Lucio Anneo Seneca, maestro di Nerone; ma non mi ricordo aver letto se ella fu donna romana, o se ella fu d’altro paese, ma nondimeno quando io guardo alla nobiltà de’ suoi spiriti, voglio piuttosto credere che ella fusse romana che forestiera. Della quale benchè noi non sappiamo l’origine, per la testimonianza dei famosi uomini, non ci manca lo esempio del pietosissimo amore verso lo marito. Ma gli degni e onestissimi uomini di quella età hanno creduto, che piuttosto per crudeltà di Nerone, che per difetto di quel severo vecchio e famosissimo sopra gli altri uomini, fusse notato nel tradimento della congiurazione Pisoniana; sotto la quale ombra fu trovata la via da Nerone di fare crudeltà contro a Seneca perchè antico odio, anzi per lo debilitato animo per la virtù. Benchè alcuni abbiano pensato che per lo stimolare di Poppea e di Tigellino, solo consigliatore della crudeltà dello Imperadore, avvenisse che per lo centurione fusse comandato a Seneca, che egli s’eleggesse la morte; alla quale vedendo Paulina apparecchiare quello, lasciate le lusinghevoli consolazioni che ella volesse vivere per le quali ella era confortata; stimolata di castissimo amore, dispose con forte animo volere morire col marito insieme, e per quella medesima maniera di morte, acciocchè una medesima morte dissolvesse quei due, i quali onesta vita avea tenuti congiunti. E essendo quella entrata senza paura nell’acqua calda, acciocchè col marito in una medesima ora morisse, e avendo fatte aprire le vene, di comandamento dell’Imperadore, lo quale non aveva contro a quella alcuno particolare odio, ritraendo egli alquanto, per opprimere l’infamia della sua natura, quella fu campata dalla morte per gli servi, ma non si potè sì tosto stagnare lo sangue, che quella ottima donna non mostrasse per perpetua pallidezza, avere molto scemato dallo vitale spirito insieme col marito. E finalmente poichè per alcuni anni ella conservò la memoria di suo marito con laudabile vedovità, non potendo altrimenti finire sua vita con Seneca, almeno la condusse con suo marito. Che potè persuadere a quella ottima donna volere piuttosto morire, che, come fanno le femmine per la maggior parte, serbare la vita per maritarsi la seconda volta? questo fu la dolcezza dell’amore, un maraviglioso segno di pietà nello venerabile sagramento del matrimonio. E per grandissima vergogna delle donne, in questo tempo è sì in usanza in alcune che non dico che elle si maritino la seconda e la terza volta, la qual cosa fanno quasi tutte, ma se è il caso da maritarsi, la sesta, la settima e l’ottava volta: ed è sì per usanza di fare nozze de’ nuovi mariti, che parono aver tolta l’usanza delle puttane, le quali hanno per usanza mutare nuova brigata di notte in notte; e non vanno a marito con altra faccia che se elle servassero santissimamente l’onestà. E non è assai certo che sì fatte, si dee dire, sieno uscite di una cella di disonesto luogo o da una camera dello innanzi morto marito? e non penso dubitare se quella va a marito più disonestamente, o quello la mena più mattamente. Oh miseri noi! a che sono condotti i nostri costumi! Gli antichi i quali ebbero l’animo a santità per usanza, pensarono cosa vituperosa maritarsi la seconda volta, non che più volte, e che siffatte non si possono con ragione mescolare con le oneste donne. Ma le donne di questo mondo fanno molto diversamente; perchè, tacendo lo suo libidinoso pizzicore, pensano se più belle e più care; perchè, avendo soperchiata la fortuna della vedovità cogli spessi matrimonj, tante volte siano piaciute a varj mariti.
CAPITOLO LXXXXIII.
Sabina Poppea.
Sabina Poppea fu nobile romana figliuola di Sabino Poppeo, uomo di non estrema nobiltà; benchè ella non prese nome da lui, ma dall’avolo, per parte della madre, Poppeo Sabino, uomo famoso, e ornato di trionfo, e di maraviglioso consolato. E non mancarono a quella l’altre virtù di donna, s’ella avesse avuto onesto animo. Perchè ella fu di singolare bellezza, e fu simiglievole alla madre, la quale in suo tempo avanzò in bellezza l’altre donne romane. Ancora, ella avea un singolare e soave parlare, e sonante con laudabile dolcezza, avea ingegno nobile e sottile, s’ella l’aresse usato a oneste cose, ed ebbe per usanza mostrare in palese continuamente modestia, ed in segreto lascivia (vizio comune delle femmine), e usando rade volte in luogo palese, non era senza arte. Perch’ell’era scalterita femmina, s’accorse potere dilettare a molti, e in ispezialità ai maggiori. Sempr’ella usciva fuori coperta in gran parte, e non per nascondere quello che desideravano e che piaceva ad altri, ma per non saziare troppo gli occhi di quelli che la guardavano, con mostrarsi liberalmente, ma piuttosto perchè quello che nascondeva eglino desiderassero. Acciocchè io non cerchi ogni cosa de’ suoi costumi, non perdonando mai alla fama, non piegava mai lo suo appetito se non dove l’utilità le pareva apparecchiata, non facendo differenza tra mariti e concubinarj. E conosciuta per questi segni ebbe assai favorevole la fortuna: fu maritata a Ruffo Crispo, cavaliere romano; e avendo già avuto da quella un figliuolo, per lusinghe di Ottone, potente per lussuria e per la gioventù nella brigata di Nerone, accostossi per adulterio a quel medesimo Ottone, e per lungo spazio diventò sua moglie. E per certo questo, o perchè fusse meno cauto nell’ardore dell’amore, o perchè non potesse comportare i costumi di quella lasciva donna, e per quello si sforzasse trarla al piacere di Nerone, o che fusse perchè la fortuna di Poppea il richiedesse; levandosi dal convito dello Imperadore era udito dire per usanza, sè andare a quella alla quale dal Cielo era conceduto ogni nobiltà e eccellenza di costumi, e divina bellezza; nella quale stavano tutti gli desiderj pegli uomini, e le bellezze e i diletti di felicità. Per le quali cose lievemente stimolato l’appetito di Nerone, fu trovata con non lungo indugio per alcuni mezzani la via che ella arrivasse al piacere dello Imperadore, volendo e desiderando: e non indugiò molto che, per lusinghe di quello, Nerone fu sì preso, che pensava essere verissime quelle cose che Ottone avea usato dire. La qual cosa conoscendo quella sagacissima donna, dissimulando quello che ella desiderava, preso il tempo, diceva con lagrime alcuna volta, che non potea porre lo suo amore dove ella desiderava, perchè ella era obbligata a Ottone per cagione del matrimonio e che lo Imperadore era stretto dell’amore di Atis, serva. Delle quali cose seguì che Ottone sotto spezie di onore fu mandato prefetto in Lusitania provincia, e Atis al postutto fu rifiutata. Quindi Poppea si cominciò a volgere contro a Agrippina, madre dello imperadore, dicendo alcuna volta, che non egli fusse imperadore, che egli non era in sua libertà; ma era pupillo ed era retto per l’arbitrio di tutrice. Pe le quali parole, non contrastando alcuno quasi per l’odio d’ogni uomo per la superbia d’Agrippina, avvenne, che di comandamento di Nerone la misera madre fusse fatta morire violentemente, e a poco a poco fussero sotterrati molti e molti per aiutorio di Tigellino, prefetto di milizia. Finalmente vedendo lo imperadore allo ardentissimo suo amore essere inclinato, tolto via ogni contrasto, cominciò a tendere le reti al matrimonio di Nerone. E avendo già partorito di lui una figliuola, essendo consoli Memnio Regolo, e Virginio Ruffo, la quale fanciulla Nerone aveva ricevuto con somma allegrezza, e avevale posto nome Poppea; già aveva cominciato fare istanza con audaci parole, dicendo, sè non essere stata mai con alcuno due notti, che subito non fusse seguito lo matrimonio; e dicendo, sè non essere stata di tale schiatta, perchè l’era bella, atta a fare figliuoli, e meritava essere moglie dello imperadore. E avendo già tratto lo ’mperadore a desiderio di suo matrimonio; primieramente Ottavia, sua moglie, e prima figliuola di Claudio Cesare, fu confinata in Pandeteria isola; e finalmente nel ventesimo anno di sua età per istimolo di Poppea, per comandamento di Nerone fu morta, e Poppea congiunta in moglie a Cesare. Ma non godè per lungo spazio di sua grandezza, cercata e acquistata per lunghe arti: perchè ingravidata da capo e a caso essendo adirato Nerone, percosse quella con un calcio, di che ella morì. Il cui corpo Nerone non volle che fusse arso secondo l’usanza de’ Romani, ma volle ch’ella fusse seppellita a modo dei re forestieri con sepoltura di gran pompa, facendola portare pubblicamente e con molte cose odorifere volle ch’ella fusse posta nella sepoltura de’ Giulj. E in consiglio la lodò, e spezialmente di mirabile bellezza con lunga ed ornata orazione, attribuendo a lei alcuni doni di fortuna e di natura, di cui ella fu ornata, in luogo di famosissime virtù. Io aveva che dire, tra queste fortune di Poppea, contro alla troppa morbidezza e lusinghe e lascivie e le lagrime, le quali sono certissimo e mortalissimo veleno delle femmine all’animo di quelli che credono; ma io ho pensato di lasciare queste cose, acciocchè io non paia fare piuttosto una satira che una storia.
CAPITOLO LXXXXIV.
Triaria.
Triaria donna non fu conosciuta per alcuno altro splendore di sua schiatta, se non perch’ella fu moglie di Lucio Vitellio, imperadore di Roma, per lo cui fervente amore verso al marito, e perch’ella avesse da natura congiunta all’animo la crudeltà, ebbe tanta ferocità, che contro all’usanza delle donne, pare che ella sia degna di farsene memoria. Dunque essendo in discordia dell’imperio Vitellio imperadore e Vespasiano, avvenne (essendo entrati in Terracina, terra de’ Volschi, alcuni gladiatori sotto Iuliano, capitano di Vitellio, ed eziandio molti nocchieri dell’armata de’ Romani, la quale dimorava non molto di lungi dal Monte Circeo sotto Pollinario prefetto, tenendosi da questo, consentendo Vespasiano; per negligenzia e molta pigrizia, e per invenzione d’uno servo) che di notte entrò in quella terra Lucio. Il quale pigliando l’armi contro a’ nimici addormentati usava crudeltà contro a’ cittadini che si difendono col ferro. E Triaria, seguendo la notte suo marito, e entrata nella città, desiderosa della vittoria di suo marito, armata e mescolata coi cavalieri di Vitellio, correva contro a quegli miseri or là or qua per le tenebre tra romori discordevoli, e lo discorrente sangue, per l’armi e per li estremi singhiozzi di quegli che morivano, non lasciando alcuna cosa della crudeltà de’ cavalieri. E fu detto ch’ella adoprò crudelmente e superbamente contro ai nimici. Sono nello moderato petto grandi le forze del matrimoniale amore; quelle non hanno alcuna paura, purchè n’esca la gloria del marito; non hanno alcuna pietà; non hanno alcuna memoria ch’elle sieno femmine; non hanno alcuna vergogna, alcuno pensiero di stimare il tempo. Triaria poteva sottomettersi in ogni cosa con lieve fatica per amore del suo marito, delle quali non solamente sogliono impaurire le donne (le quali hanno per usanza per la maggior parte, eziandio di un piccolo mormorare d’un sorcio, fuggire in grembo a’ mariti), ma eziandio sogliono alcuna volta impaurire i robusti e valenti giovani. E se questa donna corse all’arme di notte con tanto impeto, chi crederà solamente quella essere famosa per quello fatto, non solendo le virtù sole entrare ne’ petti degli uomini, o buone o ree ch’elle sieno? fieramente estimo, comechè sieno smenticate, che molto più Triaria fusse famosa per altri meriti.
CAPITOLO LXXXXV.
Proba, moglie d’Adelfo.
Proba per lo nome e per lo fatto fu una donna degnissima d’essere fatta memoria di lei per la scienza delle lettere. E essendo incognita sua nobiltà e sua nazione, piace ad alcuni (io il credo per congettura) che ella fu Romana, alcuni altri famosi uomini dicono che ella fu nata nella terra d’Otri, e moglie d’uno chiamato Adelfo, e per religione Cristiana. Questa, sotto qual maestro fusse, puossi manifestamente vedere che ella fu eccellente nelle arti liberali; e in tra gli altri studj ella fu ammaestrata dai versi di Virgilio con sì sollecita cura, che, facendone testimonianza ogni opera composta da quella, ella pareva avere sempre presente e in memoria. Le quali cose forse leggendo alcuna volta con più sottile considerazione, arrivò in pensiero che di quelli poteva descrivere la Storia del Vecchio e del Nuovo Testamento piacevolmente e splendidamente con versi pieni di sentenzia. E per certo non è senza maraviglia, che nel celebro d’una femmina entrasse sì alta considerazione; ma molto più maravigliosa cosa fu, che la cosa avesse effetto. Dunque soprastando al pietoso pensiero, discorrendo in qua e in là per li versi della Buccolica, della Georgica, e dell’Eneide, pigliando quando da una e quando da un’altra parte de’ versi, e talvolta togliendogli intieri, con maraviglioso artificio gli ridusse a suo proposito, allocandogli sì ottimamente interi, e compiendo i rotti, servando la legge de’ piedi e la degnità de’ versi; che uno che fusse molto esperto si potrebbe accorgere dove fusse la giunta. E con questo facendo principio dal cominciamento del mondo compose tutto quello che si legge nel Vecchio e Nuovo Testamento infino all’infusione dello Spirito Santo sì pulitamente, che di quella composizione quello che non lo sapesse crederebbe veramente che Virgilio fusse stato profeta o evangelista. Dalle quali cose non è compresa meno commendabile cosa a questa donna, che ella sapesse la Santa Scrittura pienamente; la qual cosa quanto avvenga rado, ed eziandio agli uomini di nostro tempo, dolendomene, lo sapemo. Ancora la nobile donna volle che la sua opera si chiamasse Centona, e quanto più degno pensiamo quello di perpetua memoria, tanto meno noi crediamo che famoso ingegno di questa donna fusse contento di questa opera sola; anzi penso, se ella visse molti anni, che ella compose altre opere molto laudabili, le quali per difetto di scrittori per nostro danno non sono arrivate fino alla nostra età. Tra le quali, come piace ad alcuni, fu una Centona d’Omero con quell’istessa arte, e di quella medesima materia che avea tolto da Virgilio fatta di versi tolti da Omero. Onde, se cosi è, si presume con maggior sua lode, Proba aver avuto cognizione così di lettere greche, come di latine. Ma io domando, che cosa più laudabile è stata, che una donna abbia scanditi i versi di Virgilio o d’Omero, e che abbia tolto quelli che erano atti alla sua opera, e che gli eletti abbia appiccati con maraviglioso cognoscimento? E consideriamo i valentissimi uomini, i quali, benchè maravigliosamente sieno prestantissimi nella professione della Sacra Scrittura, nondimeno molto è grave e faticoso trarre fuori le parti di qua e di là dalla grandissima larghezza di quella, e ragunarle alla vita di Cristo con parole sparte in prosa, come questa fece de’ versi di uomini infedeli. E se noi consideriamo i costumi delle donne, bastava a questa la rocca e l’ago o il telaio, se ella avesse voluto vivere vilmente secondo l’usanza della maggior parte; ma perchè ella, sollecita nello sacro studio, forbì dallo ingegno tutto la ruggine della pigrizia, e arrivò in eternale fama; alla quale volesse Iddio, che con buono animo, guardassero quelle, le quali reputano gran cosa stare in camera e occupare lo tempo irrecuperabile in vane favole, e spesse volte dalla mattina per tempo fino alla sera e tutta notte vegghiare, parlare rie parole e vane, ovvero soprastare alla lascivia di sè medesime; perchè veramente conoscerebbero quanta differenza sia l’acquistar fama con opere lodevoli, e seppellire la fama col corpo, e partirsi della vita come se non fussero vivute.
CAPITOLO LXXXXVI.
Faustina Augusta.
Faustina Augusta, e poi posta, fra gl’iddii, acquistò vivendo e morendo molta gloria più per benignità di suo marito, che per sua opera. Ella fa figliuola d’Antonino Pio imperadore, e di Faustina moglie di quello, e fu moglie di Marco Antonino, adottato per figliuolo da Antonino Pio; e morto suo padre ella signoreggiò insieme col marito. Per dicreto del senato fu appellata Augusta, la qual cosa non era piccola cosa a una donna in quel tempo; e benchè innanzi gl’imperadori fossero chiamati Augusti, niuna imperadrice trovo innanzi a questa esser chiamata Augusta per dicreto del senato. Ancora ella fu di sì singolare bellezza, che alcuna cosa di divinità pareva mischiata con la sua mortalità; la quale acciocchè non si consumasse per vecchiezza nè per morte, avvenne che la sua faccia, essendo ella giovanetta, e poi in più ferma età, fu iscolpita in moneta d’oro, d’argento e rame; e dura infino a questo tempo, nella quale, benchè manchi l’abito della faccia, lo movimento degli occhi, lo vivo colore, la piacevolezza della faccia, la forma nondimeno mostra grandissima bellezza. E certo quanto di lei è fama in tutto lo mondo, tanto di quella è infamia di macchia di disonestà; e fu creduto che oltre allo matrimonio ella non fusse contenta d’uno amico, anzi tenne brigata con molti, de’ quali la infamia discoperse i nomi d’alcuni, perchè fu nominato tra i suoi adulteratori un certo Vettilo, e così fu reputato Orfico, e dopo questo Moderato; ma quello che passò in tutto gli altri, fu chiamato Tercolo, il quale si dice che fu trovato a cena con lei da Antonino. E sopra questo seguì Marco Vero, non ostante che fusse suo genero, marito di Lucilia sua figliuola. E, che è più brutta cosa di tutte, dicesi che ella amò tanto un gladiatore, che per appetito di quello occorse in una infermità poco meno che mortale; e per desiderio di guarire ella manifestò ad Antonino la sua concupiscenza; e che per mitigare quello ardore, di consiglio del medico usò per rimedio dell’infermità, fare uccidere quello gladiatore, e del sangue suo, sendo ancora caldo, fece ugnere tutto il corpo della inferma. Il quale rimedio certamente i savj credettero finto; imperocchè in processo di tempo Antonino Commodo, il quale in quel tempo fu generato, fa reputato piuttosto figliuolo di gladiatore che d’Antonino, e non per l’ugnere del sangue, ma per iscellerata lussuria di quella collo gladiatore: la qual cosa fece testimonianza della verità. Le quali cose sendo divulgate ad infamia di Faustina, Antonino fu confortato da amici che la uccidesse, o almeno la repudiasse, che era più umanità. Ma Antonino, che era di pietoso animo, benchè portasse molestamente gli adulterj della moglie, non volle consentire lo consiglio, e volle piuttosto comportarla che arrivare a maggior vergogna; e non rispose agli amici che lo confortavano, se non che per lo repudio si conveniva restituire la dota; volendo che per questo egli intendessero che per Faustina egli teneva lo imperio. Ma lasciando queste cose, molto spesse volte per certo le più oneste, certe volte per lo troppo guardare, non accorgendosi, sogliono cadere. E tornando da’ vizj alle virtù; reggendo Antonino magnificamente la repubblica, appresso de’ re orientali avvenne, che Faustina morì d’infermità nella terra chiamata Aidea appresso al Monte Tauro; la quale per prieghi d’Antonino il senato la ripresentò fra gl’Iddii, e poi fu chiamata la divina Faustina: la qual cosa era avvenuta innanzi appresso a’ Romani d’alcuna donna. E avendo chiamato Antonino lei innanzi Madre del campo, fecele edificare un tempio maraviglioso in quel luogo ove ella era morta; e in quello fece porre maravigliose statue di sua fama; e ordinò in quel tempio fanciulle, le quali, consegrate a sacerdozio, volle che fusseno chiamate Faustine. E così in quel luogo fino a certo tempo Faustina fu reputata famosa Dea, acciocchè quella fama che le avea tolto la lussuria, la deità le restituisse.
CAPITOLO LXXXXVII.
Zenobia, Reina de’ Palmireni.
Zenobia, reina de’ Palmireni, per testimonianza degli antichi scrittori fu di sì eccellente virtù, che per nominanza ella dee essere preposta innanzi alle altre genti. Questa fu primieramente nobile per nazione, perché dicono gli antichi, che ella ebbe origine famosa dai Tolomei, re di Egitto, benchè non si ha ricordanza chi fusse suo padre e sua madre. E dicono che questa della prima puerizia dispregiò gli esercizj di donna; e già alquanto cresciuta e fatta forte, per la maggior parte si dice che ella abitò per boschi e luoghi salvatichi, e con l’arco e saette perseguiva i cervi, correndo, e i cavriuoli; e poi fatta più forte veniva alla presa con gli orsi, perseguiva e aspettava e pigliava e uccideva i leopardi e i lioni; e senza paura discorreva per rivi e per altri passi di montagna; cercava le tane delle fiere, e di notte dormiva all’aria; con maravigliosa potenzia comportava la piova, il caldo, il freddo; con somma diligenzia era usata spregiare l’amore e la conversazione degli uomini, e a pregiare la verginità. Per le quali cose avendo cacciato la morbidezza delle femmine, dicono che ella era fattasi robusta, che ella vantaggiava per forza i giovani di sua età in battaglia di balestra e in giuochi. E finalmente essendo venuta a età di matrimonio, per consiglio degli amici, dicono che ella si maritò a Odenato, giovane indurato a simili esercizj, lo quale era molto nobile principe de’ Palmireni. E era questa bella del corpo, benchè alquanto bruna di colore, come per lo caldo del sole sono tutti gli abitatori di quel paese: ancora ella avea bellezza di neri occhi, e bianchi denti. La quale vedendo Odenato, intento ad occupare i regni d’Oriente, essendo preso e dannato a brutto servizio Valeriano da Sapore re di Persia; e Galieno suo figliuolo come effemminato stare in ozio; e non avendo dimenticato la prima durezza; deliberò di nascondere la sua bellezza sotto le armi, e usare la milizia sotto suo marito, e con lui prese il nome reale e l’ornamento. E con Erode figliastro avendo raccolto suo sforzo, andò contro Sapore animosamente, il quale già ampiamente occupava Mesopotamia: e non isparmiandosi alcuna fatica, alcuna volta facendo l’ufficio di soldato, alcuna volta di capitano, uccise non solamente quello aspro uomo e esperto, in virtù della battaglia e delle armi; ma fu creduto che per opera di quella, Mesopotamia venisse sotto sua signoria: e preso il campo di Sapore con le sue femmine, cacciò e persegui quello infino a Ctesifonte. E non molto dappoi ella curò con sollecito studio di soperchiare Quieto, figliuolo di Matriano, il quale sotto il nome di suo padre era entrato nell’imperio di Oriente. E già tenendo insieme col marito quieto tutto l’Oriente, il quale aspettava ai Romani; il marito Odenato, secondo che alcuni dicono, fu morto con Erode suo figliuolo da Meonio suo cugino per invidia. Alcuni altri dicono, che Zenobia consentisse la morte d’Erode, perchè molto spesso dannava la sua delicatezza; perchè la successione del regno pervenisse a Eremiano e Timolao, i quali ella avea generati di Odenato. E signoreggiando Meonio, alquanto ella stette quieta; ma dopo brieve tempo essendo morto Meonio dai suoi cavalieri, quasi essendo lasciata la possessione vacua, quella donna di nobile animo subito entrò nella desiderata signoria; e essendo ancora piccoli i suoi figliuoli, ella si presentò vestita a modo di re, e in nome dei figliuoli governò la signoria molto meglio che non si conveniva a femmina, e non vilmente. Perchè Gralieno e dopo lui Claudio imperadore non ardirono contrastare contro a lei alcuna cosa, nè ancora similmente gli Orientali, gli Assirj, nè gli Arabi, nè i Sarracini de’ popoli di Armenia; anzi temendo quegli tutta la sua potenzia, erano contenti poter difendere i suoi confini; perchè quella ebbe tanto magisterio di battaglie, e sì aspra disciplina di milizia, che ugualmente i suoi osti la pregiavano e temevano molto. Appresso de’ quali ella non parlamentava mai se, non con l’elmo in testa e con armi; molte rade volte usava carretta, e andava spesso a cavallo, e alcuna volta a piè innanzi alle insegne cogli cavalieri tre e quattro miglia; e mai aveva in fastidio alcuna volta bere coi suoi capitani, benchè ella fusse sobria, e beveva cogli principi di Persia e d’Armenia che vinceva di piacevolezza e di costumi. Ella fu sì aspra conservatrice d’onestà, che, non che ella s’astenesse al postutto dagli altri uomini, ma eziandio non si congiugneva mai con Odenato suo marito, secondo che ho letto, se non per generar figliuoli, sempre avendo questa diligenzia, che quando era congiunta che ella s’accorgeva se ella era gravida, e poichè questo avveniva, non comportava poi essere tocca dal marito infino alla purgazione del parto; e quando ella s’accorgeva non essere gravida, consentivasi al marito a sua posta. Oh, quanto questa era laudabile opinione di donna! assai appare che ella giudicava che la lussuria per niuna altra cagione è data agli uomini che, rinnovandosi i figliuoli, si conservino quegli che deono venire, e da quello in suso sia un avanzo vizioso. Ma troverai molte rade volte donne di siffatti costumi. Nondimeno acciocchè io non dimenticasse l’opportune cose della casa, mai non lasciava, o rade volte, entrare dentro alcuni, se non eunuchi, ed uomini gravi d’età e di costumi. Ancora ella visse a modo di reina con magnifica spesa, con quella pompa che usano i re di Persia, e secondo l’usanza di Persia volle essere adornata, e faceva conviti a simiglianza degl’imperadori romani usando quegli vasi d’oro che ella avea uditi usare a Cleopatra. Benchè ella fusse grandissima conservatrice di tesoro, niuno fu più magnifico e più largo, dove le pareva che fusse il bisogno. E benchè per la maggior parte ella soprastasse in caccie e arme, non mancò che non imparasse le lettere d’Egitto, e ancora in parte le lettere greche sotto Longino filosofo, suo maestro. Per aiutorio delle quali ella vide tutte le storie latine, greche e barbare, con sommo studio, e con mandarle alla memoria, e non solamente questo, ma fu ancora creduto ch’ella riducesse quelle sotto brieve forma. E oltre al suo linguaggio ella seppe quello d’Egitto, quello di Soria; e volle che i figliuoli parlassino latino. Ma, poche più parole al certo: questa donna fu di tanto valore, che essendo vinti Galiano, Aurelio e Claudio imperadore, ella trasse contro a sè Aureliano, uomo di perfetta virtù, essendo egli fatto imperadore, per purgare la vergogna della nominanza de’ Romani, e per acquistare gran gloria. Essendo compiuta la guerra di Marco Mannico, essendo quietato ancora Aureliano con ogni sollecitudine, pigliò l’andata contra Zenobia: e andando contro le nazioni barbare, avendo sconfitte nobilmente molte legioni, finalmente arrivò con molte legioni poco lungi da Emessa, città presso alla quale Zenobia non impaurita insieme con Zeba (il quale ella avea preso per compagno della guerra) ella s’era posta col suo oste, e in quel luogo fu combattuta aspramente e per lungo spazio della somma del fatto tra Aureliano e Zenobia; messa in rotta cogli suoi, cioè Zenobia, da Aureliano per la virtù de’ Romani, ridussesi a Palmiro, dove subito ella fu assediata dal vincitore. E non volendo udire alcuna condizione d’arrendersi, difendevasi con maravigliosa diligenzia e sollecitudine, venuta già a necessità delle cose opportune. Poi non pensando i Palmireni contrastare alla possanza d’Aureliano, essendo eziandio sottratti dall’ajutorio di Zenobia quegli di Persia e d’Armenia e i Stracani, i quali venivano in suo aiuto; fu presa per forza quella città da’ Romani. Dalla quale città partita Zenobia colli figliuoli fuggì in Persia sopra i camelli, dove perseguita fa presa co’ figliuoli dalla gente d’Aureliano, e a lui presentata viva: per la qual cosa Aureliano fu glorioso non altrimenti che se egli avesse vinto uno grandissimo capitano, asprissimo nimico della repubblica; e salvando quella al trionfo, menolla a Roma co’ figliuoli. Poi fu apparecchiato il trionfo ad Aureliano maraviglioso per la presenza di Zenobia; nello quale, tra, le altre cose nobili e degnissime di ricordanza, egli menò lo carro, lo quale Zenobia avea fatto fare di grandissimo pregio d’oro e di perle, sperando venire a Roma non prigione, ma donna imperadrice e trionfante, e possedere lo ’mperio di Roma. Dinanzi a quello carro ella, andava co’ figliuoli ed era legata il collo, le mani e i piedi con catene d’oro, con corona e vestimenti reali carichi di perle e di pietre preziose, intanto che, essendo ella fortissima, spesse volte per lo peso stava ferma. E finito il trionfo maraviglioso per lo tesoro, e per la virtù di Aureliano, dicesi che ella invecchiò co’ figliuoli in privato abito fra le donne romane; e fulle conceduto una possessione dal senato presso Tivoli, la quale dappoi per lungo spazio fu denominata da lei Zenobia, non molto lungi dal palazzo del divino Adriano, in quel luogo, che era chiamato dagli abitatori Conche.
CAPITOLO LXXXXVIII.
Giovanni Anglica.
Giovanni, benchè paia uomo quanto al nome, nondimeno al fatto fu femmina; la cui inaudita presunzione la fece conoscere a tutto il mondo, e per innanzi saputa. Benchè si dica per alcuni che ella fosse di Magonza, appena si sa qual fusse il suo proprio nome; avvegnachè alcuni dicano quella avere avuto nome Giliberta. È manifesto questo, che ella fu amata da uno giovane scolare nella sua gioventù; il quale dicono, che ella amò tanto, che, messa giù la paura e la vergogna d’una vergine femmina, fuggì di casa di suo padre nascosamente, e mutata in abito d’uno fanciullo, seguì quello: appresso del quale studiando ella in Anglia, fu pensato da ognuno, che ella fusse uno chierico, dove ella era della milizia di Venere, e dello studio. Poi essendo morto il giovane, conoscendo ella sè medesima avere buono ingegno, essendo tratta da dolcezzi di scienza, tenendo l’abito, non si volse accostare ad altri, nè manifestarsi sè essere femmina; ma attenendosi sollecitamente allo studio, fece tanto profitto nelle scienze liberali, che era tenuta eccellente innanzi agli altri; e così ornata di mirabile scienza già in età provetta si partì d’Anglia, e andò a Roma, dove leggendo alcuni anni le scienze primitive, ebbe maravigliosi uditori. E essendo oltre alle scienze di singulare santità e onestà, fu creduto da ogni uno che ella fusse uomo. Per questo conosciuta da molti, e morendo Leone Papa Quinto, di consentimento di tutti i venerabili Cardinali fu eletta Papa in luogo di quello che era morto, e fu chiamata Giovanni. La quale femmina non temendo montare in sulla sedia del Pescatore, e trattare i sacri Misteri tutti, e darli ad altri, non concesso ad alcuna femmina per la Religione de’ Cristiani; tenne l’altezza del Papato alcuni anni, e femmina, tenne in terra il vicariato di Cristo. E avendo egli dal Cielo misericordia del suo popolo, con comportò che femmina tenesse sì maraviglioso luogo, nè che soprastasse a sì gran popolo, nè che egli fusse ingannato per sì malvagio errore. Per la qual cosa, confortandola il diavolo, il quale l’avea menata, e tenevala in quella scellerata audacia, e avendo in privata vita servata speziale onestà, montato in sì alto pontificato, cadde in lussuria. E come questo fu peccato indegno, e come maravigliosa la sapienza di Dio, finalmente mancò l’ingegno a nascondere l’adultero parto a quella che sì lungamente aveva potuto ingannare gli occhi degli uomini. Imperocchè essendo quello più presso al termine che non si credeva, ella andò per fare annuale sacrificio alla chiesa di san Niccolò al Laterano tra il Culiseo e la chiesa di Clemente Papa; non essendovi alcuna femmina per balia presta nella via, partorì pubblicamente; e manifestò con che inganni aveva ingannati tutti gii uomini, salvo che lo amante. Per questo fu messa quella in prigione misera col suo parto, dove finì sua vita. E a vituperazione di sua disonestà, e per continuare la sua infamia insino a questo tempo, il Papa facendo con lo clero e con lo popolo la processione, e venendo a quel luogo del parto, il quale è in mezzo del cammino, per abbominazione di quello piegano la via per gli altri sentieri: così passato lo vituperoso luogo, tornati alla via, compiono lor viaggio (D).
CAPITOLO LXXXXIX.
Irene Ateniese.
Irene fu una donna nobilissima d’Atene, e fu famosa di singolare bellezza, la quale avendo fatto andare da casa sua a Costantinopoli Costantino imperadore, diedela per moglie a Lione suo figliuolo. E dopo la morte di Costantino diventata imperadrice, generò di suo marito e partorì uno figliuolo chiamato Costantino. Finalmente, morto Lione, ella resse nobilmente l’imperio con Costantino suo figliuolo molto giovanetto per lo spazio di dieci anni. Ma essendo egli diventato grandicello, affermando egli, che la signoria veniva solo a lui, rimosse quella, secondo che dicono alcuni, da sua compagnia per ispazio di nove anni. Poi quella donna di grande animo, volenterosa di signoreggiare, essendo venuta a discordia col figliuolo, il quale si fidava di sua potenzia, e toltagli la signoria, lo teneva in prigione; e ella solamente alla terra, della quale innanzi tutto il mondo avea tolte le leggi, e oltre agli altri uomini famosa imperadrice, signoreggiò per tempo di cinque anni con gran gloria. Ma per opera degli amici di Costantino avvenne, che per aiutorio degli Armeni Irene fu tolta da signoria; e Costantino tratto di prigione fu messo nella sedia del padre, il quale più pietoso verso la madre che non aveva trovato lei contro a sè; avendo più speranza nella possanza degli amici, non la mise in prigione, ma fu contento di partirla da sé, e metterla nel palazzo d’Eleuterio, il quale ella medesima avea fatto edificare con grandissima abbondanzia di cose, chiamando dall’esilio tutti gli amici di quella. E nondimeno avendo egli infelicemente intentato guerra contro ai Bolgari; e per questo avendo tentato i maggiorenti torgli lo regno, e sostituire in suo luogo Niceforo suo zio, inasprito per ira, proruppe in brutta crudeltà, e fece cavare la lingua a Niceforo e a Cristofaro frategli, poi fece cavare gli occhi ad Alessio, patrizio d’Armenia, e costrinse Maria sua moglie pigliare abito di monaca, e tolse per moglie Teodata cameriera, la quale subito egli incoronò. Per le quali scelerità Irene provveduta donna, benchè costretta avesse messo giuso la fortuna dell’imperio, nondimeno avea servato il nobile animo; prese speranza di ripigliare lo ’mperio, se ella donasse della moneta a’ maggiorenti. Aperto largamente lo tesoro ch’ella aveva riposto nel palazzo dove ella abitava dispartita, fece nascosamente favorevoli a sè gli animi degli principi dello imperio. E avendo condotti quegli con ampj doni a sua volontà, fece che quegli i quali l’avevano tolta la signoria pigliarono Costantino e accecaronlo; e così l’animosa donna ricoverò l’imperio, lo quale gli era stato tolto innanzi, e Costantino infermato morì. E finalmente avendo signoreggiato da capo cinque anni, fu assediata da Niceforo, il quale contraddiceva nel palazzo d’Eleuterio: il quale avendo ricevuta la corona da Acarisio Patriarca di Costantinopoli, favoreggiando Leone e Tritile patrizj, e Sicofe nuovamente fatti ricchi da Irene, tanto fece, che, come egli entrò ad Irene, usò con umiltà e con lusinghe e accorgendosi ella, nondimeno ella non dimandò alcuna cosa della signoria, se non il palagio nel quale ella era, acciocchè ottenuta la promissione della domanda, aprisse a lui tutto il tesoro. Le quali cose ottenute, lo malvagio uomo tradito a lei la fede, mandò quella ai confini in Lesbo; dove ella già vecchia finì sua vita. Nondimeno altri giudicano diversamente del fine di costei. Dicono alcuni, che essendo in discordia la madre e il figliuolo, e privandosi l’uno e l’altro della signoria dell’imperio più volte, che i Romani ribellarono da quello, e mutarono lo ’mperio in Carlo Magno, in quel tempo re di Francia, e egli, attento di ridurre insieme l’imperio che pareva diviso, toglieva per moglie Irene, e che Irene l’accostò a lui; della qual cosa come s’accorse Erizie, gentiluomo patrizio, incontanente mise innanzi Niceforo; ed assediata Irene costrinsela ad entrare in un monistero lasciando ella la signoria; e in quello finalmente invecchiò.
CAPITOLO C.
Engeldruda, donzella fiorentina.
Engeldruda, donzella fiorentina, ebbe origine da una famiglia de’ Ravignani famosissima fra le famiglie della nostra città; la quale io ho giudicato porre fra le famose donne per la sua maravigliosa audacia a difendere la purità del suo animo innanzi allo imperadore de’ Romani. Questa essendo andata già nel tempio di Marte, il quale fu poi consagrato a Dio, sotto vocabolo di S. Giovanni Batista, ad una festa con molte donne fiorentine avvenne che Ottone, quarto imperadore romano, il quale allora era tornato a Firenze, a fare bella festa e per accrescerla con la sua presenzia, entrasse nel tempio con gran compagnia di gentili uomini. Essendo in sul più alto luogo, e guardando sopra gli ornamenti del tempio, e intorno la moltitudine de’ cittadini, e le donne che sedevano d’intorno, avvenne che egli fermò gli occhi in Engeldruda, e maravigliandosi per alcuno spazio della bellezza di quella, e dell’abito distinto da niuna vanità, e dell’onestà e della fanciullesca gravità, lodando quella, convertì le parole verso Illizione, il quale era uno de’ cittadini, venerabile per età e pet gentilezza, e forse allora per la milizia stando quello presso a lui, dicendogli: Chi è quella fanciulla la quale siede dirimpetto a noi, la quale, per mio giudizio, avanza d’onestà e di bellezza di volto tutte l’altre? Al quale Illizione ridendo, e con alcuna piacevolezza disse: Serenissimo imperadore, quale ch’ella si sia, s’io il comanderò, ella ti bacerà. Le quali parole come quella fanciulla udì, subito si sdegnò, portando molestamente che il padre mostrasse sì leggiera opinione di sua fermezza e di guardia di sua onestà, e non potò portare l’offesa per lungo spazio, ma non rispondendo ancora, levata in piede, e fatta rossa nella faccia, levando alquanto gli occhi contro al padre, poi abbassati, disse sicuramente con umili parole: Padre mio, taci e non favellare, perchè se tu non mi farai forza, niuno, salvo quello che tu mi darai per marito, potrà avere quello che tu profferi sì ampiamente. E veramente non dee cadere da animo di grande uomo quello detto. Lo ’mperadore stette alquanto con ammirazione; ma poi non contrastando asprezza tedesca, non conoscendo già quella fanciulla, per le parole giudicò lo santo casto proponimento del petto di quella vergine. E avendo lodato la indegnazione e lo detto di quella fanciulla con molte parole, fece chiamare uno nobile giovane chiamato Guido, acciocchè non mancasse alla fanciulla chi ella potesse baciare onestamente in presenza di suo padre; e rendendogliene grazie, diè per moglie Engeldruda a Guido innanzi che egli si partisse, e dotò quella nobilmente, pensando quello che la fanciulla avea detto, il giusto ed il buono non solamente stare nel segreto di quella, ma essere proceduto per forza di giusta indignazione da ampio nutrimento di virtù; e per quello essere stato molto degna del dono dello Imperadore. Dunque così quella che era entrata vergine nel tempio, per la integrità dell’onestà tornò con somma allegrezza del padre e de suoi sposata in casa del padre: e in processo di tempo partorendo molti figliuoli, morendo, lasciò ornata e famosa la casa del marito di nobile schiatta; e dura insino al presente la moltitudine dei suoi discendenti. E piacemi aver dette queste cose a vergogna delle fanciulle del nostro tempo, le quali sono di tanta leggierezza, e di sì sfrenati costumi, che paiono piegarsi per guardi e per cenni alla volontà di ciascuno che le guarda.
CAPITOLO CI.
Costanza, Reina di Sicilia.
Costanza romana imperadrice fu famosa in terra della somma altezza del mondo; ma perchè ebbe lo comune onore con molti, pare avere menomato l’ammirazione di quegli che guardano: quegli che nella nostra età vogliono apparare, hanno da cercare, altra cagione d’eccellenza, la quale non mancò a questa: e certamente se non le fu conceduto per alcuno altro merito, almeno per un solo figliuolo diventò famosa. Questa fu figliuola di Guglielmo, ottimo re di Sicilia, nella cui natività, secondo che molti dicono, Giovacchino, abate Calavrese, dotato di spirito profetico disse a Guglielmo, che la figliuola per innanzi sarebbe la distruzione del regno di Sicilia. Per lo quale augurio impaurito, e maravigliatosi, credendo allo augurio, cominciò a pensare con ansietà per che modo potesse avvenire per una donna; e non vedendo che potesse essere se non per lo marito e lo figliuolo di quella, avendo compassione al suo regno, diterminò, s’egli potesse, tor via questa per sua provisione. E acciocchè egli togliesse via la speranza del matrimonio e dei figliuoli, rinchiuse quella verginetta in un chiostro di monache, e fecele promettere a Iddio perpetua verginità: e non fu da dispregiare sua provisione se fusse giovato. Ma perchè noi stolti e deboli ponemo contro a Iddio i nostri sforzi, il quale purga giustamente gli scellerati fatti degli uomini? certamente noi c’inganniamo ad una e minima percossa. Essendo morto lo suo santissimo padre e il suo fratello, non essendo rimaso niuno suo legittimo erede del regno, salvo ella; avendo già consumata tutta sua gioventù, e già essendo fatta vecchia; e dopo la morte di Guglielmo avendo preso la corona del regno Tancredi, e dopo quello Guglielmo suo figliuolo, ancora fanciullo essendo, avvenne o per la indegna rinnovazione dei re, che per opera de’ Baroni, nascendo le guerre di ciascuna parte, lo regno pareva andare tutto in esterminio per ferro e per fuoco. Per la qual cosa avendo compassione alcuni della sciagura, vennegli a mente quello che seguì dappoi, cioè che Costanza fusse data per moglie ad alcuno principe; acciocchè per la potenzia di quello per sua opera fusse vietato lo mortale movimento. E non si ottenne senza inganno e gran fatica, consentendolo il Papa, che Costanza consentisse a cosiffatta opinione, stando ella ferma nel proposito di sua professione, e eziandio parendo contrastare. Ma repugnando ella, e già essendo avvenuto che non si poteva comodamente ritrarre, fu data per moglie a Arrigo imperadore di Roma, figliuolo innanzi di Federico primo. E così la crespa vecchia lasciato lo santo chiostro, messe giuso le bende monacali, ornata di vesti reali, maritata, imperadrice si manifestò; e quella che avea consagrato a Dio perpetua verginità, entrata nella camera dello imperatore, e montata nel letto matrimoniale, mise giuso a mal suo grado quella verginitade. Di che addivenne, non senza ammirazione di quegli che l’udirono, in età di cinquantacinque anni ella ingravidò. E non essendo dato fede a quella gravidezza, e essendo creduto da più che quello fusse inganno, a tor via lo sospetto, fu proceduto provedutamente, che appressandosi il tempo del parto, di comandamento dello imperadore fusse mandato per le donne di Sicilia, sicchè tutte le donne, quelle che volessero, fussero presenti al futuro parto. Le quali sopravvenendo eziandio di lungi, posero nei prati le tende fuori della città di Palermo, e, secondo alcuni, drento alla città; e riguardando ognuna, la vecchia imperadrice partorì, cioè, Federico; lo quale poi, cresciuto maraviglioso uomo, fu peste di tutta Italia non che del regno di Sicilia, acciocchè non fallisse l’augurio del calavrese Abate. Dunque chi non penserà che la gravidezza e il parto di Costanza fusse maraviglioso, poichè oltre a questo non sia udito alcuno alli nostri tempi anzi dalla venuta di Enea in Italia, salvo uno parto di sì antica donna, cioè d’Elisabetta moglie di Zaccheria, della quale per singolare opera di Dio nacque Santo Giovanni, al quale non doveva poi nascere pari intra i figliuoli delle femmine (E).
CAPITOLO CII.
Camiola Sanese.
Camiola vedova, donna famosa delle bellezze del corpo e de’ costumi, di cortesia e laudabile onestà, per nazione fu di Siena, e figliuola di Lorenzo di Toringo, uomo d’ordine militare. Condusse sua vita presso a Messina città di Sicilia con un solo marito infine che eglino vissero nondimeno lodevolmente che nobilmente. E essendo re dell’isola Federico terzo, e quel medesimo essendo imperadore, e morendo i suoi, ella rimase erede di ricchezze quasi reali; e servando ella onestà, Federico predetto già essendo morto, e a lui sendo sostituito Piero suo figliuolo; avvenne che di comandamento del re s’apparecchiava a Messina una grande armata sotto capitananza di Giovanni, conte di Chiaramonte, a quel tempo uomo di grandissima prodezza, per dare soccorso ai Liparitani assediati, per fame ridotti ad estremitade, nella quale armata montarono non solamente cavalieri condotti per soldo, ma molti nobili per aiutorio volontariamente, così di quegli della marina come di quegli che abitavano fra terra per acquistare gloria d’arme. Ed avea assediata quella città Gottifredo di Squillazzo, valente uomo, in questo tempo prefetto di mare di Roberto, re di Sicilia e di Gerusalem; il quale avea sì indeboliti quegli della terra, che egli assediò con marrangoni e difici da combattere, e con le spesse battaglie, che si sperava che tosto s’arrendesse. E avendo saputo per ispie d’alcune barche, che l’armata de’ nimici era molto maggiore che la sua; ridotto le sue navi insieme, cominciò a aspettare la fortuna del fatto. Ma i nimici, presi subito i luoghi abbandonati, non impacciando alcuno, portarono lo soccorso a quegli della terra, il quale eglino avevano portato. Per la quale prosperità Giovanni insuperbito richiese Gottifredo di battaglia, la qual cosa non rifiutando quell’uomo d’ardentissimo ingegno, e la notte aendo fortificato di torri e di pareti, e avendo ordinate le navi, ed altre cose; nello apparire dell’aurora con ardenti parole avendo confortati i suoi alla battaglia, levate l’ancore e dato il segno, volse le prode a’ Siciliani. Ma Giovanni, lo quale non credeva che Gottifredo aspettasse la possanza delle navi dei Siciliani, non ch’egli pigliasse la battaglia, non avea apparecchiate le sue navi a combattere, anzi a seguire quelle, che fuggissero; vedendo l’apparecchiamento e l’ardore dei nimici che sopravvenivano, quasi mancandogli l’animo, pentissi di avere domandato quello che egli avea pensato non potere ottenere; e già sfidandosi del fatto, assai avendo raffreddato l’animo, acciocchè al postutto non paresse invilito, subito rivolse l’ordine a battaglia, quanto per lo spazio gli fu conceduto, e diede lo segno della battaglia. Già erano presso i nimici, i quali, levato lo rumore, avevano mescolate le prode con l’armata de’ Siciliani la quale veniva pianamente, e incominciava la battaglia. Gittati uncini di ferro nel primo assalto con lance e con saette, stando pigri e quasi smarriti i Siciliani per la subita commutazione; la gente di Gottifredo innanzi volontariamente correndo a presentarsi ai navili de’ nimici, cominciarono a combattere con le mani e con le spade, e a bagnare ogni cosa di sangue. I Siciliani, già disfidandosi, rivolgendo le prode, quegli che poterono, volsero le spalle. E apparendo quegli di Gottifredo essere vincitori, affondaronsi molte delle navi de’ Siciliani, e molte ne furono prese, e poche più leggieri per virtù de’ galeotti camparono salve. E in quella battaglia pochi morirono, ma molti ne furono feriti: Giovanni, prefetto dell’armata, fu preso, e con lui tutti i nobili i quali volontariamente erano andati in su l’armata, e de’ galeotti molti, e molte insegne de’ cavalieri e delle navi, e il grande stendardo del re, lo quale era portato nella nave del pretore. E essendo venuta la terra a rendersi, perseguiti da fortuna di mare, furon menati a Napoli in catena e messi in prigione. E era tra quegli un giovine chiamato Orlando, figliuolo bastardo del re, bello del corpo e valente; il quale, essendo cercato riscattare tutti gli altri presi, solo essendo ritenuto, partendosi tutti gli altri, rimase tristo in prigione: perchè Piero re, al quale spettava il fatto del fratello, perchè la cosa era stata malcondotta, e oltre al suo comandamento, avea in odio così quello come gli altri, i quali erano stati in quella battaglia navale. Dunque essendo quello così in prigione e quasi senza speranza di libertà, e stando inferriato, avvenne ch’egli tornò a memoria a Camiola, la quale vedendo quello dispregiato da’ suoi frategli, ebbe compassione alla sciagura; e deliberò con seco, s’ella potesse onestamente volere ridurre quello a libertà: e non vedendo alcun’altra via, salvando l’onore di sua onestà, s’ella non lo togliesse per suo marito; nascosamente mandò chi cercasse, se per quello modo egli volesse uscire di prigione: fu ottenuto leggiermente; e così servata ogni solennità di ragione, sposò quella come moglie per procuratore, consentendolo, e sotto fermezza dello anello. E senza indugio mandato da Camiola dumila once d’argento, e pagato, tornò libero della prigione; e non andò altrimenti a casa della sposa come se non se ne fussa fatto parola. Camiola primieramente si maravigliò; e finalmente sentendo la ingratitudine di quell’uomo, sdegnossi; poi, acciocchè non paresse mossa da ira più che da ragione, piacevolmente fece richiedere quello ch’egli compiesse le nozze; il quale avendo negato che niuna cosa aveva a fare con lei, fecelo richiedere innanzi al giudice ecclesiastico, e con le autentiche carte per testimonianza di valenti uomini vinse quello essere marito. La qual cosa poi vergognandosi egli confessò: e poichè il beneficio di quella donna verso di lui fu conosciuto, ripreso da’ frategli e stimolato dagli amici, fu indotto a consentire la domanda di quella donna, e domandò fare le nozze. Ma quella donna di grande animo favellò quasi queste parole in presenza di molti: Orlando, io ho onde ringrazj Iddio; perchè, innanzichè sotto questo pretesto di matrimonio tu viziassi l’integrità della mia onestà, hai mostrata la malvagità della tua perfidia; e consentendo quello, lo cui nome santissimo tu ti sei sforzato beffare con lo malvagio spergiuro, con la ragione io ho riprovata la tua bugia, la quale è grandissima a me di te e di tuo matrimonio. Io penso che tu credesti, essendo ancora in prigione, ch’io avessi smenticato me e la mia condizione, e che mattamente io desiderassi tua bellezza con un ardore femminile; e questa, come tu avessi ricoverato tua libertà con la mia moneta, con una negazione beffare, e vituperarla; e come tu fossi tornato a’ primi onori torre per moglie più gentil donna: e quanto tu hai potuto, ti se’ sforzato al fatto; ma Colui che da alto vede le basse cose, e che non abbandona quegli che sperano in lui, conosciuta la purità della mia mente, ha fatto, che con poca mia fatica io abbia guasto i tuoi inganni, e discoperta la tua ingratitudine; e mostrassi la tua malvagità; e non ho fatto questo tanto per vituperare la tua crudeltà nè per mio fatto, ma perchè innanzi i tuoi frategli e gli altri possano vedere quello sia da commettere alla tua fede, quello che gli amici possano sperare, quello che nimici possono temere. Io ho perduto l’oro, e tu la fama; io ho perduto la speranza, e tu la grazia del re e degli amici. Le donne di Sicilia si maravigliano della mia cortesia, e magnificommi la loro lode, tu se’ fatto a conoscenti e a non conoscenti vituperoso giuoco. In questo nondimeno per alcuno spazio sono stata ingannata: io pensava avere tratto di prigione reale e magnifico giovane, dove io veggo avere liberato bugiardo ribaldo, traditore e ruffiano, crudele bestia. E non voglio che tu creda avermi tratto in questo: mossemi la recordazione de’ beneficj di tuo padre, se il serenissimo Federigo, re di santa recordazione fu, tuo padre, la qual cosa appena posso credere, che di sì famoso principe nascesse sì scornato figliuolo. Tu pensasti indegna cosa, che una vedova di sangue non reale avesse marito di schiatta reale, giovane robusto e bello, la qual cosa io confesso volontariamente. Ma io vorrei, e tu puoi con ragione, che tu mi risponda: quando io credeva averti fatto mio col mio servizio, e quando io pagai per la tua libertà moneta, dove era allora la tua libertà, dove era la tua gran forza, dove era la tua bellezza? erano coperte da oscura caverna, nella quale tu eri tenuto stretto, tutte queste cose: la pallidezza della luce non veduta, e la puzza dell’oscura prigione, per le quali cose tu debole marcivi puzzolente abbandonato da ogni uomo, avevano oppresse queste tue virtudi, le quali tu superbo magnifichi: non solamente allora tu dicevi me degna d’uno reale giovane, ma di celestiale Iddio. O come lievemente, o come tosto tu, giovane scelleratissimo, come tu rodesti lo cielo della tua patria oltre la tua speranza, già volgesti la tua opinione! non ricordandoti poi che tu fosti in tuo arbitrio, che io sono Camiola, la quale ebbi compassione alla tua avversità, la quale sola per la tua salute pagai la mia moneta; io sono Camiola che col mio denaro ho riscosso dalle mani del capitale inimico de’ tuoi maggiori, dalle catene, dalla prigione, dall’estrema miseria. Io ti drizzai a speranza, essendo tu già caduto in disperazione, io t’indussi nella patria; io ti ritornai nella casa reale nella prima vita; io t’ho fatto reale, robusto e bello giovane, di prigione brutto e debole. Ma perchè ti ridico io a memoria quelle cose delle quali ti dei ricordare, e che tu non puoi negare? ora tu per sì memorabili servigi m’hai rendute queste grazie, e che hai ardito dire te non essere mio marito e dispregiare lo matrimonio fermato per onesti e santi testimonj e per sagrate carte; e la tua ricomperazione dispregiare, e invilire; e macchiare me, se tu avessi potuto, con brutta sospizione. Tu uomo di non sana mente ti vergognavi d’avere per moglie una vedova nata di padre d’ordine di cavalleria? or quanto era meglio esserti vergognato di avere fallito alla detta fede, avere dispregiato lo santo e terribile nome di Dio, e con la tua ingratitudine maladetta avere mostrata quanta abbondanza di vizj tu abbia. Io confesso me non essere donna di schiatta reale, ma essendo io dalla mia puerizia usata appresso le fanciulle del re, e le donne delle mogli, non è maraviglia ch’io abbia presi i loro costumi e animo; la qual cosa basta ad acquistare nobiltà reale. Ma perchè più parole? Io farò a te lievemente quello che tu con tutta tua forza ti sforzasti fare a me: negasti te essere mio marito; ma io volontariamente ti concedo che tu non sii mio marito, e benchè io abbia vinto te essere mio. La nobiltà reale sia tua, nondimeno bruttata d’infamia di falsità, sia tua la giovanile fortezza; tua sia la caduca bellezza, e io da qui innanzi sarò contenta della mia vedovità; e le ricchezze le quali Iddio mi ha prestate lascerò a più onesto erede, che a quegli che fossero generati da te. Partiti adunque, infelice giovane: e perchè tu hai fatta indegna cosa contro di me, impara alle tue spese con che arti, con inganni tu ti faccia beffe dell’altre femmine: a me basta ch’io sia ingannata da te una volta. Per la qual cosa io ho in animo non essere mai insieme con teco: ma molto penso che sia da tenere innanzi servare vita casta, che avere tuo matrimonio. E, dette queste parole, tolsesi di sua presenza; e dappoi non si potè nè con prieghi nè con ammaestramento rimuoverla da suo proposito. Ma Orlando confuso e tardi pentuto di sua viltà, ripreso da ogni uomo, con volto basso non solamente fuggendo la presenzia de’ frateglj, ma eziandio de’ popolari uomini, partissi con misera fortuna non ardiscendo domandare a ragione quella ch’egli avea rifiutata ad inganno. Il re e gli altri nobili del nobile animo di quella donna magnificarono quella con maravigliose lodi, incerti che cosa fusse più da lodare, o che Comiola contro all’avarizia delle femmine ricomperasse di tanta moneta, quel giovane, o che ella animosa dispregiasse e rifiutasse quello, ricomperato e convinto come indegno di lei.
CAPITOLO CIII.
Giovanna, reina di Ierusalem.
Giovanna, reina di Ierusalem e di Sicilia, oltre all’altre donne al nostro tempo, è famosa per nazione, per potenza e per costumi: della quale pareva odioso se avessi taciuto, e tacere di lei era meglio che scrivere indarno sì poco. Dunque questa fu la prima figliuola di Carlo, glorioso duca di Calabria, primogenito di Ruberto, di famosa memoria, re di Sicilia e di Ierusalem, e di Maria sorella di Filippo re di Francia; del cui padre e madre se noi vogliamo cercare gli avoli e bisavoli non cesseremo infino che per gli ascendenti re noi verremo a Dardano, primo autore d’Ilione, il padre del quale gli antichi dissero essere stato Giove. Della quale nobile schiatta tanti famosi principi sono discesi d’una e d’altra parte, che non è alcuno de’ re de’ Cristiani che non le sia parente e congiunto; e così niuna schiatta a nostri dì nè de’ nostri padri fu famosa più di nobiltà in tutto il mondo di questa. Eziandio dappoi essendo piccola fanciulla, essendo morto il padre giovane, non avendo suo padre erede maschio, avvenne di ragione, eziandio comandando egli così, che ella sopravvivendo diventasse erede del regno. E non fa la sua eredità oltre alla torrida zona, oltre i Sauromati sotto tramontana, dove è il ghiaccio, anzi fu tra ’l mare Adriatico e Tirreno, da Piceno e Umbria allo paese de’ Volschi, infino al mare di Sicilia, sotto temperata aria. Tra i quali confini obbediscono a sua signoria gli antichi Campagnuoli, i Lucani, i Bruzi, i Salentinj, i Calavresi, i Dauni, i Vestini, i Sanni, i Peligni, i Marsi e altri molti, acciò che io taccia i maggiori, come lo regno di Ierusalem, e l’isola di Sicilia, e la Gallia Cisalpina, lo terreno da piè de’ monti, le quali cose sono occupate per ingiuria degli occupatori. E così obbediscono quegli che abitono nella settima provincia tra la Gallia Narbonese, lo Rodano e le Alpi e il contado di Folchacherio ai suoi comandamenti, e confessano quella essere donna e reina. Oh quante famose cittadi sono in queste provincie, quanti maravigliosi castelli, quanti golfi di mare e quanti rifugj di nocchieri, quanti porti, quanti luoghi, quante fontane medicinali, quante selve, quanti boschi, quanti paschi, e dilettevoli e fruttiferi campi. Ancora quanti grandi popoli, quanti grandi baroni, e ancora come grandi ricchezze, ed abbondanza di tutte cose che aspettano alla vita! e certamente non sarebbe lieve esprimerlo. La quale essendo grandissima signoria e non usata a essere retta da donne, nondimeno dà ammirazione e nominanza, se noi guardiamo bene. E, che è molto più maraviglioso, a lei basta l’animo alla Signoria, che tanto chiara serva ancora la nobiltà de’ suoi passati. Perchè ella, poichè ella fu onorata della corona reale, drizzata . . . . . era suo sostegno, incominciò nuovo e mortale scisma; e da questo si conobbe la somma de’ mali di quella; perchè la cosa procede tanto innanzi, che, vivendo Urbano e non temendo siffatta cosa, fu eletto un altro Papa, come in veleno della fè cattolica. Al quale, mutata l’opinione, la detta reina cominciò a essere favorevole, o che la fortuna menasse quella ad esterminio, o ch’ella fusse tratta da perverse lusinghe de’ suoi. E per questo ogni cosa fu turbata e messa in confusione; per che lo detto Urbano, vero Papa, mosso per isdegno pronunziò scismatica anima della fè di Cristo e della chiesa la detta reina, la quale innanzi avea chiamata diletta figliuola, e finalmente la diffamò per pubblichi processi; e non cessò infino che la cacciò del regno; e chiamò d’Ungheria, di quella medesima schiatta reale, Carlo; giovane di gran vista e fama; intantochè prima la reina predetta non rifiutava avere quello per successore, e per augurio d’ogni uomo pareva dovere essere innanzi sostituito quello re. Dunque sforzandosi l’ardito re giovane acquistare l’eredità, e quella, forte per antica possessione, sforzandosi avere la sedia de’ suoi passati, con grande apparecchiamenti di ciascuna parte avevano posto in grandissimo pericolo l’opinione. Ma la fortuna alla quale pon si può dare resistenzia, secondo che dice Virgilio, conduce ogni cosa: quello che era meno possente rimase vincitore della guerra. Non era tra le parti alcuna varietà nota di gente, non d’arte di milizia, essendo dall’una Otto predetto, sommamente ammaestrato in fatti d’arme con espertissima compagnia degli antichi baroni del regno; dall’altra parte essendo il nuovo re quasi forestiero, intricato tra barberi, non esperto in signoria, e ignorante dei fatti d’Italia; non conosciuto dai signori del nostro paese e solamente aiutato dalla possanza del Re d’Ungheria, con questa venne a battaglia. Subito con una sconfitta entrato nel regno, contro l’opinione d’ogni uomo, sconfisse la gente de’ nemici, e pigliò l’antica città di Napoli, sedia del regno; ed assediò per mare e per terra la regina in uno castello, lo quale, secondo che si diceva, era inespugnabile. La quale in brieve tempo, vecchia e miserabile, s’arrendè, e venne in arbitrio del nuovo re, o che fusse costretta da necessità, o ch’essa per inganno de’ suoi fusse mal consigliata e confortata, o, secondo che si dice, tradita. Dispogliata d’ogni signoria e libertà fu messa in onesta prigione a Nocera sotto buona e fidata guardia, dove dopo alcuni mesi finì sua vita; ma come ella morisse n’è varia opinione. Alcuni dicono, e questa più famosa opinione è tenuta vera, ch’ella morì naturalmente come la maggior parte degli uomini, essendo costretta d’infermità, e forse perchè ella, non degna e non meritevole della sua infelice sorte, menossi al fine quasi come sdegnosa di vivere. Altri sparlando contro al re, come è d’usanza de’ rei, hanno avuto ardire dire ch’ella fu avvelenata; la quale opinione dee parere vana e falsa, s’io guardo alla benignità di quello re contro a tutti i vinti da lui. Alcuni altri, mossi da diletto di fare lo peccato più aspro, non hanno temuto di mormorare, ch’ella fu strangolata con uno laccio, benchè fosse senza la coscienza del re, e al postutto non sapendone egli alcuna cosa. Queste due ultime opinioni m’è piaciuto porre in questo luogo, non perchè sia da dubitare della prima per alcuno modo, ma perchè quegli che leggeranno sappiano che io le ripruovo come false e soperchie. Poichè ella fu morta, fu portata in luogo pubblico, dov’ella stette alla veduta d’ogni uomo, acciocchè niuno dubitasse dappoi ch’ella fusse viva: poi fu seppellita con reale onore d’ultima sepoltura; e fece manifesto che la vita umana è una favola; e che egli è vero quel detto del Poeta, che noi dobbiamo aspettare l’ultimo dì a lodare alcuno uomo; e che niuno si dee chiamare beato innanzi che muoia, e che sia seppellito. Laus Deo semper.

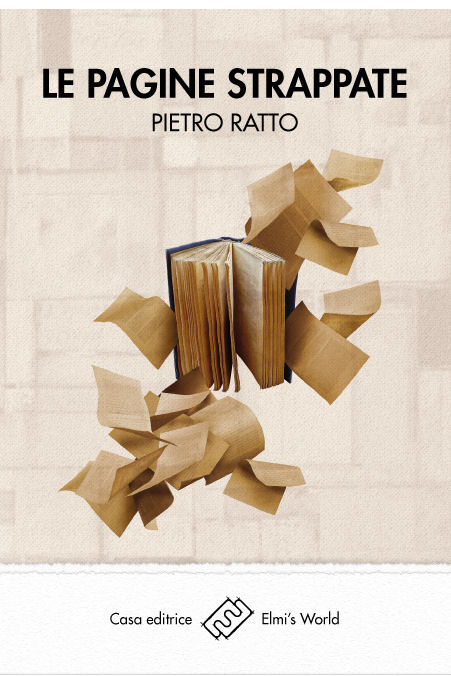 Così inizia l'avventura dell'autore Pietro Ratto alla ricerca della verità, la verità più scabrosa della Storia della Chiesa. Il viaggio nasce dall'idea di Pietro, filosofo, storico e professore, studiare la Storia diversamente da come si insegna a scuola andando a scrutare gli impervi sentieri della ricerca per arrivare alla scoperta di piccole grandi verità. Come un novello Dante, Pietro si fa accompagnare nel suo viaggio da uno studioso appassionato e misterioso a cui è difficile assegnare connotati fisici ma che chiama l'Erudito (paragonabile facilmente al sommo poeta Virgilio) il quale mette a disposizione del nostro Dante tutti gli strumenti per conoscere la verità sulla Papessa Giovanna che l'autore stesso inizialmente bolla come una leggenda. Pietro passa nottate insonni a leggere tutti i documenti "forniti" dall'Erudito, confronta date, grafici, testi, poi usa il suo intelletto cercando di scardinare le teorie classiche che fino ora hanno contornato la vicenda di Giovanna. Partendo da alcune osservazioni di Bartolomeo Sacchi e grazie all'Erudito, anche le convinzioni di Pietro iniziano a decadere sotto la scure delle fonti documentali che ha il privilegio di avere sulla sua scrivania. Cosa sconvolge Pietro? L'incredibile impegno di eminenti uomini di chiesa nel cancellare tutte le tracce di Giovanna che, durante la lotta tra cattolici e protestanti dopo il Concilio di Trento, ebbe un grande valore simbolico soprattutto per i protestanti che, cavalcarono l'onta per screditare Roma anche se in realtà avrebbero potuto denigrare la Chiesa Cattolica facendo leva su fatti ben più scabrosi. Ma chi era Giovanna? Pietro Ratto ce la descrive con precisione, sfruttando anche il De Claris Muljeribus di Boccaccio: era una donna di grande cultura e curiosità che però, in quanto donna, non poteva compiere studi. Proprio per questo decise di comportarsi e prendere le sembianze di uomo per frequentare le scuole migliori dei suoi tempi. Giovanna divenne anche abile medico e ottimo consigliere tanto che Papa Leone IV la volle prima come suo consigliere e poi come pontefice dopo la propria morte. L'elezione, secondo i metodi ben diversi da quelli che conosciamo oggi, altro non era che l'apice della carriera di Giovanna, diventare papa per una avida sete di conoscenza sfruttando anche la sua grande intelligenza. L'amore per un uomo e il figlio che cresceva nel ventre della donna, saranno causa di una scellerata fine quando nei pressi di San Giovanni, nella zona dove ora si può vedere il sacello di Giovanna, la verità si mostrò al mondo. Il papa era una donna! Il popolo adirato si riteneva colpito dal diavolo, altro che Saraceni contro i quali Leone fece costruire le mura della città! Durante la processione, Giovanna cadde a terra sofferente e partorì il frutto del suo amore proprio davanti ai fedeli che si scatenarono con una violenza inaudita contro la donna e suo figlio. Il diavolo si era infilato nelle alte sfere ecclesiastiche minandone la credibilità forse irreparabilmente. Perchè la Chiesa si è impegnata alacremente a cancellare le tracce di Giovanna? La chiesa non poteva permettere tale cecità anche per evitare delle accuse strumentali da parte delle nuove correnti religiose che negli anni post conciliari stavano prendendo piede pertanto furono moltissimi i rimaneggiamenti ai testi ufficiali che comportarono cambi di date, accorciamenti di periodi, ritocchi vari....tutte azioni che fanno credere, anche grazie alle precise testimonianze di Angelusio, Goffredo di Viterbo, Martino Polonio, Bernardo Guy, Petrarca, Boccaccio, Hus solo per citarne davvero alcuni, che la vicenda di Giovanna sia realmente da considerarsi un fatto storico. "Le pagine strappate" edito da Elmi's World è un saggio ma è anche un romanzo: è un libro che è una radiografia (per dirla come l'autore) del libro De vitis ac gestis Summorum Pontificum (1552) di cui l'Erudito ne possiede ben due copie, una del 1562 e l'altra del 1650 che sicuramente è stata censurata dal Concilio di Trento. Il ritmo incalzante del testo lo pone sicuramente tra i libri che ogni studioso, appassionato di storia e contro/storia deve avere nella propria libreria. E' altamente convincente, l'autore riesce quantomeno a dimostrare che la censura selvaggia della chiesa abbia davvero nascosto una presunta Papessa, pertanto può essere riduttivo bollare la storia incredibile della papessa Giovanna come una semplice bufala!
Così inizia l'avventura dell'autore Pietro Ratto alla ricerca della verità, la verità più scabrosa della Storia della Chiesa. Il viaggio nasce dall'idea di Pietro, filosofo, storico e professore, studiare la Storia diversamente da come si insegna a scuola andando a scrutare gli impervi sentieri della ricerca per arrivare alla scoperta di piccole grandi verità. Come un novello Dante, Pietro si fa accompagnare nel suo viaggio da uno studioso appassionato e misterioso a cui è difficile assegnare connotati fisici ma che chiama l'Erudito (paragonabile facilmente al sommo poeta Virgilio) il quale mette a disposizione del nostro Dante tutti gli strumenti per conoscere la verità sulla Papessa Giovanna che l'autore stesso inizialmente bolla come una leggenda. Pietro passa nottate insonni a leggere tutti i documenti "forniti" dall'Erudito, confronta date, grafici, testi, poi usa il suo intelletto cercando di scardinare le teorie classiche che fino ora hanno contornato la vicenda di Giovanna. Partendo da alcune osservazioni di Bartolomeo Sacchi e grazie all'Erudito, anche le convinzioni di Pietro iniziano a decadere sotto la scure delle fonti documentali che ha il privilegio di avere sulla sua scrivania. Cosa sconvolge Pietro? L'incredibile impegno di eminenti uomini di chiesa nel cancellare tutte le tracce di Giovanna che, durante la lotta tra cattolici e protestanti dopo il Concilio di Trento, ebbe un grande valore simbolico soprattutto per i protestanti che, cavalcarono l'onta per screditare Roma anche se in realtà avrebbero potuto denigrare la Chiesa Cattolica facendo leva su fatti ben più scabrosi. Ma chi era Giovanna? Pietro Ratto ce la descrive con precisione, sfruttando anche il De Claris Muljeribus di Boccaccio: era una donna di grande cultura e curiosità che però, in quanto donna, non poteva compiere studi. Proprio per questo decise di comportarsi e prendere le sembianze di uomo per frequentare le scuole migliori dei suoi tempi. Giovanna divenne anche abile medico e ottimo consigliere tanto che Papa Leone IV la volle prima come suo consigliere e poi come pontefice dopo la propria morte. L'elezione, secondo i metodi ben diversi da quelli che conosciamo oggi, altro non era che l'apice della carriera di Giovanna, diventare papa per una avida sete di conoscenza sfruttando anche la sua grande intelligenza. L'amore per un uomo e il figlio che cresceva nel ventre della donna, saranno causa di una scellerata fine quando nei pressi di San Giovanni, nella zona dove ora si può vedere il sacello di Giovanna, la verità si mostrò al mondo. Il papa era una donna! Il popolo adirato si riteneva colpito dal diavolo, altro che Saraceni contro i quali Leone fece costruire le mura della città! Durante la processione, Giovanna cadde a terra sofferente e partorì il frutto del suo amore proprio davanti ai fedeli che si scatenarono con una violenza inaudita contro la donna e suo figlio. Il diavolo si era infilato nelle alte sfere ecclesiastiche minandone la credibilità forse irreparabilmente. Perchè la Chiesa si è impegnata alacremente a cancellare le tracce di Giovanna? La chiesa non poteva permettere tale cecità anche per evitare delle accuse strumentali da parte delle nuove correnti religiose che negli anni post conciliari stavano prendendo piede pertanto furono moltissimi i rimaneggiamenti ai testi ufficiali che comportarono cambi di date, accorciamenti di periodi, ritocchi vari....tutte azioni che fanno credere, anche grazie alle precise testimonianze di Angelusio, Goffredo di Viterbo, Martino Polonio, Bernardo Guy, Petrarca, Boccaccio, Hus solo per citarne davvero alcuni, che la vicenda di Giovanna sia realmente da considerarsi un fatto storico. "Le pagine strappate" edito da Elmi's World è un saggio ma è anche un romanzo: è un libro che è una radiografia (per dirla come l'autore) del libro De vitis ac gestis Summorum Pontificum (1552) di cui l'Erudito ne possiede ben due copie, una del 1562 e l'altra del 1650 che sicuramente è stata censurata dal Concilio di Trento. Il ritmo incalzante del testo lo pone sicuramente tra i libri che ogni studioso, appassionato di storia e contro/storia deve avere nella propria libreria. E' altamente convincente, l'autore riesce quantomeno a dimostrare che la censura selvaggia della chiesa abbia davvero nascosto una presunta Papessa, pertanto può essere riduttivo bollare la storia incredibile della papessa Giovanna come una semplice bufala!




























