
Sito web di cultura medievale
Scopri la storia dei Templari con il Primo Museo Didattico Templare Permanente in Italia sito a Viterbo!
Se vuoi visitare Viterbo, l'Appartamento uso turistico di Emiliano e Rosita è il punto ideale per la tua vacanza!
Creati per difendere la Terrasanta a seguito della Prima Crociata i Cavalieri Templari destano ancora molto interesse: scopriamo insieme chi erano e come vivevano i Cavalieri del Tempio
I personaggi e i fatti più importanti del ciclo arturiano e della Tavola Rotonda
Personaggi, luoghi e fatti che hanno contribuito a conferire al Medioevo un alone di mistero che lo rende ancora più affascinante ed amato. Dal Ponte del Diavolo ai Cavalieri della Tavola Rotonda passando per Durlindana, la leggendaria spada di Orlando e i misteriosi draghi...


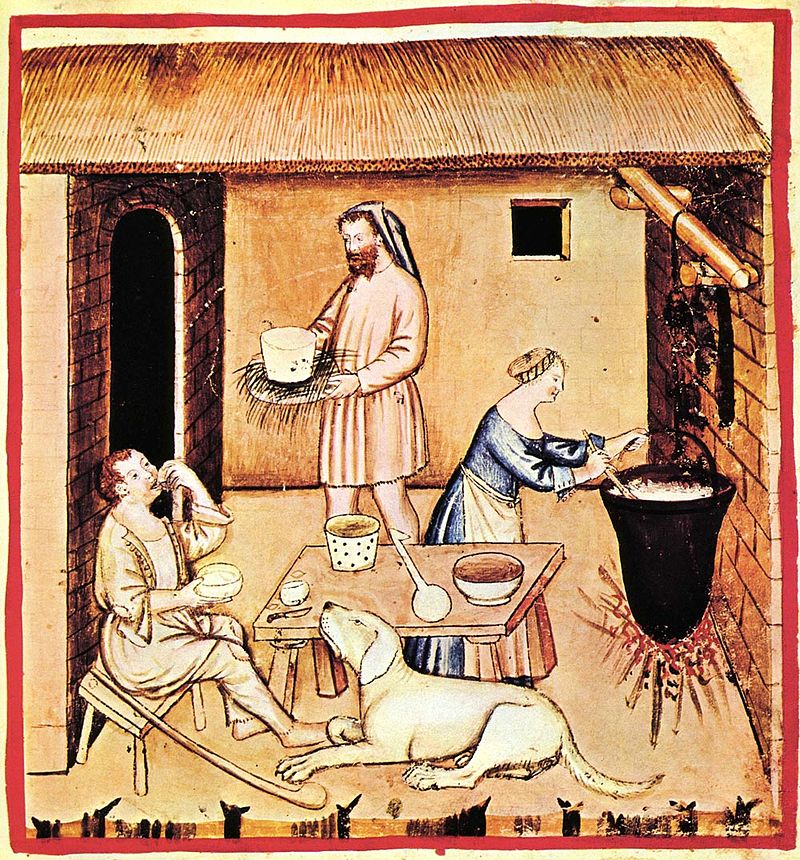






 Robert I Bruce fu re di Scozia del 1296 al 1329: di discendenza normanna è stato uno dei più grandi re e patrioti della Storia della Scozia conducendo il suo paese contro l'Inghilterra durante le guerre di indipendenza. Riposa nell'abbazia di Dunfermline mentre il suo cuore, su desiderio di Robert stesso, doveva essere portato nella Chiesa del Santo Sepolcro da alcuni cavalieri che si unirono poi ad una crociata. La leggenda vuole che uno dei cavalieri, un certo sir Douglas, portò il cuore in battaglia come fosse un talismano, in realtà fu riportato in Scozia nell'abbazia di Melrose.Nell'agosto dell'anno 1296 i Bruce giurarono fedeltà al re d'Inghilterra Edoardo I mediante il famoso patto a Berwick-upon-Tweed, patto che fu violato dallo stesso Robert che si unì ad una rivolta contro il sovrano. Il 7 luglio 1297 i Bruce furono costretti a firmare la Capitolazione di Irvine secondo cui i signori della Scozia potevano scegliere chi servire e sarebbero stati perdonati per la loro ribellione in caso di giuramento ad Edoardo e come garanzia Robert avrebbe dovuto consegnare sua figlia Marjiorie come ostaggio. Dopo la battaglia di Stirling Bridge, Bruce venne considerato un traditore, Annandale fu distrutta e successivamente la battaglia delle Falkirk sia Annandale che Carrick furono esclusi dall signoria e furono assegnate da Edoardo ai suoi seguaci. Dopo Falkirk William Wallace divenne Guardiano di Scozia e vi succedettero lo stesso Robert e Comyn. nel 1303 Edoardo attaccò nuovamente la Scozia arrivando ad Edimburgo e Perth. Comyn sapeva che avrebbe potuto ben poco contro l'esercito di Edoardo che intanto arrivò a Dundee, Montrose, Brechin ed Aberdee. La Scozia era praticamente sottomessa e tutti, tranne Wallace, si arresero ad Edoardo. L'11 giugno del 1304 Comyn e Robert strinsero un patto di collaborazione contro il nemico per proteggere gli scozzesi e per portarli all'indipendenza. La Scozia non aveva un esercito e Edoardo iniziò un processo di fusione con l'Inghilterra. Nel 1305 Edoardo affidò a Robert il Castello di Kildrummy unitamente a vasti possedimenti che ne faceva, praticamente, il padrone di tutta la Scozia facendolo mettere in cattiva luce con una parte della Comunità scozzese. Una forte opposizione a Bruce venne proprio da Comyn che aveva riunito attorno a sè altri nobili scozzesi per una strenua opposizione agli inglesi. Per evitare che l'opposizione interna avesse potuto minargli il potere, Bruce lo convocò a Dumfiers il 10 febbraio del 1306. La riunione era decisamente tesa, con Bruce che attaccò il suo compagno e lo fece uccidere da due suoi sostenitori prendendosi anche una scomunicata ritirata poi da Papa Giovanni XXII nel 1328. Bruce divenne re di Scozia con il nome di Roberto I a Scone il 25 marzo del 1306. L'avventura come re di Bruce no niniziò bene: fu sconfitto a Methven e a Strathfillan e fu costretto a fuggire a Rathlin dinanzi alla costa settentrionale dell'Irlanda. Sua moglie, sua figlia e sua nipote furono catturate mentre Niall, suo fratello, fu giustiziato. Per fortuna di Bruce Edoardo I morì il 7 luglio 1307 lasciando il trono a Edoardo II, ben lontano dalla preparazione politica e militare del padre. Bruce ed i suoi seguaci ritornarono in Scozia nel febbraio 1308 divisi in due gruppi: uno, condotto da Robert e da suo fratello Edward che si stanziarono nel castello di Turnberry dal quale organizzarono una guerriglia contro gli inglesi nel sud-ovest della Scozia; l'altro, condotto dai suoi fratelli Thomas ed Alexander che si stanziarono a po' più a sud nel Loch Ryan; ma ben presto i due fratelli vennero catturati e giustiziati. In aprile Bruce ottenne una discreta vittoria contro gli inglesi nella Battaglia di Glen Trool prima di sconfiggere Aymer de Valence e il conte di Pembroke nella Battaglia di Loudoun Hill. Lasciando suo fratello Edward a capo della regione di Galloway, si diresse verso nord e conquistò i castelli di Urquhart e di Inverlochy, dando fuoco al castello di Inverness e radendo al suolo quello di Nairn, e minacciando infine, senza successo Elgin. Trasferite le operazioni nell'Aberdeenshire verso la fine del 1307, attaccò Banff ma venne colto da una malattia piuttosto seria, che probabilmente fu la causa delle difficoltà della lunga campagna. Ristabilitosi, Bruce sottomise John Comyn, terzo conte di Buchan, e proseguì verso ovest dove conquistò i castelli di Balvenie e di Duffus, e dell' allora castello di Tarradale sulla Black Isle. Tornò indietro nel tentativo di riprendere Elgin, ma fallì nuovamente, infine sconfisse nuovamente Comyn nella Battaglia di Inverurie nel maggio 1308, quindi conquistò Buchan e massacrò la guarnigione inglese ad Aberdeen. Infine penetrò nella regione di Argyll e sconfisse i suoi nemici nella Battaglia di Pass of Brander prendendo il castello di Dunstaffnage, l'ultima fortezza di Comyn. Nel marzo del 1309, riunì il suo primo Parlamento a Saint Andrews ed entro agosto dello stesso anno controllava tutto il nord della Scozia. Il seguente anno, il clero scozzese, durante un consiglio generale, riconobbe Bruce come re di Scozia. Il supporto concesso dalla chiesa nonostante la scomunica era, per Bruce, di grande importanza politica. I tre anni successivi videro la conquista di un castello e di un avamposto inglese dopo un altro: Linlithgow nel 1310, Dumbarton nel 1311 e Perth. Nella sua sete di conquista, Bruce fece incursioni nel nord dell'Inghilterra e si stanziò a Ramsey nell'Isola di Man, dove assediò il Castello di Rushen a Castletown conquistandolo il 21 giugno 1313, con il chiaro intento di strappare agli inglesi un'importante postazione strategica, quale era l'isola di Man. Nella primavera del 1314, il fratello, Edward Bruce assediò il castello di Stirling, il cui governatore, era Sir Philip de Mowbray. Intanto nel marzo del 1314 sir James Douglas catturò Roxburgh e Randolph conquistando il Castello di Edimburgo. A maggio del 1314 Bruce invase e sottomise l'Isola di Man, per poi assicurare militarmente l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra con la storica Battaglia di Bannockburn.
Robert I Bruce fu re di Scozia del 1296 al 1329: di discendenza normanna è stato uno dei più grandi re e patrioti della Storia della Scozia conducendo il suo paese contro l'Inghilterra durante le guerre di indipendenza. Riposa nell'abbazia di Dunfermline mentre il suo cuore, su desiderio di Robert stesso, doveva essere portato nella Chiesa del Santo Sepolcro da alcuni cavalieri che si unirono poi ad una crociata. La leggenda vuole che uno dei cavalieri, un certo sir Douglas, portò il cuore in battaglia come fosse un talismano, in realtà fu riportato in Scozia nell'abbazia di Melrose.Nell'agosto dell'anno 1296 i Bruce giurarono fedeltà al re d'Inghilterra Edoardo I mediante il famoso patto a Berwick-upon-Tweed, patto che fu violato dallo stesso Robert che si unì ad una rivolta contro il sovrano. Il 7 luglio 1297 i Bruce furono costretti a firmare la Capitolazione di Irvine secondo cui i signori della Scozia potevano scegliere chi servire e sarebbero stati perdonati per la loro ribellione in caso di giuramento ad Edoardo e come garanzia Robert avrebbe dovuto consegnare sua figlia Marjiorie come ostaggio. Dopo la battaglia di Stirling Bridge, Bruce venne considerato un traditore, Annandale fu distrutta e successivamente la battaglia delle Falkirk sia Annandale che Carrick furono esclusi dall signoria e furono assegnate da Edoardo ai suoi seguaci. Dopo Falkirk William Wallace divenne Guardiano di Scozia e vi succedettero lo stesso Robert e Comyn. nel 1303 Edoardo attaccò nuovamente la Scozia arrivando ad Edimburgo e Perth. Comyn sapeva che avrebbe potuto ben poco contro l'esercito di Edoardo che intanto arrivò a Dundee, Montrose, Brechin ed Aberdee. La Scozia era praticamente sottomessa e tutti, tranne Wallace, si arresero ad Edoardo. L'11 giugno del 1304 Comyn e Robert strinsero un patto di collaborazione contro il nemico per proteggere gli scozzesi e per portarli all'indipendenza. La Scozia non aveva un esercito e Edoardo iniziò un processo di fusione con l'Inghilterra. Nel 1305 Edoardo affidò a Robert il Castello di Kildrummy unitamente a vasti possedimenti che ne faceva, praticamente, il padrone di tutta la Scozia facendolo mettere in cattiva luce con una parte della Comunità scozzese. Una forte opposizione a Bruce venne proprio da Comyn che aveva riunito attorno a sè altri nobili scozzesi per una strenua opposizione agli inglesi. Per evitare che l'opposizione interna avesse potuto minargli il potere, Bruce lo convocò a Dumfiers il 10 febbraio del 1306. La riunione era decisamente tesa, con Bruce che attaccò il suo compagno e lo fece uccidere da due suoi sostenitori prendendosi anche una scomunicata ritirata poi da Papa Giovanni XXII nel 1328. Bruce divenne re di Scozia con il nome di Roberto I a Scone il 25 marzo del 1306. L'avventura come re di Bruce no niniziò bene: fu sconfitto a Methven e a Strathfillan e fu costretto a fuggire a Rathlin dinanzi alla costa settentrionale dell'Irlanda. Sua moglie, sua figlia e sua nipote furono catturate mentre Niall, suo fratello, fu giustiziato. Per fortuna di Bruce Edoardo I morì il 7 luglio 1307 lasciando il trono a Edoardo II, ben lontano dalla preparazione politica e militare del padre. Bruce ed i suoi seguaci ritornarono in Scozia nel febbraio 1308 divisi in due gruppi: uno, condotto da Robert e da suo fratello Edward che si stanziarono nel castello di Turnberry dal quale organizzarono una guerriglia contro gli inglesi nel sud-ovest della Scozia; l'altro, condotto dai suoi fratelli Thomas ed Alexander che si stanziarono a po' più a sud nel Loch Ryan; ma ben presto i due fratelli vennero catturati e giustiziati. In aprile Bruce ottenne una discreta vittoria contro gli inglesi nella Battaglia di Glen Trool prima di sconfiggere Aymer de Valence e il conte di Pembroke nella Battaglia di Loudoun Hill. Lasciando suo fratello Edward a capo della regione di Galloway, si diresse verso nord e conquistò i castelli di Urquhart e di Inverlochy, dando fuoco al castello di Inverness e radendo al suolo quello di Nairn, e minacciando infine, senza successo Elgin. Trasferite le operazioni nell'Aberdeenshire verso la fine del 1307, attaccò Banff ma venne colto da una malattia piuttosto seria, che probabilmente fu la causa delle difficoltà della lunga campagna. Ristabilitosi, Bruce sottomise John Comyn, terzo conte di Buchan, e proseguì verso ovest dove conquistò i castelli di Balvenie e di Duffus, e dell' allora castello di Tarradale sulla Black Isle. Tornò indietro nel tentativo di riprendere Elgin, ma fallì nuovamente, infine sconfisse nuovamente Comyn nella Battaglia di Inverurie nel maggio 1308, quindi conquistò Buchan e massacrò la guarnigione inglese ad Aberdeen. Infine penetrò nella regione di Argyll e sconfisse i suoi nemici nella Battaglia di Pass of Brander prendendo il castello di Dunstaffnage, l'ultima fortezza di Comyn. Nel marzo del 1309, riunì il suo primo Parlamento a Saint Andrews ed entro agosto dello stesso anno controllava tutto il nord della Scozia. Il seguente anno, il clero scozzese, durante un consiglio generale, riconobbe Bruce come re di Scozia. Il supporto concesso dalla chiesa nonostante la scomunica era, per Bruce, di grande importanza politica. I tre anni successivi videro la conquista di un castello e di un avamposto inglese dopo un altro: Linlithgow nel 1310, Dumbarton nel 1311 e Perth. Nella sua sete di conquista, Bruce fece incursioni nel nord dell'Inghilterra e si stanziò a Ramsey nell'Isola di Man, dove assediò il Castello di Rushen a Castletown conquistandolo il 21 giugno 1313, con il chiaro intento di strappare agli inglesi un'importante postazione strategica, quale era l'isola di Man. Nella primavera del 1314, il fratello, Edward Bruce assediò il castello di Stirling, il cui governatore, era Sir Philip de Mowbray. Intanto nel marzo del 1314 sir James Douglas catturò Roxburgh e Randolph conquistando il Castello di Edimburgo. A maggio del 1314 Bruce invase e sottomise l'Isola di Man, per poi assicurare militarmente l'indipendenza della Scozia dall'Inghilterra con la storica Battaglia di Bannockburn.A partire da sabato 7 settembre, lo staff di Tesori d’ Etruria è pronto ad accogliere e trasportare i visitatori nel mondo dei Cavalieri...
