Il nome e il cognome rientrano tra i segni di riconoscibilità e di identità della persona sia come individuo che come membro del gruppo più ampio della cerchia famigliare. Il sigillo e lo stemma adempiono anch' essi al fine di riconoscibilità e, in quanto riferibili al soggetto possessore, fanno parte di una sorta d’identità che viene dispiegata per autenticare documenti e firme e, nel caso del sigillo, a garantire l’inviolabilità del contenuto di documenti da tenere segreti o a garantire i contenitori che vanno protetti per ciò che custodiscono. Altro discorso per lo stemma che è riconoscibilità ed identità del singolo e nel contempo è simbolo di appartenenza ad una determinata ed identificata Famiglia: il Casato. Lo stemma è assimilabile come riconoscibilità al cognome.
Tali segni distintivi non hanno avuto, nel tempo, sempre la stessa valenza e la loro struttura e funzione non è stata così come la conosciamo e pratichiamo al nostro tempo cioè Generalizzata e Regolamentata. Il periodo che ritengo sia stato importante per lo sviluppo e l’evoluzione del nome, del cognome e degli altri segni di identità è quello a cavallo tra l’XI e XII secolo. Con ciò non voglio asserire che prima, di tale epoca, vi erano individui privi del nome proprio di persona o che era completamente inesistente una sorta di cognome. Esisteva una sorta di identificazione basata sull’appartenenza o sulla soggezione ad una Famiglia potente, ricca ed influente basti ricordare la ” GENS” istituzione caratteristica del mondo romano. Stesso discorso per i sigilli che già esistevano fin da epoca remota. Diversa è invece la questione intorno alla nascita e allo sviluppo degli stemmi. La loro rigida regolamentazione (ARALDICA) pone il periodo iniziale proprio a cavallo tra l’XI e il XII secolo e continuerà, con le stesse regole, fino alla nostra epoca.
Il periodo indicato, XI e XII secolo, rappresenta una sorta di rinascita dell’individuo dopo il terrore ancestrale di concludere la propria esistenza e quella del genere umano con lo scoccare dell’anno mille. Ogni millennio, per l’uomo, è fonte di ansia e preoccupazione, suona sempre sinistro il monito : “Mille e non più Mille”. Anche di recente, l’uomo moderno ha predisposto eccezionali misure di sicurezza e di prevenzione per la custodia dei dati elettronici e di allerta per, eventuali, interventi di necessità generici e non bene identificati, ma tutti riconducibili allo scoccare dell’anno 2000.
Durante i primi secoli del secondo millennio si assiste ad un rinnovato potere temporale della Chiesa, che sovrasta tutte le terre e nazioni dell’epoca. Potere che si estrinseca nell’ordinare a re e monarchi di armarsi e di intraprendere costose guerre, in terre lontane, per liberare Gerusalemme il Luogo Santo della Cristianità. Solo chi fosse stato dotato di grande potere e prestigio avrebbe potuto chiedere a condottieri, a cavalieri e soldati di partecipare alle crociate: un potere notevole che andava ben oltre l’ossequio per l’autorità spirituale.
Questo nuovo fermento associato allo sviluppo economico e sociale crea nuove necessità e nuove aspirazioni. Infatti, sorgono regimi feudali in località dove fino ad allora erano sconosciuti (Meridione) mentre cominciano a sorgere e formarsi movimenti e aspirazioni finalizzati a liberarsi dal giogo feudale e a dare vita a nuove forme di amministrazione come le città comunali in contrapposizione all'autorità feudale e regia. (Settentrione).
La Chiesa si riprende ed accentua il controllo di tutte le attività quotidiane del popolo, si libera da quella sorta di soggezione in cui era caduta in concomitanza alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente sopraffatto da orde di popoli pagani.
Ma come si è modificato il nome, come è sorto il cognome che evolverà, nei secoli, fino alla struttura da noi conosciuta e praticata ? E il sigillo come atto di autenticazione e probatorio, che fa sorgere un embrione di diritto all’immagine quando reca incisa l’immagine, l’ effige ? Come nasce e si sviluppa lo stemma, un altro segno di identità, che sarà caratterizzante per tutta l’epopea cavalleresca e delle relative norme araldiche che hanno mantenuto la loro validità fino ai giorni nostri ?
NOME PROPRIO
In qualsiasi vocabolario il lemma “nome” è distinto in comune e proprio, dove il “proprio” può essere di luogo, di popolo, di persona. Il nome proprio di persona è quello per intenderci dell’onomastico che caratterizza la discendenza Famigliare. Come è noto, accanto alla trasmissione del nome in linea paterna vi è anche quella in linea materna. La trasmissione del nome avveniva, uso il passato perché in tempi recenti è invalso l’uso di “imporre” ai figli anche nomi estranei alla cerchia famigliare (casato), con una sequenza mista: i figli ricevevano i nomi dalla famiglia del padre e della madre, in maniera alternativa secondo l’ordine di nascita.
Nell’XI secolo, la Chiesa ha cominciato ad esercitare un controllo più stretto del “nome di battesimo” per poter meglio individuare i gradi di parentela che avrebbero ostato alla celebrazione dei matrimoni tra consanguinei. Spesso il “nome di battesimo” era imposto per strategie matrimoniali e per una convenienza simbolica per future eredità. Infatti, nella trasmissione ereditaria si comprendeva oltre al patrimonio materiale anche tutta una serie di diritti , e il “nome” poteva essere di grande aiuto nel caso di impugnazioni di atti e di contestazioni di eredità. Inoltre, era di grande valenza e prestigio portare il “nome” degli avi più illustri.
Era consentito aggiungere al primo “nome di battesimo” altri nomi, alcuni ispirati da opere letterarie (Lancillotto, Tristano, Parsifal) altri per il richiamo di personaggi illustri (attori, scrittori, musicisti, politici, dittatori).
Dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476) e fino all’anno mille,(Alto Medioevo) si comincia a perdere progressivamente l’uso dei TRIA NOMINA dei Latini costituiti da nome, patronimico (cognome), nome dell’antenato o il soprannome. Il nome Latino diviene sempre più raro e non viene più trasmesso nemmeno tra gli appartenenti alla antica e nobile casta dei discendenti dei Senatori Romani. Si afferma così un’influenza sempre più ampia dell’adozione di nomi di origine germanica. Questi nomi erano definiti “nomi programmi” perché contenevano parole che richiamavano la memoria degli avi, le virtù desiderate e la protezione degli dei. (esempio Federico = Fried / pace - Reich / re). La diffusione di tali nomi germanici comincia ad attenuarsi fino a scomparire, per l’azione della Chiesa che osteggia i nomi di origine pagana.
È proprio nel corso dell’XI secolo che si assiste alla notevole riduzione dei nomi di origine germanica a tutto vantaggio di quelli associati al culto dei Santi (onomastico) e ai nomi dei personaggi della Bibbia. Questi nuovi nomi si diffondono con numerose varianti locali e anche con diminutivi. Il nome Nicola origina altri nomi e persino cognomi: Cola, Coletta, Klaus, Nicolet, Colin… quello femminile di Elisabetta si diffonde con le varianti di Elisa, Isabella, Eloisa, Lisa, Lisetta… Una notevole diffusione si registra per il nome Giovanni, imposto in memoria sia del Santo che battezzò Gesù Cristo che dell’Evangelista, che originò anche numerose varianti.
COGNOME
Le nuove esigenze, sia di ordine amministrativo che fiscale, inducono a ricercare un nuovo segno di identità stabile ricollegabile direttamente alla famiglia di appartenenza. Il cognome, quindi, sorge e diviene una sorta di “nome più ampio” ricomprendente più persone della medesima Famiglia, del Casato. Il Cognominare, come atto di designare mediante l’attribuzione di cognome caratterizza il periodo intorno alla fine del 1100. Inizialmente, il cognome consiste nell'adottare il nome del luogo del feudo per i nobili laici, la denominazione della comunità o del luogo dove vi è l’istituzione ecclesiastica per i religiosi. L’attribuzione, l’uso e la diffusione del cognome riguarda tutta la società del tempo e include pure le donne e ha carattere ereditario. Tale struttura è l’origine del nostro attuale sistema che pone di seguito al nome proprio personale il nome di Famiglia (cognome).
Si sono fatte svariate ipotesi sulla nascita e l’affermarsi del cognome, riconducendolo a motivi di radicamento dell’aristocrazia terriera, alla crescita demografica, sia nelle campagne che nelle città, alla maggiore mobilità della popolazione dovuta all'espansione e allo sviluppo economico del XII e XIII secolo. Un ruolo importante si ritiene che l’abbia svolto un’ evoluzione dei costumi, della mentalità e la percezione nuova della persona-individuo. Diverse e svariate sono le tipologie di cognomi, con riferimento ai luoghi di provenienza o di origine territoriale sono quelli di Calabrese/i, Campano, Pugliese/i, Siciliano/i, Toscano/i. Altri cognomi non sono altro che il nome del padre o della madre abbiamo così: Di Giovanni, Di Leo, De Titta, Di Girolamo.
I soprannomi hanno rappresentato una fonte quasi inesauribile di cognomi. Connotando pregi e difetti, fisici o morali, hanno portato alla formazione dei cognomi: Moro, Belli, Brutto, Piccolo/i, Sordi, Zoppo/i, Malfatti, Boni, Degli Esposti, Esposito, Rosso/i. Non vengono ignorati nella nascita dei cognomi l’esercizio di arti, professioni e mestieri così: Ferraro, Ferrero, Ferrara, Fabbri, Sacchi, Sarti (Schneider), Vaccaro/i (Vacheron), Molinaro/i, Calzolaro (Shumacher), Medici, Martelli.
Il cognome si afferma inizialmente presso le classi feudali aristocratiche. Il processo di sviluppo e diffusione agli altri ceti sociali è stato lento e progressivo raggiungendo solo nel corso del XV secolo una generalizzazione e regolamentazione molto simile a quella attualmente in uso.
MARCHIO - SCRITTURA E FIRMA
Come abbiamo accennato esistono altri segni di identità che sono conseguenza diretta e naturale della formazione del nome e del cognome in capo ad un individuo. Così nella nostra epoca, se associamo un nome, un cognome, un luogo e una data di nascita ricaviamo un codice che serve ad identificarci e a renderci riconoscibili ovunque e per svariate e diverse finalità.(Codice Fiscale)
Nei secoli passati era, invece, l’iscrizione del proprio nome e cognome che serviva per così dire a “marchiare” ogni tipo di oggetto. Si “marchiava”un oggetto per formulare un voto, per ringraziare per grazia ricevuta (ex voto), per memoria perpetua di un fondatore, di un donante, di un defunto si “marchiavano” monumenti e lapidi. Il “marchio” consisteva nel nome e cognome per esteso o anche in forma abbreviata o addirittura ridotto ad un monogramma o alle semplici lettere iniziali del nome e del cognome.
Tra i segni più personali spicca la scrittura e anche in questo caso il nome serve ad autenticare il contenuto e il significato che ne traspare. Nasce così la firma autografa, che diviene un segno di identità che rinforza lo scritto e aumenta l’efficacia e l’effetto probatorio.
Alcune firme del passato vengono apposte con un semplice segno di croce, ma tale grafo non sempre e non necessariamente rappresenta la firma di una persona analfabeta. Spesso questo segno di croce assume, al pari del gesto di segnarsi, una forte valenza simbolica di fronte a Dio e agli uomini. (Si veda la firma di Carlo Magno). La firma per esteso e autografa diviene un nuovo segno personale di identità e la sua pratica si diffonde progressivamente in tutte le classi sociali, infine viene recepita, riconosciuta e tutelata dal Codice Civile.
SIGILLO
Con lo sviluppo economico e il crescente numero di atti e documenti, si fa più pressante la necessità di avere uno strumento idoneo ad autenticare la firma dei contraenti e a cristallizzarne il contenuto, si individua così nel sigillo tale caratteristica. Così per garantire, autenticare il contenuto e/o il segreto di missive, di testamenti o di contenitori era uso apporre il sigillo. Tale oggetto è uno strumento, di metallo o di pietra dura, che reca inciso un simbolo, uno stemma, delle iniziali o delle figure-immagini, che impresso su cera fusa lascia un’impronta in rilievo.
Molto usato fin dall'antichità, a Roma veniva utilizzato sotto forma di anello “sigillare”. Prosegue l’uso dell’anello sigillare anche nell'Alto Medioevo per autentica di diplomi di origine reale. Nel corso dell’XI secolo l’uso viene esteso anche in ambito episcopale e presso i principi. Nel XII e XIII secolo, diviene di uso normale e generalizzato da parte dei notai che se ne servono per validare gli atti giuridici. La forma dell’impronta in genere rotonda o ogivale (a navetta) era impressa nella cera fusa mescolata con resine colorate. L’impronta, in un primo tempo, era apposta in calce alle carte, ma a partire dal XII secolo tali impronte vengono appese ai documenti per il tramite di matassine di seta, di lino o di canapa, con strisce di cuoio o di pergamena.
Onde evitare l’uso fraudolento dell’impronta in cera che poteva essere staccata, dal documento, ed utilizzata per autenticare un altro atto con altro contenuto e quindi un atto falso, si apponeva un controsigillo sul retro della cera, già impressa, creando una seconda impronta. La funzione del sigillo è di identificare pubblicamente il suo possessore (il sigillante) che apponendolo valida i contenuti dell’atto comprese le firme.
La diffusione dell’uso dei sigilli porta alla configurazione del “diritto di immagine” che non ha avuto eguali fino all’invenzione della fotografia. La sfragistica è la scienza che studia i sigilli dal punto di vista tecnico, artistico e storico. Il repertorio degli emblemi dei sigilli è ricchissimo e rappresenta, per quantità e qualità, una fonte importante per lo studio della storia, dell’economia, del diritto, delle istituzioni, del progresso della mentalità, del costume e dello sviluppo materiale e sociale di una comunità.
Altro importante aspetto è che essendo immagine e rappresentazione in effige, il sigillo è anche un’opera d’arte sia come strumento inciso che come impronta lasciata. Ne derivano informazioni, facilmente databili, sul modo di vestire, sul tipo di armature, elmi e scudi dei cavalieri,sull’uso di abiti liturgici, per gli ecclesiastici, e non meno importante la moda e le acconciature delle dame.
STEMMI (Araldica)
Nel XII secolo, come accennato, appaiono gli stemmi che vengono catalogati in un codice sociale aperto, ma rigoroso. Il fatto caratterizzante è proprio l’esistenza di tali regole che formano il sistema araldico e differenziano gli stemmi da altri emblemi anteriori sia militari che civili. Presso le varie culture esistono segni che servono ad indicare l’identità dei singoli e dei gruppi, a far conoscere il loro valore e la posizione che occupano nella gerarchia della comunità. Questi segni si palesano attraverso formule proprie e utilizzano supporti di qualsiasi natura e materiale.
Si formulano numerose ipotesi circa l’origine degli stemmi. Alcune appaiono proprio fantasiose come quelle che farebbero risalire gli stemmi ad Adamo, a Giulio Cesare o a re Artù. Tra le ipotesi che hanno avuto un buon seguito e una lunga durata menzioniamo quella che vorrebbe l’origine degli stemmi in oriente e quindi l’assimilazione, durante la prima crociata, di una cultura musulmana per alcuni, bizantina per altri. Anche questa ipotesi è stata respinta dagli studiosi che si sono dichiarati per ipotesi che tengano conto della trasformazione della società medioevale dopo l’anno mille, dell’evoluzione degli equipaggiamenti militari tra la fine dellXI secolo e i primi decenni del XII.
Anche l’ipotesi dell’origine derivante dall'evoluzione dell’equipaggiamento militare non è idonea a fornire una spiegazione pienamente valida ed accettata. In effetti la comparsa degli stemmi si può collegare più direttamente al nuovo ordine sociale che si andava formando e che interessava tutta la società occidentale in epoca feudale. Nella stessa epoca, XI e XII secolo, nascono i nomi patronimici e gli attributi iconografici, che si concretizzano in immagini. L’araldica, dal canto suo, contiene questi “segni di identità nuove”, di una società in corso di riorganizzazione. Gli individui si collocano in nuovi gruppi e questi gruppi costituiscono il nuovo sistema sociale.
Per tale motivo gli stemmi che inizialmente rappresentano un emblema individuale, si estendono poi alla cerchia della parentela Familiare. Dalla fine del XII secolo lo stemma diviene, nell'ambito della Famiglia, ereditario. La regola di trasmissione dello stemma prevede che all'interno di una famiglia (casato) un solo individuo abbia il diritto di portare lo stemma nella sua interezza ed originalità, è il primogenito in linea di primogenitura. Agli altri membri della famiglia (fratelli, figli e nipoti) è consentito l’uso dello stemma, ma con modifiche che indichino chiaramente che non sono loro il “capo d’arme” cioè il primogenito della linea di primogenitura.
Senza inoltrarci oltre in argomenti che caratterizzano gli stemmi e che richiederebbero copiose descrizioni di segni, simboli, scudi, colori, corone, elmi … è sufficiente aver dato il concetto di stemma come il complesso delle figure che costituiscono il contrassegno stabile e riconosciuto di persone e famiglie (casato).Il filo logico che ha legato il nome, il cognome, il sigillo e lo stemma sorge e si sviluppa nel corso dell’XI e XII secolo e per certi versi continua il suo cammino attraversando anche il XXI secolo.
Articolo del Cav. Avv. Antonio Fotia 27 maggio 2016







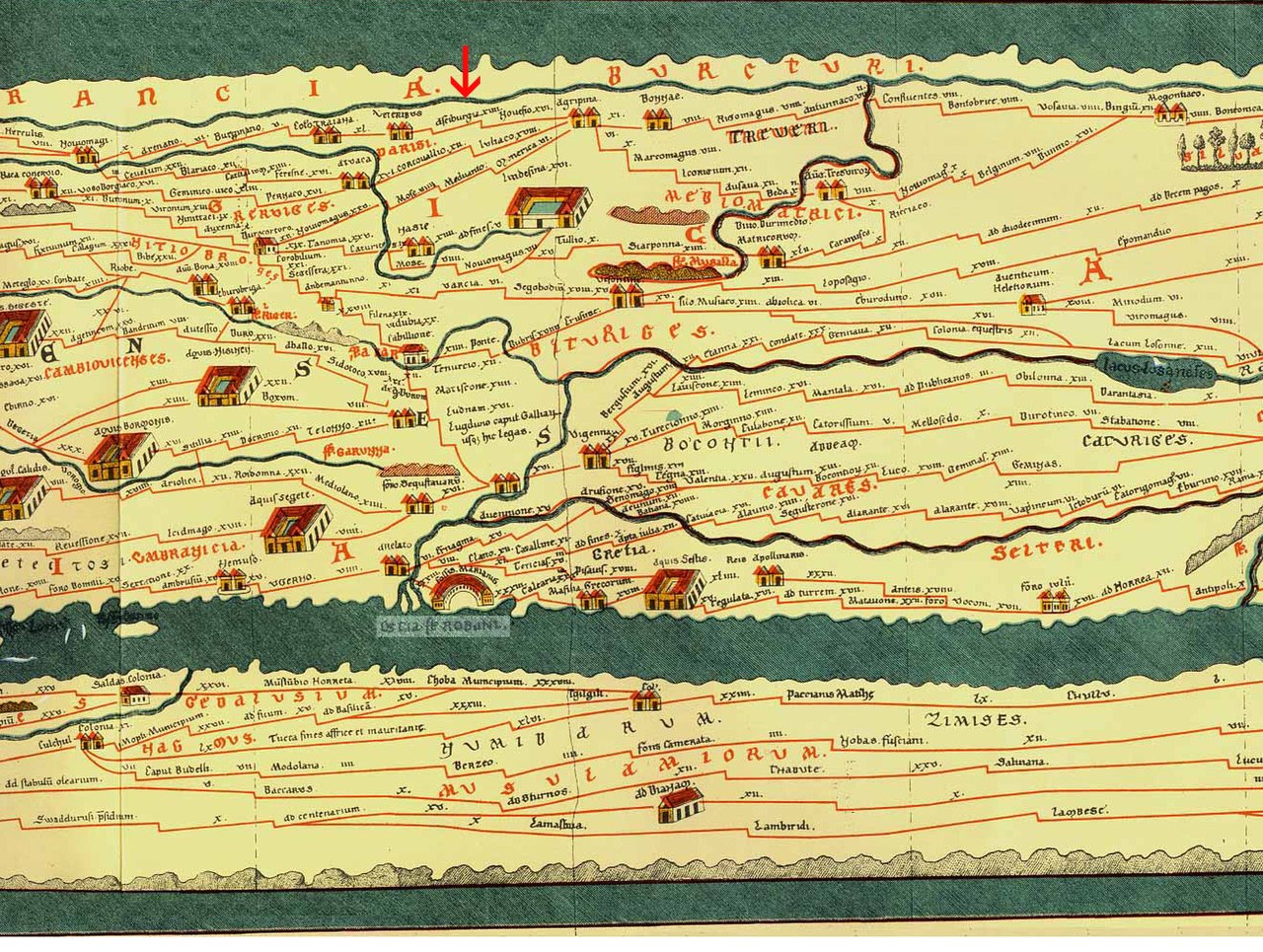

.jpg)

