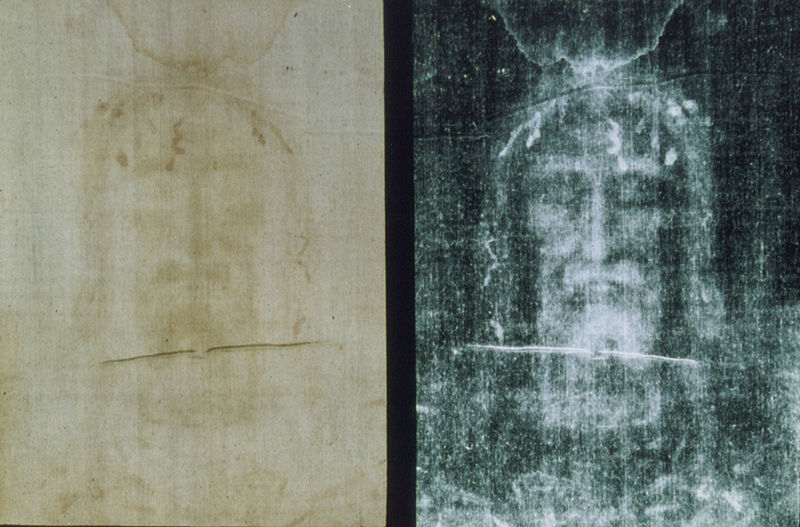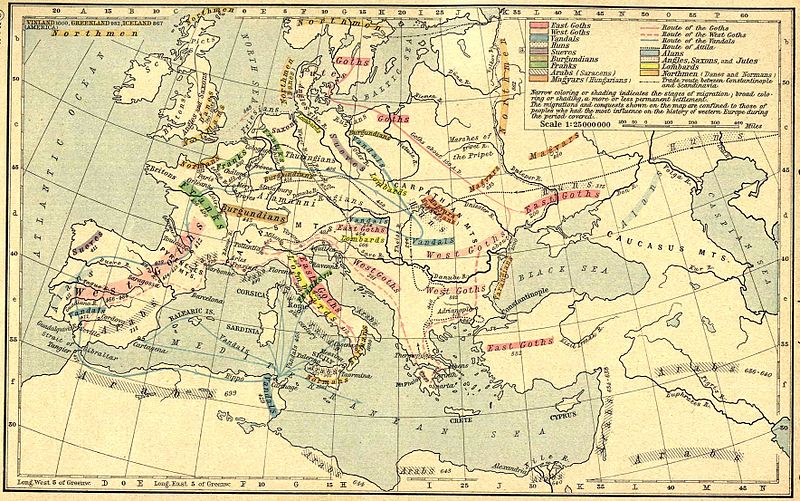Rompo momentaneamente il silenzio-protesta solo per condividere con voi il celeberrimo CRIMEN SOLLICITATIONIS firmato da San Giovanni XXIII e documento cardine dell'insabbiamento dei preti pedofili di Giovanni Paolo II
PRELIMINARI
1.Il reato di molestia si ha quando un sacerdote o nell’atto del sacramento della confessione; o prima o immediatamente dopo la confessione; o in occasione o con il pretesto della confessione; o anche al di fuori dell’occasione della confessione nel confessionale o in altro luogo destinato ad ascoltare le confessioni o scelto con il pretesto di ascoltare la confessione proprio in quel luogo, abbia, tentato di incitare o invitare un penitente - qualsiasi persona sia - a comportamenti disonesti e vergognosi sia con parole, sia con segni, sia con cenni, sia con contatto fisico o attraverso la scrittura da leggere al momento o in seguito o abbia tenuto con lui discorsi o pratiche illecite e disoneste con audacia sconsiderata (Const. Sacramentum Poenitentiae, §1).
2. Informarsi su questo orribile reato spetta in prima istanza agli Ordinari dei luoghi nel territorio dei quali l’accusato ha la residenza (V. più avanti nn. 30 e 31), e ciò non solo per proprio diritto, ma anche per speciale delega della Sede Apostolica; e si ordina assolutamente a loro, essendo gravemente obbligata la loro coscienza, che da ora innanzi curino di introdurre, discutere e concludere quanto prima le cause di questo tipo davanti al proprio tribunale. Tuttavia, per particolari e gravi ragioni anche queste cause, a norma Can. 247, §2, possono essere direttamente deferite alla S. Congregazione del S. Uffizio o possono essere avocate a se stessa dalla stessa S. Congregazione. Anzi, anche agli stessi accusati convenuti in giudizio spetta integro il diritto di ricorrere al S. Uffizio; ma il ricorso così intervenuto non sospende, escluso il caso di appello, l’esercizio di giurisdizione nel giudice che comincia già a conoscere la causa; ed egli perciò potrà proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, se non avrà constatato che la Sede Apostolica ha avocato a sé la causa (cfr. Can. 1589).
3. Con il nome di Ordinari dei luoghi qui si intendono, ciascuno in rapporto al proprio territorio, il Vescovo residenziale, l’Abate o il prelato nullius (cioè con territorio e popolo separati ed esenti) l’Amministratore, il Vicario e il Prefetto Apostolico e coloro che, mancando i predetti, hanno la successione nel frattempo secondo quanto prescritto nel diritto o secondo decreti approvati (Can. 1589); non tuttavia il Vicario Generale, se non per speciale delega.
4. L’Ordinario dei luoghi in queste cause è giudice al posto dei “Regolari” sebbene esentati; infatti ai loro Superiori è rigorosamente vietato intromettersi nelle cause spettanti al Santo Uffizio (Can. 198 §1). Salvo tuttavia il diritto dell’Ordinario, ciò non impedisce che i Superiori stessi, se siano venuti a conoscenza per caso che un loro sottoposto abbia mancato nell’amministrazione del Sacramento della Penitenza, possano e debbano vegliare su di lui, adoperando anche salutari penitenze e ammonirlo e correggerlo e, se sia il caso, rimuoverlo da qualsiasi mansione; potranno anche trasferirlo altrove, se l’Ordinario del luogo non abbia vietato ciò a causa della denuncia ricevuta e a causa dell’inchiesta iniziata.
5. L’Ordinario del luogo può o presiedere di persona a cause di questo tipo, o affidarne l’investigazione ad un altro, vale a dire ad un ecclesiastico autorevole e di età matura, certamente non abitualmente per la totalità di queste cause, ma delegando un documento per ogni singola causa, salvo la disposizione Can. 1613, §1.
6. Sebbene di regola, a causa del segreto, sia prescritto un giudice unico in cause di questo tipo, non è vietato tuttavia che l’Ordinario nei casi più difficili si associ con uno o due assessori consulenti da scegliere fra i sinodali (Can. 1575); o anche che affidi la causa da trattare a tre giudici, ugualmente da scegliere fra i sinodali, con il mandato di procedere collegialmente secondo il Can. 1577.
7. Il promotore di giustizia, il difensore dell’accusato e il notaio, che è necessario che siano sacerdoti autorevoli, di età matura, di integra fama, dottori in diritto canonico o peraltro esperti e conosciuti per ardore di giustizia (Can. 1589), e che non devono trovarsi nei confronti dell’accusato nelle condizioni, sulle quali Can. 1613, sono nominati con nomina scritta dall’Ordinario, promotore di giustizia (che può essere diverso dal Promotore di giustizia della Curia) per tutte quante le cause di questo genere; difensore dell’accusato e notaio (sono nominati) altrettante volte nei singoli casi. Per ultimo non è proibito che l’accusato proponga un difensore benvisto da lui (Can. 1655), che tuttavia sia sacerdote e che deve essere approvato dall’Ordinario.
8. Ogniqualvolta (cosa che è detta negli articoli che lo riguardano) viene richiesto il suo intervento, senza che il promotore di giustizia sia citato, a meno che, anche se non citato non sia in realtà presente, gli atti dovranno essere considerati non validi; se invece, legalmente citato non sarà presente in alcuni atti, gli atti saranno certamente validi, ma in seguito dovranno essere sottoposti al suo esame affinché possa, sia a voce sia per scritto, osservare e proporre tutte quelle cose che abbia giudicato necessarie e opportune (Can. 1587).
9. Al contrario è necessario che il notaio sia presente assolutamente in tutti gli atti, sotto pena di nullità e che li scriva di propria mano o almeno li sottoscriva (Can. 1585 §1). Per la speciale natura di questi processi tuttavia è lecito all’Ordinario dispensare, per cause ragionevoli, dall’intervento del notaio nell’accogliere, come verrà annotato a suo tempo, le denunce e anche nel trattare quelle che definiscono “diligenze” (= accurate investigazioni) e nell’esaminare i testimoni introdotti.
10. Non siano adoperati come aiutanti dei minorenni, se non quelli assolutamente necessari; e questi si scelgano, per quanto si potrà fare, dall’ordine sacerdotale; sempre però siano di provata fedeltà e superiori ad ogni obiezione. Si deve tuttavia osservare che, quando lo richieda la necessità, possono essere nominati per ricoprire alcuni incarichi anche non sottoposti che vivono in territorio lontano o l’Ordinario di quel territorio (Can. 1570, §2): fatte salve sempre le cautele di cui sopra e il Can. 1613.
11. Infatti quello che nel trattare queste cause deve essere curato e osservato in misura più grande è che le medesime si svolgano segretissimamente e che, dopo che siano state determinate e ormai affidate ad esecuzione siano vincolate da un perpetuo silenzio (Instr. del Santo Uffizio, 20 febbraio 1867, n.14); tutti anche presi singolarmente, in qualsiasi modo appartenenti al tribunale, o ammessi a causa del loro incarico alla conoscenza degli avvenimenti sono tenuti a conservare inviolabilmente il segreto strettissimo, che è comunemente definito segreto del Santo Uffizio, sotto pena di incorrere nella scomunica latae sententiae, immediatamente e senza altra dichiarazione, e riservata alla sola persona del Sommo Pontefice, ad esclusione della Sacra Penitenziaria. Gli Ordinari sono vincolati da questa legge ipso iure o dall’importanza del proprio incarico; gli altri aiutanti ex iuramento che sempre debbono prestare prima di cominciare il proprio compito; e sono vincolati anche coloro che sono delegati, interpellati informati in contumacia, ex praecepto nelle lettere di delega, di citazione, di istruzione imponendolo loro con l’espressa menzione del segreto del Santo uffizio.
12. Il premesso giuramento, la formula del quale si trova in Appendice di questa Disposizione (form. A), deve essere prestato (da quelli naturalmente che lo prestano abitualmente, una volta per sempre; da quelli invece che sono assegnati soltanto per un qualche determinato incarico o causa, ogni volta) davanti all’Ordinario o al suo Delegato sopra i Santi Vangeli di Dio (anche dai sacerdoti) e non altrimenti, aggiungendo la promessa di adempiere fedelmente l’incarico, promessa alla quale non si estende la scomunica di cui sopra. Bisogna fare attenzione, da parte di coloro che presiedono queste cause, che nessuno anche fra gli aiutanti sia ammesso alla conoscenza dei fatti, se non nella misura in cui la parte o il compito che egli deve ricoprire lo richieda necessariamente.
13. Debbono prestare sempre il giuramento di conservare il segreto anche gli accusatori, sia i denuncianti che i testimoni; essi però, non sono sottoposti a nessuna censura, a meno che per caso non ne sia stata inflitta loro qualcuna durante l’accusa, la deposizione o l’escussione. L’accusato sia però ammonito pesantemente a mantenere anche lui il segreto con tutti tranne che con il suo difensore, sotto pena di sospensione immediata a divinis in caso di trasgressione.
14. Per quanto attiene la redazione, la lingua, la conferma, la custodia e la eventuale nullità degli atti, si deve osservare quanto è prescritto nei Canoni 1642-43, 379-80-81-82 rispettivamente.
TITOLO PRIMO
RIGUARDO ALLA PRIMA NOTIZIA DEL DELITTO
15. Poiché il delitto di molestie si suole compiere lontano da testimoni, perché non rimanesse nascosto e impunito con inestimabile danno delle anime, è stato necessario costringere il penitente davvero molestato, unico consapevole di quel fatto, a rivelarlo attraverso una denuncia imposta da una legge stabilita. Dunque:
16. «A norma delle Costituzioni Apostoliche e particolarmente della Costituzione di Benedetto XIV Sacramentum Poenitentiae 1 giugno 1741, il penitente deve denunciare entro un mese il sacerdote colpevole del delitto di molestie in confessione, al Vescovo del luogo o alla Sacra Congregazione del Santo Uffizio; e il confessore deve, essendo gravemente impegnata la sua coscienza, ammonire il penitente riguardo a questa responsabilità» (Can. 904).
17. Del resto, secondo il proposito Can. 1935, chiunque fra i fedeli può denunciare il delitto di molestie di cui abbia avuto sicura notizia; anzi l’obbligo della denuncia preme ogniqualvolta che qualcuno sia spinto a ciò dalla stessa legge naturale a causa del pericolo della fede o della religione o a causa di qualche altro male pubblico imminente.
18.” Il fedele invero che abbia tralasciato scientemente di denunciare colui dal quale sia stato molestato contro quanto prescritto dal (citato sopra) Canone 904, incorre in scomunica latae sententiae che non è risparmiata a nessuno, e non deve essere assolto se non dopo che abbia soddisfatto l’obbligo o abbia promesso che lo soddisferà più tardi” (Can. 2368, §2).
19. L’onere della denuncia è personale e deve essere adempiuto regolarmente dalla stessa persona molestata. Ma se venga impedito da gravissime difficoltà che di persona possa portare a termine ciò, allora o per lettera o attraverso un’altra persona benvista da lui, raggiunga il suo Vescovo o la Congregazione del Santo Uffizio o la S. Penitenziaria, dopo aver esposto tutte le circostanze (Instr. Sancti Officii, 20 febbraio 1867, n.7).
20. Le denunce anonime generalmente devono essere trascurate; potranno tuttavia avere un valore di sostegno o offrire occasione ad ulteriori investigazioni, se le specifiche cose aggiunte rendano credibile l’accusa (cfr. Can 1942, §2).
21. L’obbligo di denuncia da parte del penitente molestato non viene meno per la spontanea confessione eventualmente fatta dal confessore autore delle molestie, né per il suo trasferimento, promozione, condanna, presunta correzione e altri motivi di questo genere; viene meno tuttavia per la sua morte.
22. Ogniqualvolta accada che un confessore o un altro ecclesiastico sia deputato a ricevere una qualche denuncia, insieme con l’istruzione riguardante l’acquisizione degli atti in base alla procedura giudiziaria, sia invitato espressamente a trasmettere subito tutto all’ Ordinario o alla persona che lo ha incaricato, senza lasciarne assolutamente in suo possesso modello o traccia.
23. Nel ricevere le denunce si osserverà regolarmente questo ordine: Per prima cosa sia sottoposto al denunciante il giuramento di dire la verità toccando i Ss. Vangeli; sia poi interrogato secondo la formula (Form. E), con l’avvertenza che racconti tutti i fatti e le singole cose riguardanti le molestie che ha subito brevemente e convenientemente, ma chiaramente e distintamente; in nessun modo tuttavia si chieda se sia stato consenziente alla molestia, anzi sia ammonito che non è tenuto a manifestare il consenso eventualmente offerto; le risposte, non solo per quanto attiene alla sostanza, ma anche alle parole del testimone (Can. 1778) siano senza indugio riportate per scritto; sia riletto allora al denunciante il documento con voce chiara e distinta, dopo avergli dato la facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e fare variazioni; si esiga infine la sua firma o, se non sappia o non possa scrivere, il segno di croce; e mentre egli è ancora presente venga aggiunta la firma sottoscritta di colui che riceve (la denuncia) e, se è presente, quella del notaio; e prima che sia congedato, si riferisca, come sopra, il giuramento di conservare il segreto, minacciando, se fosse necessario, la scomunica riservata all’Ordinario del luogo o alla S. Sede (cf. n. 13).
24. E se talvolta, impedendolo gravi ragion sempre da riprodurre negli atti, questa prassi ordinaria non possa essere mantenuta, si permetta che venga omessa una o l’altra delle formule prescritte, fatta salva tuttavia la sostanza. Così se non possa essere prestato il giuramento sopra i SS. Vangeli, potrà essere prestato in altro modo e anche solamente con le parole; se il documento della denuncia non possa essere redatto per scritto senza indugio, potrà essere registrato in tempo e luogo più opportuno da chi lo riceve o da chi fa la denuncia e in seguito essere confermato e firmato dallo stesso denunciante con un giuramento, in presenza di chi lo riceve; se non si possa rileggere il documento stesso al denunciante, si potrà darglielo da leggere.
25. Nei casi più difficili inoltre è permesso anche che la denuncia (previa concessione del denunciante, affinché non sembri che sia violato il sigillo sacramentale) sia ricevuta dal confessore nella stessa sede confessionale. In questo caso, se non possa essere fatto immediatamente, sia scritta a casa dal confessore o dallo stesso denunciante, e in un altro giorno conveniente ad ambedue nella sede confessionale, sia riletta o data da rileggere e sia confermata dal denunciante con un giuramento e la propria firma o il segno di croce (se sia impossibile del tutto apporre queste). Di tutte queste cose tuttavia, come è già stato detto nel paragrafo superiore, deve sempre essere fatta espressa menzione negli atti.
26. Infine, se si imponesse una causa veramente grave e straordinaria, la denuncia potrà essere fatta anche attraverso una relazione scritta dal denunciante, purché tuttavia sia confermata e sottoscritta in seguito con un giuramento davanti all’Ordinario del luogo o al suo delegato e al notaio, se è presente; cosa che deve essere detta ugualmente di una denuncia rozza, per lettera, per esempio, o fatta a voce al di fuori del processo.
27. Una volta ricevuta una denuncia qualsiasi, l’Ordinario è tenuto a sub gravi a comunicarla quanto prima al promotore di giustizia che per scritto deve dichiarare se nel caso specifico ci si trovi davanti a uno specifico delitto di molestia nel senso n.1 oppure no e, se l’Ordinario dissentisse da lui, deve presentarla al Santo Uffizio.
28. Se al contrario l’Ordinario e il promotore di giustizia concordassero, o comunque il promotore di giustizia non facesse ricorso al Santo Uffizio, allora l’Ordinario, se avrà decretato che non è presente lo specifico delitto di molestia, ordini di riporre gli atti nell’archivio segreto o si serva del suo diritto e incarico in rapporto alla natura e alla gravità delle denunce; se però abbia deliberato che è presente (il delitto di molestia), proceda immediatamente all’indagine (cf. Can. 1942, §1).
TITOLO SECONDO
IL PROCESSO
Cap. I - L’Inchiesta
29. Avuta attraverso le denunce la prima notizia del reato di molestia, si deve compiere una speciale inchiesta “per constatare se e su quale fondamento si appoggi l’imputazione” (Can. 1939, §1); e ciò tanto più per il fatto che un delitto di questo tipo, come è stato già detto sopra, è solito essere commesso di nascosto, e testimonianze dirette di questo si possono avere solo raramente, tranne dalla parte lesa.
Aperta l’inchiesta, se il sacerdote denunciato è un Religioso, l’Ordinario potrà impedire che sia trasferito altrove prima della conclusione del processo.
Tre sono i punti ai quali soprattutto tale inchiesta deve tendere, cioè:
a) ai precedenti del denunciato;
b) alla consistenza della denuncia;
c) ad altre persone molestate dallo stesso confessore o comunque al corrente del crimine se alcune, come avviene non di rado, sono citate dal denunciante.
30. Per quanto attiene il primo punto (a), l’Ordinario non appena abbia ricevuto qualche denuncia riguardante il delitto di molestia, se il denunciato, sia che appartenga al clero secolare sia a quello regolare (cf. n.4), abbia la residenza nel suo territorio, indaghi se esistano in archivio altre denunce contro di lui anche riguardanti materia diversa e le riprenda; e se eventualmente avrà soggiornato in altri territori, chieda ai rispettivi Ordinari e, se un religioso, ai superiori regolari, se abbiano qualcosa che lo possa incriminare in qualche modo. E se riceverà questi documenti, li riporti negli atti da accumulare insieme, sia per presentarli insieme al processo, in ragione dell’estensione o della connessione delle cause (cf. Can. 1567), sia per stabilire e valutare la circostanza di recidività, nel senso del Can. 2208.
31. Se invece si tratti della denuncia di qualcuno che non abbia la residenza nel suo territorio, l’Ordinario trasmetta gli atti all’Ordinario dello stesso denunciato o, non essendo conosciuto costui, alla Suprema Congregazione del Santo Uffizio, fatto salvo il diritto di negare al sacerdote denunciato la facoltà di esercitare le mansioni ecclesiastiche nella propria diocesi o quella eventualmente concessa di revocarla, qualora si sia avvicinato o sia tornato ad essa.
32. Per quanto riguarda il secondo punto (b), il peso di ciascuna denuncia, le caratteristiche e le circostanze devono essere valutate accuratamente perché sia chiaro se e quale fede le stesse meritino. Né è sufficiente che ciò sia noto in qualche modo, ma che lo sia in forma certa e giudiziaria; cosa che è solita essere indicata nel foro del Santo Uffizio con la formula “diligentias peragere”.
33. A questo fine non appena l’Ordinario avrà ricevuto una qualche denuncia riguardante il crimine di molestia, o attraverso lui stesso o attraverso il sacerdote specialmente delegato convocherà due testimoni (ben inteso separatamente e con la circospezione conveniente), per quanto si potrà fare, provenienti dal ceto ecclesiastico, ma comunque superiori ad ogni obiezione, che conoscano bene sia il denunciato che il denunciante e li interrogherà, in presenza del notaio (cf, n. 9) che riporti per scritto le domanda e le risposte, con il vincolo della santità del giuramento sul dire la verità sul mantenere il segreto con la minaccia, qualora sembri necessario, di scomunica riservata all’Ordinario del luogo o alla S. Sede (cf. n. 13), sulla vita le abitudini e la pubblica fama sia del denunciato sia del denunciante; se giudichino il denunciante degno di fede; o al contrario capace di mentire, calunniare, spergiurare; e se conoscano una qualche causa di odio, rivalità o inimicizie tra lo stesso denunciante e denunciato.
34. Se le denunce fossero numerose, nulla impedisce che gli stessi testimoni siano adoperati a favore di tutti o all’opposto a favore dei singoli, sempre tuttavia con l’avvertenza che ciascun denunciato e denunciante abbia un testimone.
35. Se non possono essere trovati due testimoni che conoscano ciascuno sia dei denunciati che dei denuncianti o se non possano senza pericolo di scandalo o danno della reputazione essere interrogati su questo e su queste cose, si applichino, come dicono, le diligentiae dimidiatae (Form. H), interrogati evidentemente due testi riguardanti il solo denunciato e altri due riguardanti i soli denuncianti. Tuttavia in questo caso si dovrà prudentemente indagare in altro luogo se i denuncianti abbiano motivi di odio, inimicizia o altro sentimento umano contro il denunciato.
36. Se non possono essere applicate neppure le diligentiae dimidiatae (investigazioni dimezzate?) o perché non si possono trovare testimoni adatti o perché si ha ragione di temere uno scandalo o un danno della reputazione, si potrà supplire, con cautela e prudenza tuttavia, per mezzo di informazioni extragiudiziali riguardanti il denunciato e il denunciante e le loro mutue personali relazioni che devono essere verbalizzate; o anche attraverso prove sussidiarie che rafforzino o infirmino l’accusa.
37. Per quanto riguarda infine il terzo punto (c), se nelle denunce, cosa che avviene non di rado, vengano eventualmente introdotte persone ugualmente molestate o che possano in qualche modo portare testimonianza di questo delitto, anche tutte queste devono essere esaminate e particolarmente con procedura giudiziaria (Form. 1): e per prima cosa devono essere interrogate in senso generale (per generalia), poi per gradi, finché così suggerisca la situazione, arrivando ai fatti particolari (ad particularia), se e come anche esse siano state molestate, o se siano a conoscenza o abbiano sentito dire che altre persone siano state molestate (Instr. del Santo Uffizio, 20 febbraio 1867, n. 9).
38. Bisogna tuttavia usare grandissima circospezione nell’invitare queste persone; infatti non sempre sarà opportuno che esse si radunino nel luogo pubblico della cancelleria, in particolare se debbano essere sottoposte ad esame o ragazze o ammogliate o addette alla servitù; allora sarà più saggio convocarle, in base alla prudente valutazione dell’Ordinario o del giudice, con prudenza o nelle cappelle o altrove (per esempio in sede confessionale) per esaminarle. Se quelle che devono essere esaminate si trovassero o nei monasteri o negli ospedali o nelle pie case delle fanciulle, allora si dovranno chiamare con grande attenzione e in diversi giorni secondo le particolari circostanze (Istr. del Santo Uffizio, 20 luglio 1890).
39. Le cose dette più sopra sul modo di ricevere le denunce, si applichino anche, cambiate le cose da cambiare, all’esame delle persone che sono state indotte.
40. Gli esami di queste persone che hanno ottenuto risultato positivo, dai quali cioè il sacerdote inquisito o un altro risulterà responsabile, si considerino vere e propriamente dette denunce, e su di esse vengano portate a termine tutte le procedure che sono prescritte sulla specificazione del crimine, il recupero dei precedenti e le accurate indagini .
41. Completate tutte queste pratiche, l’Ordinario si metta in comunicazione con il promotore di giustizia affinché veda se tutto si sia svolto secondo le regole oppure no. E se egli al contrario giudicasse che non c’è nulla da obiettare, dichiari chiuso il processo inquisitorio.
Cap. II - Le Ordinazioni canoniche e l’ammonizione del colpevole
42. Chiuso il processo inquisitorio, l’Ordinario, sentito naturalmente il promotore di giustizia, proceda come segue:
a) se constatasse che la denuncia è veramente destituita di ogni fondamento, ordini che ciò sia dichiarato negli atti, e vengano distrutti tutti i documenti dell’accusa;
b) se gli indizi di reato venissero ritenuti vaghi e indeterminati o incerti, ordini che vengano riposti nell’archivio, da riprendere se in seguito si aggiungerà qualche altra cosa;
c) se però gli indizi di reato venissero ritenuti abbastanza gravi ma non ancora sufficienti ad istituire un’azione accusatoria, come in particolare se si abbiano una sola o solo due denunce con regolari investigazioni, ma non rafforzate da alcuna prova sussidiaria (cf. n.36), o anche più denunce, ma con investigazioni incerte o incomplete, si ordini che l’accusato secondo i diversi casi (Form. M) la prima o la seconda volta, sia ammonito paternamente, severamente o molto severamente a norma Can. 2307, dopo avere aggiunto, quando fosse necessario, una esplicita minaccia di processo, sia gravato da qualche altra nuova accusa; e gli atti, come sopra, siano conservati nell’archivio e nel frattempo si vigili sui costumi degli imputati (Can. 1946, §2, n. 2);
d) se infine siano a disposizione argomenti sicuri o almeno probabili per istituire l’accusa, si ordini che l’accusato sia citato e sia assoggettato alle disposizioni.
43. L’ammonizione di cui al numero precedente (c) deve sempre essere fatta segretamente; tuttavia potrà essere fatta anche per lettera o per interposta persona, ma in qualsiasi caso deve risultare prova di essa da qualche documento che deve essere conservato nell’archivio segreto della Curia (cf. Can. 2309, §§ 1 e 5), registrando come il denunciato la abbia accolta.
44. Se dopo la prima ammonizione si aggiungeranno contro lo stesso imputato altre accuse di molestie precedenti la stessa ammonizione, l’Ordinario veda se, secondo il suo parere e la sua coscienza, quella ammonizione si debba ritenere sufficiente o se piuttosto si debba procedere ad una nuova ammonizione o anche ad ulteriori provvedimenti (Ibidem, §6).
45. Contro disposizioni canoniche di questo tipo esiste per l’imputato il diritto di appellarsi al promotore di giustizia e di fare ricorso alla Santa Congregazione del Santo Uffizio entro dieci giorni dalla loro emanazione o notifica. In questo caso si dovranno trasmettere alla medesima S. Congregazione gli atti della causa secondo quanto prescritto nel Can. 1890.
46. Tuttavia le stesse, anche se arrivate a compimento, non estinguono l’azione penale: e perciò, aggiungendosi eventualmente in seguito altre accuse, bisognerà procedere anche riguardo a quei fatti che hanno causato le dette disposizioni canoniche.
Cap. III - Le Disposizioni per gli Accusati
47. Una volta che si abbiano a disposizione argomenti sufficienti per stabilire l’accusa, come è stato detto sopra al n. 42 (d), l’Ordinario, sentito il promotore di giustizia e salvati tutti i provvedimenti, per quanto il tipo particolare di queste cause lo permette, che sono stabiliti nel libro IV, tit. VI, Cap. II del Codice, porti il decreto (Form. O) riguardante l’accusato davanti a sé o al giudice da lui delegato (cf. n.5), citando per i reati a lui contestati quanto si dice comunemente nel foro del S. Uffizio “Reum constitutis subiicere”; curerà solamente che quel provvedimento sia portato a conoscenza dello stesso Accusato secondo la legge prescritta.
48. Il giudice paternamente e dolcemente esorti alla confessione, dopo averlo citato, l’Accusato che compare in giudizio, e se questo accondiscende a queste esortazioni, il giudice, fatto venire il notaio o anche, se lo riterrà più opportuno (cf. n.9), senza l’intervento di questo, riceva la confessione.
49. In questo caso, se la confessione confrontata con gli atti sostanzialmente venga trovata completa, avuto prima il voto del promotore di giustizia da registrare nel verbale, la causa, omessi gli altri atti (vedi cap. IV), potrà essere conclusa con una sentenza definitiva, concessa tuttavia all’Accusato l’opzione di accettare la sentenza stessa o di chiedere lo svolgimento di un regolare processo.
50. Se invece, al contrario, l’Accusato negherà il reato, o farà una confessione sostanzialmente incompleta, o rifiuterà sommariamente, anche in considerazione della confessione, la sentenza emessa, il giudice, in presenza del notaio, gli legga il decreto, di cui al precedente n. 47, e dichiari aperto il procedimento.
51. Aperto il procedimento, il giudice può secondo la disposizione del Canone 1956, dopo avere ascoltato il promotore di giustizia, sospendere completamente dall’esercizio del sacro ministero l’Accusato convenuto o soltanto dall’ascolto delle confessioni sacramentali dei fedeli fino alla conclusione del giudizio. Se però stabilisse eventualmente che egli può incutere timore nei testimoni o subornarli o in altro modo impedire il corso della giustizia, può anche, sentito ugualmente il promotore di giustizia, ordinare che si ritiri in un luogo determinato e lì rimanga sotto una particolare vigilanza (Can. 1957). E contro ambedue i decreti di questo tipo non è concesso ricorso legale (Can. 1958).
52. Dopo questi preliminari, si proceda all’esame dell’Accusato secondo la formula P, con la precauzione più attenta da parte del giudice che non siano svelate le persone degli accusati e soprattutto degli accusanti, e che da parte dell’Accusato non sia violato il sigillo sacramentale in qualunque modo. Anzi se all’Accusato nella foga del discorso sfuggirà qualcosa che sembri sapere di violazione sia diretta che indiretta del medesimo sigillo, il giudice non permetta che ciò sia verbalizzato dal notaio; e se eventualmente è stato sconsideratamente verbalizzato, ordini, non appena se ne accorgerà, di cancellalo completamente. Ma il giudice ricorderà senza dubbio che non è mai lecito obbligare l’Accusato al giuramento di dire la verità (cf. Can. 1744).
53. Completato in ogni parte l’esame dell’accusato e visti e approvati gli atti dal promotore di giustizia, il giudice emetta la sentenza conclusiva nella causa (Can. 1860) e, se per caso sia giudice delegato trasmetta tutti gli atti all’Ordinario.
54. Se eventualmente l’Accusato è contumace, o per motivi veramente gravi le disposizioni non possono essere eseguite nella Curia diocesana, l’Ordinario, riservatosi il diritto di sospendere a divinis l’Accusato, trasferisca tutta la causa al S. Uffizio.
Cap. IV - La discussione della causa, la sentenza definitiva e l’appello
55. L’Ordinario, ricevuti gli atti, a meno che non voglia lui stesso procedere alla sentenza definitiva, sceglierà, per quanto potrà essere fatto, un giudice diverso (cf. n. 5) da quello che ha portato a termine l’indagine o le disposizioni (cf. Can. 1941, §3). Il giudice poi, chiunque egli sia o l’Ordinario o il suo delegato, metta a disposizione del difensore, a suo prudente arbitrio, un periodo di tempo congruo per preparare la difesa e per presentarla in duplice esemplare, uno allo stesso giudice l’altro al promotore di giustizia (cf. Can. 1862-63-64). Il promotore di giustizia, in un tempo che deve essere ugualmente predefinito dal giudice, presenti in forma scritta quella che ora chiamano requisitoria (form. Q) .
56. Infine, frapposto un congruo intervallo di tempo (Can. 1870), in base alla coscienza che si è formata dagli atti e dalle prove (Can. 1869), pronuncerà la sentenza, di condanna definitiva, se certo del reato; o assolutoria, se certo dell’innocenza; o di condono se dubbioso per mancanza di prove.
57. La sentenza scritta secondo le formule annesse a questa Istruzione, munita di decreto di esecuzione (Can. 1918) e in precedenza notificata al promotore di giustizia, dovrà essere solennemente resa nota all’Accusato citato per questo dal giudice nella sessione del tribunale in presenza del notaio. Se però l’Accusato opponendosi alla citazione non comparisse, l’intimazione della sentenza avvenga tramite lettera, raccomandata con ricevuta di ritorno.
58. Sia l’Accusato, se si senta oppresso da questa, sia il promotore di giustizia hanno il diritto di appellarsi contro questa sentenza presso il Supremo Tribunale del Santo Uffizio, secondo quanto prescritto nel Can. 1879 e sgg. entro dieci giorni dalla solenne notifica della stessa; e l’appello di questo tipo è in sospeso, pur rimanendo stabile, se è stata emessa (cf. n. 51) la sospensione dell’Accusato dall’ascolto delle confessioni sacramentali o dall’esercizio del sacro ministero.
59. Una volta sia stato interposto appello con successo, il giudice deve trasmettere un esemplare autentico di tutti gli atti della causa o gli stessi prototipi al Santo Uffizio, quanto più velocemente possibile, dopo avere aggiunto le informazioni che giudicherà necessarie e opportune (Can. 1890).
60. Per quanto attiene al ricorso di nullità, se si presentasse il caso, si osservino esattamente le disposizioni dei Canoni 1892-97; per quanto riguarda l’esecuzione della sentenza, si osservino, in rapporto alla natura di queste cause, le disposizioni dei Canoni 1920-24.
TITOLO TERZO
LE PENE
61. “Colui che abbia commesso … il reato di molestie, sia sospeso dalla celebrazione della Messa e dall’ascolto delle confessioni sacramentali o anche, in ragione della gravità dei reati, sia dichiarato incapace a ricevere le stesse, sia privato di tutti i benefici, le dignità, della voce attiva e passiva, e sia dichiarato inabile a tutte queste cose, e nei casi più gravi sia assoggettato anche alla degradazione”. Così nel Can. 2368 §1 del Codice.
62. Per una giusta applicazione operativa nel decretare le pene in giusta proporzione secondo il Can. 2218, §1, riguardo al reato di molestia, si abbiano davanti agli occhi nello stimare la gravità del reato queste cose, cioè: il numero delle persone molestate e la loro condizione, come se siano minorenni o in particolare consacrate a Dio con voti religiosi; la forma di molestia, soprattutto se unita ad una falsa dottrina o ad un falso misticismo; l’immoralità non solo formale ma anche materiale degli atti commessi e particolarmente la connessione della molestia con altri reati; la continuità della pratica disonesta; la ripetizione del reato; la recidività dopo l’ammonizione; la confermata malizia del molestatore.
63. Si arrivi alla pena massima della degradazione, che per gli accusati Religiosi potrà essere mutata alla riduzione allo stato di converso soltanto quando, esaminati tutti i punti, appaia evidente che il colpevole, immerso nell’abisso della malizia, nell’abuso del sacro ministero, con grande scandalo dei fedeli e rovina delle anime, sia arrivato a tale avventatezza e consuetudine che, parlando da uomini, non rifulga più addirittura quasi nessuna speranza di una sua correzione.
64. Comminate convenientemente le pene, per ottenere un effetto di queste più completo e più sicuro, si dovranno aggiungere nelle cause di questo tipo queste sanzioni supplementari, cioè:
a) A tutti gli accusati riconosciuti colpevoli si aggiungano delle congrue, a misura della colpa, e salutari penitenze, non in sostituzione delle pene propriamente dette nel senso del Canone 2312, §1, ma per loro complemento, e tra queste (cf. Can. 2313) soprattutto gli esercizi spirituali, che devono essere fatti per alcuni giorni in qualche casa religiosa con sospensione dalla celebrazione della Messa, per tutta la loro durata.
b) Ai rei convinti e confessi si imponga inoltre l’abiura, secondo i diversi casi, dal sospetto leggero o forte di eresia, nel quale incorrono i sacerdoti che compiono molestie, o anche dalla eresia formale, se eventualmente il reato di molestia sia unito ad una falsa dottrina.
c) Coloro che sono in pericolo di ricadere, e perciò tanto più i recidivi siano sottomessi a una particolare sorveglianza (Can. 2311).
d) Ogniqualvolta, a prudente giudizio dell’Ordinario, sembri necessario, per correzione del colpevole, per rimuovere la più vicina occasione, o per prevenire lo scandalo, si aggiunga la proibizione o la prescrizione di fermarsi in un luogo fissato. (Can. 2302).
e) Infine, poiché, per quanto ciò sia delineato nella Cost. Sacramentum Poenitentiae, non si può avere mai nessuna regola nel foro esterno, dunque di sigillo sacramentale, alla fine della sentenza di condanna si dia al Colpevole il consiglio che, se per caso avesse assolto il complice, provveda alla sua coscienza attraverso il ricorso alla Sacra Penitenziaria.
65. A norma Can. 2236, §3 tutte queste pene, una volta che siano state applicate per obbligo dal giudice, non possono essere condonate se non dalla Santa Sede attraverso la Sacra Congregazione del Santo Uffizio.
TITOLO QUARTO
LE COMUNICAZIONI UFFICIALI
66. Qualsiasi Ordinario, non appena abbia ricevuto una qualche denuncia riguardante il reato di molestia, non tralasci mai di notificarla al Santo Uffizio. E se per caso si tratti di un sacerdote sia secolare che Religioso, che abbia la residenza in un altro territorio, trasmetta contemporaneamente (come già sopra n. 31 è stato detto) all’Ordinario del luogo, dove il denunciato in atto risiede, o, non essendo conosciuto questo, al S. Uffizio, copia autentica della denuncia, con le investigazioni, nel miglior modo si sia potuto farle, e le opportune dichiarazioni e informazioni.
67. Qualsiasi Ordinario che abbia proceduto secondo legge contro qualche sacerdote molestatore, non tralasci di informare sull’esito della causa la Sacra Congregazione del Santo Uffizio e, se la cosa riguardi un religioso, il suo Superiore Generale.
68. Se un sacerdote condannato per il reato di molestia o anche solamente ammonito trasferisse la sua residenza in un altro territorio, l’Ordinario del luogo da cui proviene informi al più presto l’Ordinario del luogo dove si trasferisce dei suoi precedenti e del suo stato giuridico.
69. In una causa di molestia, se un sacerdote sospeso dall’ascolto delle confessioni sacramentali, ma non dalla sacra predicazione si recasse in un altro territorio per predicare, l’Ordinario di questo territorio sia avvertito dal Prelato di costui, sia secolare che religioso, che non può essere adibito per ricevere le confessioni sacramentali.
70. Tutte queste comunicazioni ufficiali dovranno sempre essere fatte sotto vincolo del segreto del Santo Uffizio; e poiché partecipano soprattutto al comune bene della Chiesa, il precetto di compierle obbliga sub gravi.
TITOLO QUINTO
IL DELITTO PEGGIORE
71. Con il nome di “peggiore dei delitti” si intende qui qualsiasi atto osceno esterno, gravemente peccaminoso, compiuto o tentato in qualsiasi modo da un membro del clero con una persona del proprio sesso.
72. Quanto è stato stabilito fin qui sul reato di molestia, valga anche, cambiate necessariamente le cose che devono essere cambiate in rapporto alla natura dell’accaduto, per il peggiore delitto, se per caso avvenga che un membro del clero sia accusato di ciò (che Dio non voglia), essendo stato imposto l’obbligo di denuncia secondo la legge imposta della Chiesa, a meno che la cosa non vada congiunta anche con il delitto di molestia durante la confessione sacramentale. Nelle pene da decretare contro colpevoli di questa fatta, oltre alle cose che si trovano dette sopra, si tenga davanti agli occhi il Canone 2359, §2.
73. Al peggiore delitto va equiparato, per gli effetti penali, qualsiasi azione oscena esterna, gravemente peccaminosa, compiuta da un membro del clero in qualsiasi modo, o tentata, con ragazzi di ciascun sesso o con animali bruti (s). bestialitas.
74. Contro membri del clero accusati di questi reati, se siano Religiosi exempti e se non coincida insieme il reato di molestie, possono procedere, secondo i ss. Canoni e le proprie Costituzioni anche i Superiori Regolari, in maniera sia amministrativa che giudiziaria; essi tuttavia devono sempre comunicare la sentenza emessa e la decisione amministrativa nei casi più gravi alla Suprema Congregazione del Santo Uffizio. I Superiori Religiosi non exempti però possono procedere soltanto con misura amministrativa. In caso di espulsione dell’accusato dalla religione, l’espulsione sarà priva di effetto fino a che non sarà approvata dal S. Uffizio.
DALL’UDIENZA DEL SANTISSIMO DEL 16 MARZO 1962
Il nostro Sommo Signore Giovanni Papa XXIII nell’udienza concessa all’Eminentissimo Cardinale Segretario del S. Uffizio il giorno 16 marzo 1962, si è degnato di approvare e confermare questa Disposizione, affidando a quelli ai quali spetta che la mantengano e la facciano mantenere.
Roma, 16 marzo 1962, ex Aed. S. C.
Loco X Sigilli
A. Card. Ottaviani
* * * * * * * * * * * * * * * * *