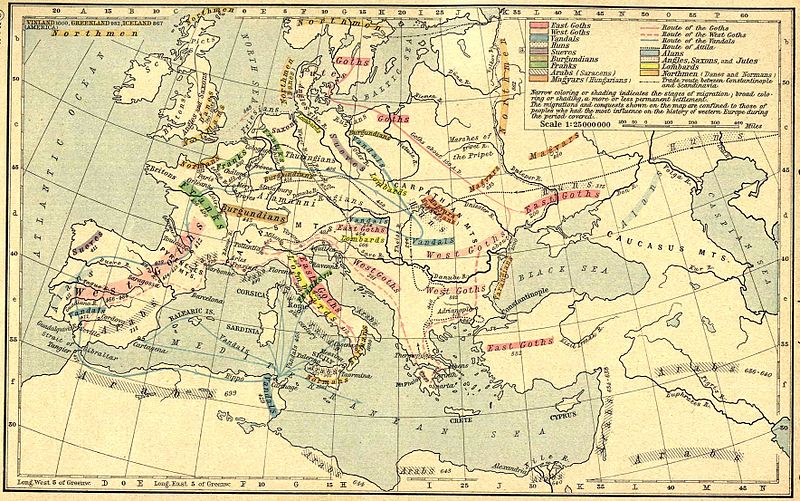
Il ventennio che va dal sacco di Roma da parte del re vandalo Genserico (455) alla deposizione dell'ultimo imperatore romano d'occidente, Romolo Augusto, da parte del generale barbaro Odoacre (476) è uno dei più convulsi e drammatici nell'intera storia d'Europa. Mentre i popolo germanici continuano a strappare lembi sempre più vasti dell'Impero per fondare i nuovi regni romano-barbarici, in Italia i sempre più potenti generali, di stirpe germanica anch'essi, fanno e disfano gli ultimi fantasmi di sovrani, dopo che l'estinzione della dinastia di Teodosio ha aperto una crisi nella successione che non verrà mai più superata. Tra essi spicca la figura di Ricimero, vero burattinaio di quest'ultimo scorcio di vita dell'Impero Romano, che restando nell'ombra manovra spregiudicatamente degli effimeri sovrani-fantoccio.
1. AVITO

Dopo la partenza dei Vandali da Roma l'Impero d'Occidente, o meglio l'Italia con gli sparsi frammenti del suo antico dominio in Gallia, in Spagna e nel Norico, spezzato l'ultimo anello della continuità dinastica dei Teodosidi, rimase passivamente in attesa che la più potente delle nazioni barbariche decidesse il suo destino.
Dopo la repentina scomparsa degli Unni dalla storia europea, due popoli erano in condizione di disputarsi il protettorato sull'Impero, i Vandali e i Visigoti; ma Genserico, con l'orrendo saccheggio compiuto a Roma per ben due settimane, si era tagliato con le proprie mani la possibilità di far eleggere Augusto un proprio candidato. Egli ben sapeva che un erede di suo figlio Unnerico e della figlia maggiore di Valentiniano III, Eudocia, non avrebbe mai potuto ambire al titolo imperiale, in quanto per metà di sangue germanico. Perciò meditava di sostenere quale candidato lo sposo della figlia minore di Valentiniano III ed Eudossia, Placidia, il nobile Anicio Olbrio; ma la partenza del re vandalo da Roma, come un volgare malfattore, dopo un saccheggio spietato rivelava la coscienza della irrealizzabilità di una simile impresa.
A Tolosa il nuovo re dei Visigoti, che era giunto al trono dopo l'assassinio di suo fratello Torrismondo, era adesso Teodorico II, che aveva impresso una svolta all'indirizzo della politica estera del proprio regno, adottando un atteggiamento molto più conciliante verso l'Impero Romano.
La morte di Massimo e la partenza dei Vandali da Roma sembravano offrirgli l'occasione per instaurare sul trono dell'Occidente un proprio candidato e di prevenire così le analoghe intenzioni di Genserico, ed egli non lasciò passare un momento favorevole. Teodorico decise di sostenere il magister militum delle Gallie, Flavio e Parchio Avito vecchio generale di Ezio, che era stato sempre in stretti rapporti coi Visigoti per aver svolto importanti missioni diplomatiche presso di loro. E con il decisivo appoggio di Teodorico, nell'assemblea annuale delle Sette Province ad Arles, Avito venne acclamato imperatore dai senatori gallici (10 luglio 455).
Il Senato di Roma non aveva avuto alcuna parte nell'elezione di Avito e il popolo italico probabilmente nutriva diffidenza e disprezzo per un magnate gallo che calava nella Penisola sostenuto, oltre che dalle sue truppe "romane", da un forte contingente di Visigoti (autunno 455). Tuttavia Avito non incontrò in Italia senza opposizione, anzi entrato in Roma su invito dello stesso Senato, vi fu riconosciuto ufficialmente ed ascoltò il servile panegirico di suo genero, il poeta Siconio Apollinare, che ne ricevette in compenso una statua di bronzo nel foro di Traiano (1°gennaio 456). Identico riconoscimento avevano ricevuto, prima di lui, il poeta Claudiano al servizio del generale Stilicone, e il poeta Merobaude per i suoi servigi nei confronti del generale Ezio. Scomparso il pericolo Unno e divenuti i Visigoti - per forza di cose - alleati e sostenitori dell'Impero, i primi atti di governo che gli Italici si attendevano da Avito erano i preparativi per una campagna militare contro Genserico, il che rientrava naturalmente anche nei desideri di Teodorico II, al quale andava debitore della porpora. E Avito, condottiero e diplomatico di qualche valore oltre che uomo di cultura, si diede ad allestire la spedizione che avrebbe dovuto mettere al sicuro una volta per tutte le coste della Penisola, ed eliminare l'incombente minaccia vandalica dal Mediterraneo. Ma in Dalmazia il conte Marcellino manteneva un'orgogliosa e ostile indipendenza, in Gallia e in Spagna le province romane erano ridotte a ben poca cosa,e il maggior peso dei preparativi ricadde gravosamente sull'Italia esausta, e già affamata dall'interruzione dei rifornimente di grano dall'Africa. Nell'Urbe desolata dalla carestia, oltre che dal recente saccheggio, il nuovo imperatore si vide così costretto a far ricorso a misure estreme, persino a fondere le statue di bronzo per venderne il metallo, mentre la presenza delle truppe ch'egli aveva condotte con sé aumentava il carico già insopportabile di sofferenze della popolazione, provocando scontento e recriminazioni. Perciò Avito non si trattenne a lungo in Roma e fece ritorno in Gallia appena possibile, lasciando in Italia un suo luogotenente, Remisto, in qualità di patricius. In Spagna la situazione stava nuovamente precipitando poiché gli Svevi, dopo la partenza dei Vandali per l'Africa si erano fatti nuovamente aggressivi e dalle loro sedi nella montuosa Gallaecia (Galizia) e nella parte settentrionale della Lusitania fino al Tago, effettuavano continue scorrerie nella Baetica, nella Carthaginiensis e nella Tarraconensis. Ma in tal modo il loro re Rechiario non solo minacciava di distruggere gli ultimi resti del governo romano nella Penisola Iberica, bensì entrava direttamente in urto con suo cognato Teodorico II che non poteva tollerare un pericoloso aumento di potenza dei vecchi nemici dei Visigoti, né esimersi dal sostenere l'imperatore che lui stesso aveva fatto insidiare. Si giunse ad un'aperta rottura fra Svevi e Visgoti e la decisiva battaglia sulle rive del fiume Urbio, in cui la rinascente potenza sveva subì un colpo da cui non si sarebbe mai più ripresa. Rechiario cadde in mano ai suoi avversari poco più tardi e venne messo a morte, ma, mentre Teodorico regolava da vincitore la successione al trono svevo, Avito - nel cui nome egli continuava a proclamare di agire - abbandonato a sé stesso era andato incontro a una fine rapida e improvvisa. Agendo con la consueta tempestività, Genserico aveva prevenuto la spedizione che in Italia si veniva organizzando contro di lui, sferrando una violenta offensiva navale contro le coste della Penisola. La situazione era stata salvata da un valoroso comandante germanico di nome Ricimero, che aveva infllitto loro due decisive sconfitte: davanti ad Agrigento e nelle acque della Corsica, ove sessanta galere vandaliche erano state distrutte e l'immediata minaccia di uno sbarco in Italia, per il monento, sventata (456). Ma Gensierico, benchè sconfitto, proseguiva una distruttiva guerra di corsa sulle coste del Tirreno e dello Ionio; la Sardegna e la Corsica erano già state occupate dai Vandali (455 o 456); la Sicilia e l'Italia meridionale, seriamente minacciate. Le popolazioni italiche vivevano in un continuo stato di apprensione, e Ricimero, orgoglioso delle proprie vittorie, ambiva al supremo comando militare. Egli però era un Germano, Goto per parte di madre e Svevo per parte di padre: era anzi il nipote del re Vallia; e Avito diffidava di lui, tanto più che - per debito di riconoscenza verso Teodorico - gli aveva preferito quale patricius Remisto, che probabilmente era un visigoto. Deluso nelle proprie ambizioni, conscio della propria forza e della debolezza dell'imperatore gallico, Ricimero agì allora di forza: affrontò Remisto e lo sconfisse a Ravenna, poi si volse contro lo stesso Avito che, in tutta fretta, era accorso dalla gallia. Ricimero agiva d'intesa con l'aristocrazia italica, che sperava di trovare in lui un più valido sostegno dei propri interessi economici - ruolo che già era stato di Stilicone e di Ezio , e con il Senato di Roma, che non si era mai realmente rassegnato a subire l'autorità di un imperatore eletto senza il suo consenso da un re barbaro, e sostenuto nell'Urbe stessa dalle armi dei Visigoti. Nella decisiva battaglia, combattuta fra l'esercito di Ricimero e quello dell'imperatore, Avito fu sconfitto (17 ottobre), costretto dal generale vitorioso ad abdicare, e infine ordinato vescovo della città di Piacenza. La vendetta del Senato fu più implacabile di quella del barbaro germano: colpito da una sentenza di morte, Avito fu costretto ad abbandonare il rifugio malsicuro della propria chiesa per tentare di fuggire verso il suo paese natale, oltre le Alpi. La morte lo colse per via, in circostanze oscure (456), e in Gallia non arrivò che il suo cadavere. A questo punto Ricimero, avrebbe avuto aperte innanzi a due strade: quella di scegliersi un imperatore fantoccio, assumere direttamente del potere. In realtà la porpora imperiale, pur nell'estrema decadenza dell'Impero, continuava a restare negata ad un Germano: Ricimero non avrebbe potuto assumere il potere, se non estinguendo formalmente l'ultima parvenza di sovranità imperiale in Occidente - anticipando, cioè, l'iniziativa che Odoacre avrebbe preso vent'anni dopo. Ma una tale possibilità non appariva facilmente realizzabile per Ricimero; egli aveva bensì un esercito ai propri ordini (romano di nome, germanico nei fatti), ma non un popolo; e quei mercenari non manifestavano ancora né il desiderio né l'intenzione di crearsi un regno in Italia. Del resto, l'eliminazione di Avito era stata il frutto di un'alleanza fra lui e il senato, e i tempi non sembravano ancora maturi per scavalcare senza scrupoli quell'antico consesso, che restava tuttora, in mezzo al marasma generale, il più autorevole rappresentante della tradizione romana di governo. D'altra parte la deposizione e la morte di Avito avevano sdegnato l'animo di Teodorico e irritato i bellicosi Visigoti, i quali, se fino a quel momento avevano combattuto gli Svevi in qualità di alleati dell'Impero, ora cominciavano a dare mano alla conquista, per proprio conto, dei territori spagnoli strappati al popolo rivale. Di più: essi ripigliavano l'antica loro politica di espansione verso il cuore dell'Impero, verso il Mediterraneo e l'Italia stessa; e, ritenendosi sciolti dagli obblighi dei precedenti trattati, tornavano a minacciare Arles e Narbona. Sul loro esempio anche i Burgundi, rotti gli angusti confini assegnati loro nella Sapaudia (Savoia), a suo tempo, da Ezio, incominciavano ad allargarsi nella sottostante vallata del Rodano, e s'impadronivano della grande Lugdunum (Lione); mentre i franchi Ripuari, dalle loro sedi sul Reno, conquistavano Trèviri e Colonia. Dal porto di Cartagine la flotta vandalica rinnovava incessantemente le sue spietate scorrerie e l'Italia affamata, priva ora anche dei rifornimenti di grano della Gallia e della Spagna, si aspettava di momento in momento di veder riapparire le galere di Genserico alla foce del Tevere, o davanti a Napoli, a Palermo, a Siracusa. In quei drammatici frangenti Ricimero, prima d iagire di propria iniziativa, avrebbe voluto stringere un accordo con la corte di Costantinopoli, e, sperando di riceverne aiuti, temeva di rompere i ponti dietro di sé con qualche azione che avrebbe potuto alienargli completamente anche l'ultimo potenziale alleato. L'imperatore d'Oriente Marciano, però, non aveva voluto riconoscere né Massimo (l'usurpatore proclamatosi imperatore subito dopo la morte di Valentiniano III), né Avito, e ogni possibilità di accordo con lui sembrava irrealizzabile. Ricimero, tuttavia, seppe agire con grande prudenza e preferì lasciar vacante per sei mesi il trono occidentale, piuttosto che arrischiare una rottura diplomatica con il governo di Costantinopoli. Solo dopo la morte di Marciano (gennaio 457) si decise ad assumere il titolo di patricius (febbraio), sperando che il nuovo sovrano si sarebbe dimostrato più malleabile. Sul trono d'Oriente era salito Leone, una nuova creatura del generale alano Aspar, che svolgeva colà un ruolo simile a quello cui ambiva, in Occidente, lo stesso Ricimero. Con l'elezione di Leone veniva reciso anche l'ultimo legame con la famiglia di Teodosio il Grande, che aveva regnato a Costantinopoli dal lontano 378, quando Valente, fratello di Valentiniano I, era caduto in battaglia contro i Goti ad Adrianopoli. A quel punto fu possibile giungere ad un accordo fra Leone e Ricimero, che nel frattempo aveva nominato secondo magister utriusque militiae il proprio comes domesticorum, Giulio Valerio Maioriano.
2. MAIORIANO
Il patrizio avrebbe voluto designare Maioriano alla porpora e governare egli stesso, di fatto, l'Italia, pur restando nell'ombra, come avevano fatto Stilicone ed Ezio; ma Leone era ancora restio ad accettare il candidato di un barbaro germano come suo collega sul trono dell'Occidente. Lo stesso Maioriano, del resto, si comportava con notevole moderazione e quando, alla fine, le truppe lo acclamarono imperatore (1°aprile), rifiutò, in attesa di un riconoscimento ufficiale da Costantinopoli, che avrebbe suggellato un'alleanza estremamente necessaria all'Italia, minacciata dai Vandali. L'attesa si protraeva, però, da molto tempo e per altri nove mesi sia lui che Ricimero rispettarono gli scrupoli dell'imperatore d'Oriente. Per tutto quel tempo la Penisola rimase senza un'autorità sovrana ben definita; alla fine Maioriano si risolse ad accettare l'acclamazione da parte dell'esercito e del Senato, e indossò la porpora e il diadema (28 dicembre). Il regno di Maioriano (457-61) fu caratterizzato da un attivo ed energico impegno politico-militare, e quasi unanimemente gli storici moderni hanno salutato in questo nobile e sfortunato imperatore l'ultimo degno successore di Augusto, di Traiano e di Marco Aurelio. Se infatti Ricimero si era illuso di potersi servire del proprio candidato come di un docile e sottomesso strumento, rimase ben presto disilluso dal vigore con cui Maioriano si diede a tentar di riorganizzare lo stato in sfacelo. Egli dapprima annullò tutti i tributi arretrati dei provinciali, indi tentò di prevenire futuri abusi abolendo le commissioni straordinarie e riportando l'esazione delle tasse sotto la giurisdizione dei magistrati ordinari. Ma fece ancora di più: rimise in onore l'antica carica dei defensores civitatum, dotandola di ampi poteri per contrastare e combattere l'avidità e la corruzione dei pubblici funzionari. Come della stessa aristocrazia senatoria. Grandi sforzi furono fatti per imporre l'osservanza delle leggi anche ai magistrati provinciali e per ripristinare le curie cittadine, alleviandone al tempo stesso il carico insopportabile delle imposte. Infine, riprendendo e accentuando alcuni aspetti della politica ecclesiastica di Valentiniano III, Maioriano cercò di limitare i privilegi della Chiesa e d'impedire una fuga massiccia dei cittadini dalle responsabilità civili, per rinchiudersi fra le mura silenziose degli innumerevoli conventi, che sorgevano ovunque. Alle vergini desiderose di prendere i voti, fu imposto di attendere l'età minima di quarant'anni; e le vedove, che entro quell'età avessero indugiato più di cinque anni per risposarsi, sarebbero incorse nella perdita della metà dei loro beni. Si trattava, evidentemente, di porre un freno all'accumulo di beni immobili da parte di una chiesa cattolica sempre più potente, mentre i redditi e le proprietà imponibili si riducevano rapidamente a causa, appunto, delle donazioni dei privati a favore del clero. Si trattava, inoltre, di arginare l'impressionante calo demografico, dovuto anche all'aumento smisurato delle vocazioni monastiche e sacerdotali e all'uso, da parte delle matrone dell'aristocrazia, di non sposarsi o, se vedove, di non riprendere marito, per consacrarsi alla verginità pur conservando lo stato laicale - di solito sotto la direzione di qualche religioso; fenomeno che è documentato fin dal tempo di san Girolamo.
Ma la riforma di Maioriano voleva essere morale e di costume, prima ancora che amministrativa e politica: egli si sforzò di far riardere l'antica fiamma della virtù guerriera in un popolo ormai imbelle, e di far sottostare ai doveri sociali anche quanti, in virtù del proprio patrimonio o della carica indegnamente rivestita, avevano dimenticato la comune appartenenza ad una società gravemente minacciata da pericolo interni non meno che esterni. Tutto pervaso dall'ammirazione e dall'entusiasmo perle antiche tradizioni, l'imperatore denunciò l'abbandono degli antichi monumenti di Roma e, peggio, la sistematica distruzione da parte di quanti ne utilizzavano impunemente i materiali di risulta perla costruzione di nuovi e mediocri
edifici privati; e comminò pene severissime per quanti, privati cittadini e pubblici funzionari, avessero proseguito o tollerato tale distruzione indiscriminata del parimonio storico-artistico dell'Urbe.
Maioriano, però, non si nascondeva che qualsiasi tentativo di efficace riorganizzazione interna era destinato a cadere nel vuoto, fino a quando l'Impero avesse continuato a permanere sotto l'incubo dell'invasione vandalica e, da valoroso soldato quale egli era, si apprestò a tale suprema impresa con la massima energia.
Prima, però, era necessario assicurare all'Italia una più vasta fonte di rifornimenti, e quindi riportare all'obbedienza Visigoti, Burgundi e Franchi, e ristabilire l'autorità romana sulle Gallie e sulla Spagna. Maioriano, pertanto, si assicurò la collaborazione del conte Marcellino, inducendolo a portarsi dalla Dalmazia in Sicilia con un esercito di Unni, per sventare un eventuale attacco vandalico contro la grande isola mediterranea. Ciò fatto, egli partì personalmente diretto oltre le Alpi, confermando in una serie di campagne militari il grande talento strategico, già illustrato quando non era che un ufficiale subalterno del grande Ezio. Con l'aiuto di un valoroso generale di nome Egidio, l'imperatore sconfisse i Visigoti rioccupando Arles; poi ricacciò i Burgundi da Lione e, fatta con essi la pace, oltrepassò i Pirenei. In Spagna egli recuperò le province che i Visigoti avevano tolte agli Svevi, senza però restituirle al governo romano, col pretesto della scomparsa di Avito, che essi consideravano il solo legittimo imperatore.
Era tempo di accingersi alla grande impresa africana, i cui preparativi avevano fatto risorgere speranze dimenticate negli animi oppressi degli Italici. Solo a prezzo di grandi sacrifici era stato possibile raccogliere un esercito per l'invasione dell'Africa e, quel che è più notevole, dato lo stato di estrema decadenza ella marina da guerra, una grande flotta di ben 300 galere, senza contare il naviglio minore e quello da trasporto. In un primo tempo Maioriano aveva fondato grandi speranze, per l'impresa vandalica, sul concorso dell'Impero d'Oriente; ma, benché egli avesse fatto subito coniare una moneta che lo raffigurava accanto a Leone, il geloso sovrano di Costantinopoli non si era ancora deciso a riconoscerlo, e perciò nessun aiuto venne offerto all'Occidente per la grande impresa contro Genserico. Maioriano non si perse d'animo per questo, e si avviò ugualmente verso Saragozza (maggio 460), nell'imminenza ormai della spedizione, che avrebbe dovuto coronare gli sforzi tenaci e coraggiosi di due anni e mezzo di lavoro. Ricimero, a dire il vero, non vedeva troppo di buon occhio tutto questo ardore di attività da parte del nuovo imperatore, e se n'era rimasto inattivo e in disparte, senza aver partecipato ad alcuna delle imprese di Maioriano nei paesi transalpini. Ancora una volta l'aristocrazia senatoria, colpita nei propri egoistici interessi dalle leggi inflessibili del nuovo sovrano, si avvicinò all'onnipotente patrizio in vista di un comune interesse a bloccare le riforme avviate. Non è possibile stabilire esattamente come avvenne, e se l'iniziativa proditoria partì da Ricimero, che aveva desiderato un sovrano-fantoiccio e si trovava ora a fare i conti con un personaggio di reale spessore, deciso a esercitare sul serio le funzioni imperiali, o dai senatori preoccupati per le loro proprietà e i loro patrimoni: fatto sta che qualcuno informò proditoriamente Genserico sui preparativi della spedizione africana. La reazione del re dei vandali fu fulminea. Penetrato all'improvviso nel porto di spagnolo di Nova carthago (Cartagena), le sue navi vi sorpresero la flotta tanto faticosamente radunata da Maioriano, e la distrussero quasi interamente (primavera del 460). L'imperatore non si abbattè nemmeno dinnanzi a tanta sventura: conclusa la pace con Genserico, si avviò da solo, senza flotta e senza esercito, verso l'Italia. Ma Ricimero era stanco di quella sua creatura, di cui non si poteva più fidare. Così, quando Maioriano rientrò a di qua delle Alpi, lo fece arrestare a Tortona, in Liguria, il 2 agosto 461; e poco dopo, fattolo condurre a Roma, lo costrinse ad abdicare e subito dopo lo fece decapitare (7 agosto).
3. SEVERO E ANTEMIO
Ricimero aveva appreso la lezione. Il suo successivo candidato che fece eleggere imperatore da un Senato ormai prono ai suoi voleri, fu l'oscuro senatore Libio Severo (19 novembre 461), che nei quattro mesi del suo principato non diede mai alcuna preoccupazione al suo irritabile patrizio. Ricimero non scordava come i servigi di Stilicone e di Ezio fossero stati ricompensati, a suo tempo, da Onorio e da ValentinianoIII, e da allora fino alla sua morte egli continuò a fare e a disfare imperatori secondo il suo volere, contribuendo all'instabilità di un governo che precipitava verso la sua fatale disintegrazione. Ma quegli anni, in cui il patrizio regnò, di fatto, come un sovrano indipendente, furono per lui e per l'Italia tutt'altro che facili: da ogni parte egli si vedeva minacciato sia dai vecchi amici di Maioriano sia dalle incessanti scorrerie piratesche di Genserico. In Gallia, il magister militum del defunto imperatore, Egidio, aveva assunto un atteggiamento ostile e addirittura minaccioso, e preparava una spedizione contro l'Italia; mentre un analogo comportamento assumeva il magister militum della Spagna, Nepoziano. Per sventare il pericolo, Ricimero non esitò a stringere accordi con i barbari che di recente avevano combattuto l'Impero, e a sacrificare ciò che il valore e l'abilità di Maioriano erano riusciti a recuperare. Mediante l'alleanza di Ricimero con Visigoti e Burgundi, tanto Egidio che Nepoziano vennero eliminati, e sostituiti rispettivamente dallo stesso re burgundo Gundiuc, e da un candidato di Teodorico, Arborio. Il prezzo di questa operazione fu, probabilmente, la cessione di Lione ai Burgundi e di altri territori ai Visigoti. Ma non basta: Teodorico non si accontentò dei territori cedutigli, ma riuscì a impadronirsi - col tradimento – anche dell'ambitissima Narbona, assicurandosi finalmente lo sbocco sulla costa del Mediterraneo. Nemmeno il conte Marcellino aveva voluto riconoscere Severo dopo l'esecuzione di Maioriano - questa fedeltà alle persone fisiche anziché al concetto astratto di Stato reca già in sé qualcosa di medioevale, di feudale - , nella Sicilia ove si era portato in vista della guerra vandalica. Ricimero, che sapeva usare l'arma della corruzione altrettanto bene della spada, non potendo affrontarlo apertamente istigò una sedizione fra gli Unni che Marcellino aveva condotto con sé, come esercito personale. Quest'ultimo però non si lasciò catturare, ma imbarcandosi in fretta riuscì a rientrare nella sua Dalmazia, ch'egli governava ormai come una sorta di dominio privato. Di là si diede ad arruolare un nuovo esercito, con il quale contava d'invadere l'Italia e regolare una volta per tutte la partita col suo subdolo avversario. Ad aggravare le difficoltà di Ricimero, i Vandali continuavano ad aumentare la pressione sulle coste italiche con la loro flotta ormai padrona del mare. In effetti, Genserico aveva adesso un obiettivo preciso, che andava al di là del puro e semplice saccheggio delle coste e del naviglio dell'Impero d'Occidente: quello di imporre sul trono di Ravenna un suo personale candidato, il genero Anicio Olibrio, così come Teodorico aveva imposto, qualche anno prima, Avito. Minacciato sia dalla parte della Dalmazia, sia da quella di Cartagine, Ricimero non sembrava in gradi di fronteggiare due avversari contemporaneamente. Egli cercò allora di riavvicinarsi al sovrano di Costantinopoli, che - dal suo canto - fin dal 462 si era adattato a stipulare la pace con i Vandali. Leone, in realtà, riuscì a convincere Marcellino a non muovere contro l'Italia; ma quanto a Genserico, in cambio di un concreto appoggio contro di lui il sovrano orientale impose a Ricimero di riconoscere sovrano d'occidente un proprio candidato. Ricimero non era in condizioni di rifiutare. Nel 464 era riuscito a fermare e sconfiggere, a Bergamo, un'orda di Alani penetrati da oltre le Alpi, ma la situazione dell'Italia permaneva difficilissima. Così, quando Severo - assai opportunamente - morì, forse di morte naturale, forse avvelenato (15 agosto 465), dopo due anni di trattative Ricimero dovette piegarsi a riconoscere imperatore Procopio Antemio, un lontano discendente del generale ribelle e parente dell'imperatore Giuliano, che inoltre era genero di Marciano, di cui aveva sposato la figlia. Antemio, ex magister militum per Illyricum e console nel 435, era un personaggio molto in vista a Costantinopoli, e il suo arrivo in Italia, alla testa di un forte esercito, dovette rafforzare i dubbi e la diffidenza di Ricimero, che avrebbe preferito un docile strumento come l'insignificante Severo. Antemio, comunque, venne acclamato Augusto dall'esercito e dal Senato di Roma 813 aprile 467), e Ricimero venne rabbonito dalla promessa di matrimonio con la figlia del nuovo imperatore d'Occidente. Poco dopo, mentre Antemio - in collaborazione con Leone- iniziava energici preparativi per la guerra vandalica, il patrizio sposò sua figlia, ancor fanciulla, Alipia, tra grandi feste; e la città di Roma, devastata, spopolata e immiserita, celebrò per l'ultima volta spensierati festeggiamenti, mai come allora più incongrui e surreali. A corte, ancora una volta, la Musa di Sidonio Apollinare esaltò senza arrossire i meriti del nuovo sovrano, come già aveva fatto con quelli di Avito e di Maioriano. Forte dell'appoggio di Costantinopoli e ammonito dalla sorte dei suoi predecessori, Antemio cercò di controbilanciare lo strapotere di Ricimero appoggiandosi sul suo antico avversario, il conte Marcellino, ch'egli aveva condotto in Italia e che, adesso, si risolveva a nominare suo secondo patricius. Ma con ciò inaspriva le sotterranee tensioni con Ricimero e gettava i semi di un'aperta rivalità tra i due generali, che non si erano mai stimati e che adesso (come a suo tempo Ezio e Bonifacio) erano pronti a sfoderare le armi, quando più lo Stato avrebbe avuto bisogno della loro concordia e della loro reciproca cooperazione.
Intanto i preparativi per la spedizione africana procedevano intensamente e i due governi di Ravenna e Costantinopoli, con uno sforzo gigantesco, riuscirono a raccogliere una flotta grandiosa di 1.000 vascelli, e un esercito di ben 100.000 uomini. L'onere di gran lunga maggiore era ricaduto sull'Impero d'Oriente, e così il comando della spedizione fu affidato a Basilisco, fratello dell'imperatrice Verina e quindi cognato di Leone, mentre Marcellino ebbe il comando della flotta occidentale. L'impresa incominciò sotto i migliori auspici. Il prefetto orientale Eraclio, sbarcato sulle coste della Tripolitania, avanzò vittoriosamente in direzione di Cartagine, mentre Marcellino con la sua flotta riconquistava la Sardegna. A completamento di questa complessa manovra strategica, il grosso della squadra di Basilisco approdò a Capo Bon, sbarcandovi l'esercito che si accinse (come ai tempi di Attilio Regolo e dei due Scipioni) ad investire la capitale, Cartagine. L'ora fatale sembrava scoccata per Genserico, ma ancora una volta lo scaltro, abilissimo re dei Vandali seppe uscire con successo da una situazione quasi disperata. Ottenuta una tregua d'armi di cinque giorni, sferrò a tradimento un attacco notturno contro la flotta romana, riuscendo ad incendiarne una gran parte (468). A Basilisco non restò altro da fare che reimbarcarsi con i resti di quella che era stata una delle più poderose flotte mai viste nel Mediterraneo, e far ritorno mestamente a Costantinopoli. Là giunto, dovette cercar rifugio nella chiesa di Santa Sofia allo sdegno dell'imperatore Leone, e solo l'intervento di sua sorella Verina potè salvarlo da un drastico castigo per il suo clamoroso fallimento. Quanto al patrizio Marcellino, questa volta non ebbe lo possibilità di mettersi al sicuro nel suo feudo della Dalmazia: perì in Sicilia, assassinato - si disse - per gli intrighi del suo collega e rivale, l'implacabile Ricimero. Naufragavano così, nello sconforto e nei sospetti più odiosi di tradimento, le grandi speranze che per un momento avevano rianimato l'Italia. È probabile che l'insuccesso di Basilisco fosse dovuto, oltre che a incapacità e, forse, a corruzione, ai maneggi dell'altro potentissimo barbaro che dominava la corte orientale: Aspar, che forse aveva dato segrete istruzioni per sabotare la spedizione africana. In ogni modo, poiché Antemio era giunto in Italia in veste di uomo di fiducia della corte orientale, il fallimento della guerra vandalica si tradusse in un colpo assai duro per il suo prestigio e per la sua credibilità, poiché era sotto gli occhi di tutti il fatto che Costantinopoli non aveva potuto o voluto sostenerlo nel momento decisivo. Orami, tra lui e Ricimero i sospetti si erano convertiti in avversione, l'avversione in odio. Antemio, che definiva con spregio il suo patrizio "un barbaro vestito di pelli" e si lagnava amaramente della sua malafede, nonostante gli avesse dato in sposa la figlia, aveva posto la sua residenza a Roma, mentre Ricimero, che chiamava il suo imperatore "un greculo" e "un Galata eccitabile", si era stabilito a Milano. L'Italia era divisa, di fatto, in due Stati separati e ostili. Anche nelle province transalpine, la politica di restaurazione dell'autorità imperiale perseguita da Antemio era andata incontro a gravi rovesci, indebolendo la posizione dell'Augusto. A Tolosa, il re Teodorico era perito, assassinato dal fratello Eurico, che si era impadronito del trono (466), ripigliando l'antica politica antiromana e di espansione del suo popolo, ai danni delle vicine province della Gallia ancora sottoposte alla sovranità imperiale. Antemio aveva cercato di contenerne la pressione e, mentre suo figlio Ecdicio animava la resistenza della Civitas Arvernorum (Clermont-Ferrand) assediata, l'imperatore aveva assoldato un corpo di 12.000 mercenari bretoni, che, sotto la guida del loro re Riotamo, avevano occupato Bourges, minacciando i Visigoti alle spalle. Ma Eurico disfece i Bretoni in una grande battaglia; i Burgundi, benché alleati di Roma, non si mossero; e a stento il comes Paolo, con le poche truppe romane e con i foederati franchi, riusciva ad impedire ai Visigoti di attraversare la Loira. Sbarrata la strada del settentrione, Eurico tornò a invadere l'Alvernia, e qui dovette affrontare, più che l'esercito romano ormai evanescente, i coraggiosi abitanti di quella regione, che gli opposero una strenua resistenza. Benchè stremati dalla carestia e dalla pestilenza, i provinciali si batterono con indomito valore, animati dall'esempio del nuovo vescovo di Clermont: quel Sidonio Apollinare che, come sembra, valeva di più come pastore del suo gregge nei momenti difficili, che come poeta di corte per tutte le stagioni. Respinti, per il momento, dalla capitale dell'Alvernia, i Visogoti si rifecero tutttavia devastando spietatamente la valle del Rodano, e pemetrando fin nella Provenza. Una eloquente testimonianza dello sfacelo dell'autorità romana in Gallia è data dal processo, intentato a Roma, dai nobili provinciali contro il prefetto del pretorio Arvando, responsabile non solo di abusi nel governo e di aver oppresso il paese, ma anche di alto tradimento nei confronti dello Stato. Gli accusatori di Arvando, infatti, furono addirittura in gradi di esibire una lettera da lui diretta al re dei Visigoti, in cui l'indegno prefetto cercava di distoglierlo dai propositi di pace con "l'imperatore greco" (cioè Antemio), lo esortava ad attaccare i Bretoni e suggeriva una spartizione del paese fra Goti e Burgundi. Pareva una replica, a quattro secoli di distanza, del celeberrimo processo contro Verre, solo che qui le colpe dell'imputato erano ancora più inescusabili, anche se mancava un oratore della forza di Cicerone per inchiodarlo alle sue responsabilità. Riunitosi una delle ultime volte per giudicare una causa riguardante la Gallia, il Senato di Roma emise una sentenza capitale che fu, all'ultimo istante, commutata nella confisca dei beni e nell'esilio. La piaga era però talmente diffusa, che subito dopo i padri coscritti dovettero condannare a morte lo stesso successore di Arvando, Seronato, colpevole di aver stretto accordi coi Visigoti per consegnar loro l'Alvernia, che ancora coraggiosamente si difendeva con le sue sole forze. In Italia, intanto, la tensione fra Antemio e Ricimero si avvicinava al punto di rottura. Ricimero, impotente a difendere le coste della Pensila dalle devastazioni dei Vandali, stava giungendo a un accordo con Geserico, rassegnandosi ad accettare il suo candidato quale futuro sovrano dell'Occidente. La mediazione svolta fra Roma e Milano dal vescovo di Pavia, Epifanio, per iniziativa della nobiltà ligure, fallì; e mentre Ricimero, alla testa del suo esercito, marciava sull'Urbe, giungeva in Italia Olibrio, il marito di Placidia, candidato del re dei Vandali. Occupati i due quartieri di Trastevere, il Vaticano e il Gianicolo, il patrizio pose l'assedio a Roma, ove Antemio resistette con le sue scarse forze e per tre mesi: tre mesi interminabili per la città. Straziata dalla fame e dalla peste. Il re ostrogoto Videmiro, accorso in aiuto del legittimo imperatore, venne sconfitto e ucciso sotto le mura della città; indi le truppe germaniche di Ricimero presero d'assalto la Porta Aureliana e irruppero nell'Urbe incendiando e massacrando (11 luglio 472): era la terza volta in sessantadue anni. Antemio, scoperto mentre cercava di mescolarsi alla folla dei mendicanti davanti alla chiesa di San Crisogono in Trastevere, fu subito ucciso e Olibrio, che fin dall'aprile era stato proclamato imperatore da Ricimero, non esitò ad insediarsi sul trono insanguinato. Questa fu certo un'amara delusione per il sovrano di Costantinopoli, Leone, che probabilmente lo aveva mandato in Italia per rafforzare la posizione del legittimo Augusto, e che vide così malamente tradita la fiducia in lui riposta. In realtà, era da moltissimo tempo che Olibrio, in quanto marito della figlia di Valentiniano III, aspirava a cingersi delle insegne imperiali della pars Occidentis, cui riteneva di aver diritto, e alle quali aveva continuare a pensare sia in Africa, quando era stato ospite prigioniero di Genserico, sia a Costantinopoli. Non voleva capire che mai il protetto del re dei Vandali avrebbe potuto essere accettato dai Romani, né riconosciuto dal governo orientale.
4. OLIBRIO, GLICERIO, GIULIO NEPOTE, ROMOLO AUGUSTO
Il regno di Olibrio fu brevissimo: Roma era devastata dalla peste, e di peste Olibrio moriva meno di quattro mesi dopo (23 ottobre o 2 novembre: ci son giunte due date possibili). Con lui scendeva nella romba l'ultimo, esilissimo elemento di continuità del ramo occidentale della dinastia teodosiana, sebbene, attraverso sua figlia, i discendenti di Teodosio il Grande sopravvivessero a Costantinopoli per altre otto generazioni. Prima di lui era morto il suo creatore, il patrizio Ricimero 819 agosto), formidabile facitore e disfacitore d'imperatori, che - elevando al trono un Augusto dopo l'altro, e sbarazzandosene successivamente - aveva contribuito in misura determinante all'estinzione dell'Impero d'Occidente. Da questo momento in avanti, il processo di dissoluzione si fa ancora più rapido: l'impossibilità di instaurare una stabile dinastia imperiale fa sì che gli ultimi fantasmi d'imperatori siano espressione d'interessi sempre più ristretti, e sempre più incapaci di assumere il controllo della situazione. Dopo la morte di Ricimero, Olibrio aveva nominato patricius il nipote di lui, il burgundo Gundobad, morto anche Olibrio, Gundobad seguì l'esempio dello zio, e anziché assumere egli stesso la porpora, la fece indossare al comes domesticorum Glicerio (5 marzo 473), un uomo piuttosto oscuro, senza dubbio pensando di utilizzarlo come un docile fantoccio, sull'esempio di Ricimero con Libio Severo. Ma da Costantinopoli non venne alcun riconoscimento, anzi Leone, che il 1° giugno aveva scritto al nipote di Marcellino, Giulio Nepote, quale magister militum Dalmatiae, s'indusse poi a riconoscere questi Augusto dell'Occidente sotto le pressioni dell'imperatrice Verina. Giulio Nepote aveva sposato una delle nipoti di Verina, mentre dallo zio Marcellino aveva ereditato un solido potere personale dalla Dalmazia. Adesso egli ottenne da Leone l'autorizzazione a marciare sull'Italia per spodestare Glicerio e assumere l'impero dell'Occidente. Nel frattempo Glicerio era rimasto abbandonato a sé stesso perché Gundobad aveva lasciato l'Italia per andare ad assumere nel proprio paese il trono dei Burgundi, rimasto da poco vacante per la morte di suo padre. Così, quando Nepote sbarcò a Ravenna alla testa di un proprio esercito, non gli rimase altra via di scampo che la fuga (giugno 474). Ma a Portus, presso la foce del Tevere, egli venne catturato e la generosità del suo avversario gli concesse di sostituire la porpora con il pastorale, e lo
ordinò vescovo di Salona in Dalmazia ( 19 o 24 giugno), seguendo l'esempio di Ricimero con Avito diciotto anni prima. Ma nemmeno questa volta giunse da Costantinopoli un riconoscimento ufficiale. Leone era morto il 18 gennaio 474, e senza attendere la decisione del suo successore (e nipote) Leone II, il nuovo sovrano occidentale assunse ufficialmente il diadema (24 giugno 474). Anche il suo regno fu però di brevissima durata e, se vide un parziale successo dei Romani in Gallia con la riconquista di Arles e Marsiglia, la pace stipulata con Eurico attraverso il vescovo di Pavia, Epifanio, sanzionò la cessione dell'Alvernia ai Visigoti, con la città di Clermont-Ferrand. Ormai i Visigoti erano padroni non soltanto di tutta la Spagna tranne la Galizia (ove di nuovo avevano ricacciato gli svevi), ma di tutta la Gallia sud-occidentale fino alla Loira e al Rodano, mentre i Franchi e i Burgundi rafforzavano le loro conquiste nel centro e nel settentrione del Paese. Giulio Nepote aveva nominato patricius un romano della Pannonia, Oreste, lo stesso che era stato segretario di Attila al tempo di Teodosio II, e a lui diede ordine di ricondurre oltre le Alpi il numeroso esercito d'Italia composto da foederati Eruli, Sciri, Rugi e Turcilingi (i reggimenti romani si erano praticamente dissolti), probabilmente con l'intenzione di scioglierlo e rimandare i vari gruppi germanici nei Paesi di provenienza. Ma nell'ultimo esercito barbarico d'Italia, che rifiutava di sciogliersi, scoppiò una sedizione: le truppe marciarono su Ravenna sotto la guida dello stesso Oreste, e Nepote abbandonò la partita, fuggendo per mare nella sua Dalmazia (28 agosto 475). Le truppe barbariche offrirono al loro comandante la corona di re d'Italia, ma
Oreste per qualche ragione preferì invece rivestire della porpora e del diadema il suo figlioletto Romolo, scherzosamente chiamato Augustolo dai soldati per la sua giovane età (31 ottobre). Ma ormai la situazione stava precipitando: l'Impero d'Occidente, praticamente ridotto entro gli angusti confini della Penisola, non era più in grado di stipendiare regolarmente, in denaro o in natura, come si era sempre fatto, un esercito sproporzionato alle sue necessità, e che tuttavia non voleva essere sciolto. Allora le truppe barbariche chiesero a Oreste che fosse permesso loro d'insediarsi su un terzo delle terre italiche, secondo il regime della hospitalitas. Acconsentire a ciò avrebbe significato sanzionare lo stanziamento definitivo di una massa di barbari armati in Italia, come era già avvenuto coi visigoti in Gallia, con la sola differenza che queste truppe non avevano alcuna unità etnica o politica. Oreste, che era pur sempre un Romano, rifiutò, anche per non mettersi in condizione di dover governare sotto l'eterno ricatto della forza militare: voleva essere un novello Ricimero, e non ricoprire il debole ruolo di Giulio Nepote, che lui stesso aveva spodestato. Allora l'esercito gli si ribellò ed elesse proprio re un ufficiale di nome Odoacre, forse scita e figlio di quell'Edeco che era stato ambasciatore di Attila alla corte di Costantinopoli (23 agosto 476). Oreste non fuggì subito, come il suo predecessore, ma tentò di organizzare una resistenza, Fu tutto inutile: assediato in Pavia, venne catturato e la città saccheggiata spietatamente; indi fu condotto a Piacenza e decapitato (28 agosto). Anche suo fratello Paolo, che aveva cercato di guidare una riscossa, venne sconfitto nei pressi di Ravenna, e rimase ucciso sul campo (4 settembre). Tutto si era svolto con tale rapidità, che nel giro di pochi giorni il destino dell'Italia e dell'Impero si era compiuto, e tutto era finito prima ancora che il Senato di Roma o la corte d'Oriente avessero potuto rendersene conto. Odoacre fu relativamente generoso, o piuttosto volle tenere un basso profilo diplomatico per non esasperare possibili reazioni sia interne che esterne: era un capo abile e prudente, e alla forza bruta preferiva le arti della politica. Al piccolo Romolo Augusto, l'ultima larva di sovrano dell'occidente, risparmiò la vita: si limitò a farlo abdicare e, poi, a relegarlo con la sua famiglia in una villa di Lucullo in Campania, presso Napoli, con una pensione annua di 6.000 solidi. Quindi non volle assumere a sua volta la porpora, e compì un gesto da molti studiosi moderni giudicato sensazionale, ma in realtà abbastanza logico e naturale: rimandò a Costantinopoli le insegne imperiali e chiese per sé il titilo di patricius e, di fatto, l'amministrazione dell'Italia. Sul trono d'Oriente il piccolo Leone II era morto fin dall'autunno del 474 e, da allora, governava il solo Zenone, un Isauro scarsamente interessato alle faccende dell'Occidente.
Egli accolse con ambiguità l'ambasceria inviatagli da Odoacre, la quale affermava che un solo imperatore sarebbe bastato, d'ora in poi, all'Oriente e all'Occidente. Zenone non confermò a Odoacre il titolo di patrizio, e rispose anzi che il legittimo imperatore di Ravenna era pur sempre Giulio Nepote. Questi si trovava tuttora in Dalmazia, e proprio in quei giorni gli aveva lui pure inviato un'ambasceria, chiedendo aiuti per rientrare in Italia e riprendere possesso del trono imperiale. Zenone non si compromise con la richiesta di Giulio Nepote, e quanto agli ambasciatori di Odoacre accettò gli ornamenta palatii, assumendo così, teoricamente, la funzione di sovrano unico di tutto l'Impero Romano ma, in pratica, riconoscendo tacitamente il fatto compiuto in Occidente - almeno per il momento. In ogni caso, nel rivolgersi a Odoacre per via epistolare lo gratificò del titolo di patricius, accogliendo così, in pratica, la sua principale richiesta, che legalizzava in qualche modo la sua posizione nei confronti del Senato romano e delle popolazioni italiche.
Ritornati a Ravenna i suoi ambasciatori, Odoacre si accontentò del mezzo riconoscimento strappato a Zenone, che lo qualificava in pratica governatore di una provincia dell'Occidente, l'ultima rimasta, in nome e per conto della suprema autorità di Costantinopoli. Si limitò ad aggiungere al titolo di patricius, nei confronti di Zenone, quello di rex nei confronti della massa eterogenea di barbari, che lo aveva spinto al potere. Non rex di un popolo, perché non era capo di un popolo ma di un esercito composito, e tanto meno rex dell'Italia, che non era divenuta un regno autonomo (almeno de iure), ma continuava a rimanere una provincia dell'Impero Romano, la cui capitale unica era, adesso, Costantinopoli. La posizione giuridica di Odoacre era complicata dal fatto che, in Dalmazia, il penultimo sovrano dell'Occidente - da lui spodestato - era ancor vivo e vegeto, e continuò a rivendicare fino all'ultimo i suoi diritti imperiali. Giulio Nepote visse ancora quattro anni, ma non potè mai organizzare una spedizione contro l'Italia per riprendersi il trono. Dovette anzi guardarsi le spalle dal vescovo Glicerio, l'imperatore che, a sua volta, aveva spodestato nel giugno del 474: incredibile a dirsi, pare che costui continuasse a tramare nell'ombra contro Nepote, magari sognando anche lui di poter rientrare in Italia e far valere i suoi diritti. Si stenta a credere che quell'ombra di sovranità imperiale continuasse a venir bramata ardentemente, persino dopo che si era estinta senza alcuna speranza di ripresa. Alla fine Giulio Nepote fece uccidere Glicerio, ma solo per cadere a sua volta assassinato da due suoi conti (480). Con lui si estingueva, e per sempre, l'ultima teorica vestigia di sovranità dell'Impero di Occidente. Nella Gallia settentrionale, circondato da Visigoti, Burgundi, Alamanni, Franchi e Celti dell'Armorica rimase ancora un relitto isolato di territorio romano sotto il generale Siagrio, che sopravvisse altri dieci anni prima di venir conquistato dal re franco Clodoveo (486). Ma, di fatto, l'Impero di Occidente si era estinto con la deposizione di Romolo Augusto. Se il 476 fu davvero una data decisiva nella storia dell'umanità, è una questione che rimane aperta fra gli studiosi. Su un punto, comunque, sembra esservi accordo: quella del 476 fu, per usare le parole di uno studioso italiano, "la caduta di un Impero senza far rumore".
Articolo di Luigi Caliendo. Tutti i diritti riservati















0 commenti:
Posta un commento